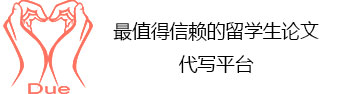服务承诺
 资金托管
资金托管
 原创保证
原创保证
 实力保障
实力保障
 24小时客服
24小时客服
 使命必达
使命必达
51Due提供Essay,Paper,Report,Assignment等学科作业的代写与辅导,同时涵盖Personal Statement,转学申请等留学文书代写。
 51Due将让你达成学业目标
51Due将让你达成学业目标 51Due将让你达成学业目标
51Due将让你达成学业目标 51Due将让你达成学业目标
51Due将让你达成学业目标 51Due将让你达成学业目标
51Due将让你达成学业目标私人订制你的未来职场 世界名企,高端行业岗位等 在新的起点上实现更高水平的发展
 积累工作经验
积累工作经验 多元化文化交流
多元化文化交流 专业实操技能
专业实操技能 建立人际资源圈
建立人际资源圈Il_Ruolo_Della_Donna_Nella_Spagna_Del_900
2013-11-13 来源: 类别: 更多范文
Introduzione
Nel secolo appena trascorso, almeno nel mondo cosiddetto “occidentale”, ha trovato terreno fertile il dibattito sulle tematiche di genere, legate cioè alle differenze derivanti dalla distinzione uomo-donna. Il Novecento in particolare ha visto il susseguirsi di prese di coscienza, manifestazioni, movimenti e nascite di leggi aventi l’obiettivo di evidenziare e tutelare la collocazione delle donne in una società in rapida trasformazione. Tale tematica abbraccia numerosi campi di indagine, che vanno dagli studi culturali, alle tecniche della comunicazione, alla storia, alle scienze sociali. Si è quindi ritenuto estremamente interessante affrontare il tema del ruolo della donna all’interno della realtà spagnola, oltre che per la ricchezza dell’argomento in sé, anche per le sue peculiarità contestuali. Questo paese, infatti, è da pochi decenni uscito da una dittatura durata 40 anni, che ha costituito, sempre in relazione alla posizione femminile nella società, un vero e proprio medioevo, dove qualsiasi tentativo di emancipazione è stato soffocato da una forte ideologia mediante la creazione di un’immagine femminile canonica, l’emanazione di leggi mirate a segregarla ad un ruolo secondario e subalterno rispetto all’uomo e, nei casi peggiori, anche tramite provvedimenti quali il carcere stesso in caso di mancato rispetto di tali leggi o anche di semplice protesta nei confronti delle stesse.
Il presente lavoro comprende quindi una parte introduttiva nella quale verranno illustrate le prospettive di vita che si presentano alla donna spagnola nel contesto del franchismo e del periodo ad esso immediatamente precedente, per passare poi a ripercorrere le leggi emanate in tutto l’arco del ventesimo secolo discriminanti o a tutela del genere femminile, alle reazioni delle donne, tradottesi nei vari movimenti femministi e nelle iniziative ad essi collegati, per terminare in conclusione con l’analisi di alcune opere letterarie considerate particolarmente significative ed emblematiche rispetto all’argomento trattato. Si è scelta tale modalità operativa poiché si ritiene la più funzionale per osservare l’evoluzione della rappresentazione della donna in Spagna. Il canale della letteratura, inoltre, da sempre in bilico fra l’essere lo specchio della società civile e lo strumento istituzionale per arrivare alla società civile stessa, si rivela un’ottima spia della situazione reale, in quanto in esso confluiscono tensioni, timori, sogni ed aspirazioni delle generazioni che gli fanno da cornice. Si intende infine precisare che sono numerose le tipologie questi canali, soprattutto in epoca contemporanea, ma si è ritenuto più funzionale ai fini di un’analisi mirata selezionare solo quello già citato, la letteratura appunto.
La ricerca ha contemplato la consultazione di libri di testo, fra cui saggi, romanzi ed enciclopedie, reperiti in gran parte nelle biblioteche di Scienze Politiche, Lingue, Mediazione Linguistica e Culturale nonché all’Istituto di Lingua Spagnola Cervantes di Milano, dei codici e delle Costituzioni, accessibili in rete e di saggi e ricerche di studiosi autorevoli anch’essi trovati online. Questi passi serviranno ad evidenziare il processo attraverso il quale nello scorso secolo in Spagna si è, da un lato, costruita un’immagine e, dall’altro, avviato e quasi concluso un processo di emancipazione della donna. Nel corso dell’analisi si presenteranno e si commenteranno le posizioni dei vari autori si trarrà, infine, una conclusione su ciò che è emerso.
Capitolo 1
Le radici del presente
1.1 Premesse
Imprescindibile dalla attuale rappresentazione femminile in Spagna è la storia di questo Paese, che merita un’attenzione particolare in quanto geograficamente e di conseguenza anche economicamente e politicamente, piuttosto appartato nei confronti del contesto europeo. Sua peculiarità, in aggiunta, è tutto quel periodo, di ben 40 anni, nel quale ha vissuto sotto una delle dittature più longeve del Novecento: quella del generale Francisco Franco, meglio nota come Franchismo, da alcuni chiamato anche Falangismo, dal nome del partito politico cui fa capo, la Falange, instaurato in Spagna nel 1939 dal generale Francisco Franco e durato fino alla sua morte, nel 1975. Si è deciso di procedere per gradi e di selezionare le fasi più significative del secolo appena trascorso, individuando per ciascuna di esse i fatti storici più significativi e le caratteristiche costituzionali relazionate alla concezione della donna, evidenziando infine il ruolo assegnatole all’interno della società spagnola. Si è inoltre cercato di evidenziare una relazione di causa/effetto tra gli avvenimenti che hanno segnato la storia di questo Paese e i tentativi di affermazione di una figura, quella femminile, spesso collocata in una posizione marginale rispetto ad essa.
In particolare saranno quattro le fasi prese in esame: la dittatura del generale Primo de Rivera, La Seconda Repubblica; il periodo Franchista e la Transizione. Per realizzare tale scopo ci si è avvalsi prevalentemente della guida del testo di Guy Hermet, Storia della Spagna nel Novecento, già affrontato ed approfondito in ambito accademico e quindi considerato altamente attendibile, oltre che ben strutturato. Ciononostante si è ritenuto necessario, per una maggiore obiettività e precisione, ricorrere all’apporto di un altro storico affermato quale Juan Pablo Fusi, una delle voci più autorevoli in merito all’argomento trattato. Si precisa infine che sono numerosissime le fonti relative alla storia spagnola, ma che per ragioni funzionali, non trattandosi nello specifico di un elaborato a carattere storico, si è ricorso solamente a quelle precedentemente citate considerandole esaurienti, complete e riassuntive della conoscenza storica universalmente riconosciuta a livello accademico. Si aggiunge infine a questa analisi anche un approfondimento sugli ultimi anni del diciannovesimo secolo, allo scopo di meglio introdurre le vicende riportate e le premesse che ne hanno condizionato lo svolgimento.
1.2 Il tramonto del secolo XIX e l’alba del secolo XX
1. Il Carlismo e la sua influenza politica all’inizio del secolo scorso
Quando si parla del XX secolo spagnolo è necessario tenere conto che si tratta di un’epoca percorsa sul piano politico ed ideologico da varie correnti di pensiero, alcune, come quelle democratiche e socialiste, sintomo dei cambiamenti politici in corso a livello internazionale, altre più conservatrici e legate alla lunghissima tradizione monarchica e cattolica, peculiarità del Paese. Il Carlismo in particolare è un movimento il cui nome deriva da Carlo Maria Isidoro di Borbone, sovrano spagnolo nel XIX secolo. In questo periodo e più precisamente a partire dal 1883 i suoi sostenitori si adoperano anche militarmente per ottenere il potere e la restaurazione dei suoi successori, dando vita a ben tre differenti guerre carliste. Secondo i carlisti infatti, che si autoproclamano i portatori dei più autentici valori spagnoli, sono solamente i successori di Carlo gli eredi legittimi al trono di Spagna. I valori promossi da tale movimento sono decisamente conservatori, monarchici e cattolici. Una precisa definizione in merito al movimento carlista, è riportata dall’Enciclopedia Universal, secondo la quale esso è una
Doctrina y comunión política que sostiene el derecho alegado por Don Carlos, hermano de Ferdinando VII, y sus discendientes y más proximos parientes varones, para ocupar el trono de España. (…) tiene(n) su programa político y social, formando parte del tradicionalismo político español. (Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana 1989: 990).
Il movimento in questione accompagna, a volte marginalmente ed altre come parte attiva, il percorso politico spagnolo di tutto il secolo scorso, in rappresentanza di una fascia sociale conservatrice e benestante sostenitrice dei valori monarchici e trovando un forte radicamento nei ceti popolari e rurali della Spagna del nord. Durante la Guerra Civile Spagnola i carlisti sostengono i nazionalisti di Franco e per questo, seppur marginalmente, rimangono al governo durante la sua dittatura. Dopo la guerra civile, tuttavia, la presenza di questo movimento è sempre più residuale e a seguito delle prime elezioni rimane un microcosmo esterno alla vita politica del Paese.
2. Morte della Prima Repubblica
Nel 1873, a seguito di forti tensioni interne, l’allora reggente Amedeo di Savoia, salito al potere con un colpo di stato che costringe all’esilio la precedente sovrana Isabella II, si vede costretto ad abdicare: nasce così la Prima Repubblica Spagnola. Al suo interno fioriscono però tanti e tali disordini, alimentati in gran parte dai carlisti internazionali, sostenitori di Isabella e dai federalisti spagnoli che essa verrà rovesciata nemmeno un anno più tardi, nel gennaio 1874, ad opera dei conservatori. Questo colpo di stato, che non è il primo e che sarà solo uno fra i tanti ad animare la travagliata storia di Spagna, avviene mediante due prounciamientos[1] militari. Uno, nel gennaio 1874 è quello di cui sopra, nel quale si dichiara finita la stagione politica precedente e l’altro, datato 29 dicembre 1874 è gestito dal generale Martinez Campos che con l’aiuto del politico Canovas[2], sceglie un sovrano che possa essere facilmente controllabile dal potere militare. Si decide con questi presupposti di consegnare il trono a re Alfonso XII, sostituito alla morte dal successore Alfonso XIII. I golpisti mirano ad un potere esecutivo forte che sia approvato anche dalla nuova classe dominante, composta da borghesia, aristocrazia ed ufficiali dell’esercito, nella speranza che col tempo la rimanente fetta di popolazione accetti la situazione. La classe ricca si ritrova in questa fase della storia spagnola molto unita e la piccola borghesia manifesta una tranquillità maggiore rispetto al periodo precedente, senza dimenticare la Chiesa, ben lieta di poter sostenere nuovamente la monarchia, sua garanzia di privilegio e promozione. Cánovas, la punta di diamante del nuovo potere insediatosi, mediante la Costituzione del 1876 crea un regime bicamerale all’inglese dove le Cortes sono elette a suffragio censitario (escamotage necessario alla legittimazione dell’ordine costituito), il senato è composto da notabili ed il governo è responsabile davanti al re e alle Cortes. Nella fattispecie però, questo sistema si basa sulla complicità tra i leader conservatori e moderati, senza la quale non potrebbe produrre quella parvenza di legalità auspicata da Cánovas. Si tratta quindi di una forma di governo a suffragio ristretto, cioè riservato solamente alla classe più abbiente di una democrazia oligarchica, ben lontana dalla democrazia tout court quasi quanto dall’attuale monarchia costituzionale. Ciononostante il dissenso è talmente diffuso anche tra gli elettori che il partito conservatore si vede costretto, per mantenere il potere, a ricorrere a brogli e a schede fasulle.
Nel 1902 Alfonso XIII diventa re a pieno titolo e contribuisce al degenero della situazione politica, nominando e licenziando voluttuosamente secondo i propri interessi i presidenti del consiglio. Per molto tempo il potere costituito non riesce a superare il logoramento dei partiti e trascura le esigenze e le richieste di buona parte della popolazione civile fra cui gli operai, i repubblicani, gli intellettuali, i catalani e i cattolici. Questa tensione a livello politico attira quindi sul governo una sfiducia anche da parte degli intellettuali in un periodo nel quale tutto il Paese, con in testa Madrid e la sua realtà accademica, sta vivendo una forte rinascita culturale. Non solo, la Chiesa stessa, che da sempre rappresenta uno dei pilastri fondamentali della società spagnola, forse il più potente, si distacca progressivamente dallo Stato. La situazione politica del Paese è piuttosto variegata; al Sud infatti è radicato il partito conservatore e terriero mentre al Nord ha una forte influenza il partito liberale e commerciante; disposizione questa che rispecchia praticamente in senso figurato il profondo allontanamento, nella forma di una forbice che si allarga. La particolarità della Spagna dell’epoca è l’influenza che i notabili al potere hanno sulle masse che rimangono nelle aree rurali, in uno stato di sottomissione e dipendenza di carattere quasi feudale. In sostanza si può quindi sostenere che la forma parlamentare adottata rimane un artificio, una fictio iuris, per via dei clientelismi che ruotano attorno ai Cacicchi[3], i grandi proprietari terrieri latifondisti spagnoli e dei già evidenziati brogli elettorali. Alla lunga però, quando il popolo inizia a dare segnali di intolleranza rispetto ai continui abusi subiti, sorgono al suo interno i primi gruppi di dissidenti, che vedono la rivoluzione e l’anarchia come unica soluzione ad un’ingiustizia sociale sempre meno accettabile. Si registra allora un elevato astensionismo, oltre che madrileno e basco per motivi di carattere regionale, anche in Catalogna, Murcia, Andalusia e Estremadura, divenute centri nevralgici del movimento anarchico. Nasce in questo contesto anche la famigerata “Mano Nera”, organizzazione anarchica praticamente priva di gerarchie che terrorizza e uccide i grandi proprietari andalusi. Dopo vari episodi di violenza e il rifiuto della legalità, gli anarchici spagnoli di inizio secolo capiscono che è meglio puntare sull’attività sindacale e nel 1911 costituiscono la CNT Confederación Nacional del Trabajo, illegale fino al 1914. Nel 1921 nasce infine il Partito Comunista Spagnolo, completando la rosa dei partiti e dei movimenti di sinistra all’opposizione, a sostegno delle masse operaie e contadine. Nel partito conservatore, invece, che governerà il paese anche nel 1921-22, Antonio Maura incarna per qualche anno la parte più modernista. Per concludere si può quindi notare come agli inizi del secolo scorso in Spagna l'oligarchia abbia completamente rinnovato il suo sistema di dominio ed abbia adattato le vecchie forme parlamentari alle nuove condizioni. In sostanza, però, concordando con il punto di vista dell’autore, si nota come essa non abbia mai permesso né alle masse operaie né a quelle popolari di ottenere particolari agevolazioni che le avrebbero spinte a supportarla, creando così tutti i presupposti della creazione di una cornice di stato d'emergenza. Alla luce del diffuso dissenso, dei disordini e dell’instabilità da essi generata, l’oligarchia ottiene come risultato dei suoi stessi inganni ed abusi una vera e propria crisi generale.
3. Miguel Primo de Rivera: dittatura
Figura dall’indubbio carisma e dalle grandi doti militari è il generale Miguel Primo de Rivera. Il generale in data 13 settembre 1923 a Barcellona, mediante un pronunciamento «dichiara di voler salvare il paese dai “politici di professione” e proclama lo scioglimento delle Cortes e del governo» (Hermet 1999:87). Quest’ultimo, non potendo contare nemmeno sull’appoggio del sovrano Alfonso XIII, si vede costretto a dimettersi due giorni più tardi. Conquistato il potere, Primo de Rivera presenta il proprio insediamento come una soluzione transitoria volta a tutelare il cammino verso la democrazia e a proteggere la Costituzione. Nella realtà dei fatti però il dittatore non tarda a costituire un direttorio militare che presiede con le “facoltà di ministro unico”, in netta contrapposizione con i propositi iniziali. Sospende le garanzie costituzionali, instaura lo stato di guerra e revoca i governatori delle province. Egli esercita personalmente il potere legislativo attraverso decreti sottoposti solo formalmente alla firma del re. La posizione del dittatore tuttavia perde stabilità già nell’arco del primo biennio, causa il malcontento generale provocato dalla politica riformista avviata; più di tutto influisce la sua esplicita intenzione di modernizzare l’esercito diminuendo il numero degli ufficiali e mandando in pensione i gerarchi più anziani. Tutto ciò solleva ampi dissensi nel mondo militare, che vive queste idee di ristrutturazione come un tradimento nei propri confronti. Nell’anno 1926, consapevole di una congiura in corso organizzata dai sommi capi dell’esercito e percependo l’avvicinarsi di un pronunciamiento da parte dei suoi avversari politici, il generale stesso dichiara di sottomettersi al volere di coloro che l’hanno sostenuto nell’ascesa al potere e di abbandonare la scena politica qualora il risultato non gli sia favorevole. Si tratta di un’arma a doppio taglio poiché se da un lato questo stratagemma tutela Rivera dal colpo di stato, dall’altro rimette completamente nelle mani dei suoi superiori all’interno dell’esercito la facoltà decisionale circa la legittimità della propria carica. Come ci si può aspettare gli organi chiamati in causa non riescono a trovare un nuovo accordo in appoggio al dittatore, che si ritrova a questo punto costretto a lasciare il Paese. Miguel Primo de Rivera muore a Parigi 6 settimane più tardi (Hermet 1999: 99). Il governo di transizione che segue, a partire dal 30 gennaio 1930, è presieduto dal generale Berenguer, nominato dal re Alfonso XII su suggerimento del dittatore uscente, ed è sostenuto dai militari suoi avversari. Si tratta di una semidittatura dalla brevissima durata, dodici mesi soltanto, osteggiata fin dagli esordi dai partiti di opposizione che con il “patto di San Sebastián” si coalizzano in vista delle future elezioni, la cui necessità è dettata anche dai continui scioperi che oramai si susseguono in tutta la Spagna (Hermet 1999: 101).
2. La Seconda Repubblica
1. La monarchia abbandonata
Alla luce di quanto esposto si può affermare che la breve parentesi di Berenguer nasce e si estingue come una soluzione di transizione che prelude ad un ritorno a nuove elezioni, quindi alla democrazia. Immediatamente successivo a questo sarà il governo dell’ammiraglio Aznar, insignito della più alta carica dello Stato in data 18 Febbraio 1931, con il solo scopo di fissare le date per queste nuove elezioni, unica alternativa all’instabilità politica ed al dissenso diffuso oramai nella maggior parte della popolazione. Il risultato elettorale del 12 Aprile 1931 conferma i repubblicani alla guida di quella che passerà alla storia come la Seconda Repubblica, finalmente proclamata due giorni dopo e che si esaurisce solo cinque anni più tardi. Mediante la legittimazione elettorale quindi, prende forma un nuovo governo presieduto da Niceto Alcalá Zamora, cattolico conservatore. Instauratasi con una spontaneità tale da stupirne i dirigenti repubblicani stessi, la Seconda Repubblica è retta da una coalizione eterogenea, che comprende i repubblicani convinti, gli autonomisti catalani e baschi ed i democratici delusi dal generale Rivera.
L’opinione internazionale e la Chiesa, allora guidata da Papa Pio XI, sono favorevoli al nuovo governo spagnolo che, isolato dalla crisi internazionale che sta affliggendo il Vecchio Continente, si trova in una buona congiuntura anche dal punto di vista economico. Al contrario, i problemi principali si riscontrano a livello politico e sono, almeno in parte, legati agli anarchici che disapprovano il nuovo governo creatosi. Essi alimentano proteste e disordini, soprattutto nelle zone rurali e fra le fasce di popolazione povere e di bassa estrazione sociale. L’estrema destra, inoltre, rende presto manifesto il proprio desiderio di un ritorno alla monarchia, non appoggiando lo sviluppo del modello repubblicano. Ben presto anche i rapporti del governo con la Chiesa, inizialmente in una posizione come precedentemente evidenziato piuttosto favorevole, iniziano ad incrinarsi a cagione di un disegno di legge che prevede per quest’ultima lo stesso trattamento riservato a qualsiasi altro gruppo religioso, in uno Stato laico a modello di quello francese e la sospensione dei fondi statali ad essa destinati. Sicuramente, inoltre, la decisione del Governo di abolire i privilegi fino a quel momento sempre garantiti del clero, attraverso l’espropriazione delle terre ecclesiastiche non aiuta a stemperare la tensione venutasi a creare, la quale anzi precipita di lì a poco in maniera definitiva. A contribuire alla totale rottura intervengono altre decisioni volte a colpire proprio le figure ecclesiastiche, che ovviamente non prendono di buon grado il fatto di non poter percepire più uno stipendio statale, esercitare la professione di insegnanti nelle scuole pubbliche, esibire i propri simboli nei luoghi pubblici e ultimo, ma non per importanza, il vedere declassata la Chiesa alla stregua di un’associazione privata. A lungo andare purtroppo questa tendenza ad allontanare il più possibile dal potere le élites precedenti la seconda repubblica mette questi stessi gruppi, altrimenti disposti a rimanere neutrali, nella condizione di una dichiarata opposizione al governo (Hermet 1999: 109). Il modello di ispirazione francese perseguito dal governo infatti risulta inapplicabile nella penisola iberica, per via della sua lunga tradizione monarchica e della forte e nettamente predominante confessione cattolica dei suoi abitanti, che li rende fedeli innanzitutto di fronte alla Chiesa. Il presidente del consiglio Manuel Azaña, nominato nel 1931, continua tuttavia a difendere a spada tratta i principi contenuti nella nuova Costituzione prendendo provvedimenti che riducono notevolmente lo spazio di autonomia all’interno della società spagnola dei quali hanno goduto sino ad allora Chiesa ed esercito. Nella fattispecie il nuovo governo abolisce l’ordine dei gesuiti, riduce il numero degli ufficiali dell’esercito, elimina l’ora di religione in nome della laicità della scuola e vara una legge sull’aborto: tutti questi provvedimenti mettono in allarme anche la piccola e la media borghesia, prevalentemente di confessione cattolica, oltre che, ovviamente, i militari e le minoranze agiate. Nonostante la buona situazione occupazionale ed industriale, inoltre, gli anarchici continuano a contestare allo Stato il poco interesse rivolto alle tematiche sociali e ben presto iniziano i primi scontri con la Guardia Civil. Tornando all’esercito, infine, la concessione alla Catalogna di un proprio statuto avvelena ulteriormente i suoi rapporti con l’ordine costituito, rappresentando una minaccia all’unità nazionale. Il presidente della repubblica Zamora, prendendo atto di queste forti tensioni, scioglie il governo e indice nuove elezioni nel 1933.
2. Le elezioni del 1933
In occasione delle elezioni la situazione a livello politico si è nel frattempo trasformata, vedendo la nascita di nuove realtà che raccolgono i principali orientamenti formatisi. A partire dal 1932 si crea un nuovo partito a maggioranza cattolica, la Ceda (Confederación española de las derechas autónomas), conservatore per sua stessa ammissione ma fedele alle istituzioni. A tirarne le fila troviamo Gil Robles, presentato da Hermet come
giovane giurista proveniente dall’Azione Cattolica e considerato un simpatizzante del regime mussoliniano (…) troppo carismatico agli occhi dei repubblicani (Hermet 1999: 111).
La Ceda raccoglie la polposa massa dell’elettorato cattolico e in aggiunta, grazie all’estensione del voto avvenuta dopo il 1931 alla popolazione femminile, si vede notevolmente rinforzata anche da quest’ultima. Nonostante vi si adegui, il partito di Gil Robles è piuttosto ostile nei confronti del sistema di governo repubblicano e tra le sue fila vanta la presenza di varie tipologie di simpatizzanti, anche di tendenze piuttosto estreme, fascisti in potenza secondo Hermet (Hermet 1999:113).
Le elezioni del 1933 sono vinte dalla Ceda, con una maggioranza nettamente preponderante sull’amministrazione uscente. L’elettorato infatti, oltre che riconoscersi in larga parte nel nuovo partito, confida nel cambiamento del colore politico del governo quale possibile soluzione verso il miglioramento della situazione sociale. Su un ben differente versante politico intanto, a seguito di questo avvenimento, gli scioperi e la violenza anarchica si intensificano ulteriormente e il partito socialista operaio spagnolo, il Psoe, inizia ad assumere una posizione sempre più vicina al Marxismo, radicalizzandosi nella propria opposizione al nuovo governo. Per questo motivo, cercando di evitare un inasprimento delle tensioni interne, a malincuore Zamora affida il compito di presiedere il nuovo governo al radicale Lerroux, che cercherà di distribuire equamente i ministeri, andando però incontro ad un netto rifiuto da parte degli esponenti della sinistra. Sotto questa nuova formazione vengono ripristinati tutti quei privilegi riservati alla confessione cattolica aboliti solo un paio di anni prima e viene sospesa la riforma agraria avviata dal governo precedente.
3. Sull’orlo della guerra
La situazione del paese continua intanto a precipitare in un susseguirsi di episodi violenti, fra cui la rivolta delle Asturie del 1931, un’insurrezione di differenti forze della sinistra anarchica e comunista asturiana che si pone tra i diversi obiettivi quello dell'abolizione della Costituzione Repubblicana del 1931 e l'instaurazione di un regime socialista. Questa rivolta si posiziona all'interno di un processo più ampio della primavera del 1934 in Spagna conosciuto come Rivoluzione del 1934 e viene sedata nel sangue dall’allora generale Franco e dal suo collega Godet. In tale occasione i minatori della zona carbonifera di Oviedo, nella regione delle Asturie, altamente organizzati a livello sindacale, occupano militarmente le città principali della regione provocando l’ovvio intervento da parte dell’esercito e gli inevitabili scontri che ne nascono. Inizialmente i minatori ottengono in pochi giorni il controllo della regione riuscendo a disarmare la Guardia Civil e proclamano proprio ad Oviedo la Repubblica Socialista Asturiana. Molto si è discusso circa violenza cieca che i minatori avrebbero esercitato sui nemici di classe e in particolar modo su religiosi e uomini di Chiesa. I generali Goded e Franco sono incaricati dal Governo centrale di mettere fine alla rivolta: i due accettano l’incarico a condizione che siano utilizzate le truppe scelte africane, proposta che viene immediatamente accettata dal governo.
Il conflitto si protrae per due settimane, con la facilmente prevedibile vittoria da parte dell’esercito, che ha luogo il 18 ottobre dopo una serie di durissimi scontri. Ciononostante gli insorti subiscono negli anni immediatamente successivi una repressione durissima con numerosi arresti, morti e feriti, tristemente classico copione dell’ascesa dei tiranni, notoriamente accompagnata dall’eliminazione degli avversari politici e dei dissidenti popolari. Proprio in questa circostanza secondo Hermet si crea la spaccatura fra quelli che divengono i due schieramenti in lotta durante la guerra civile spagnola: da un lato buona parte dell’esercito e la destra, dall’altro i partiti politici di sinistra e la classe operaia, che da quel momento adotta una più dura linea di opposizione al governo (Hermet 1999: 117-118).
In un susseguirsi di iniziative controrivoluzionarie delle bande armate falangiste e di non meno feroci rivolte da parte degli anarchici, si arriva infine all’assassinio, il 13 luglio 1936, di Calvo Sotelo, il leader dei monarchici.
1.3.4 Fine della Seconda Repubblica
Chiaramente questo omicidio non è che l’ultimo atto di una tragedia cominciata con la nascita della Seconda Repubblica stessa. Secondo Hermet probabilmente si sarebbe potuta evitare una conclusione tanto drammatica se solo il governo repubblicano avesse realizzato per tempo l’importanza del sostegno da parte d tutta la popolazione. Quest’ultima infatti è composta da una classe conservatrice rappresentata dalla piccola e media borghesia, dal terzo settore operaio e contadino prevalentemente libertario e, infine, dalle classi urbane, che sono invece decisamente repubblicane (Hermet 1999:127). Una volta insediatosi, infatti, il nuovo ordine repubblicano non si preoccupa di darsi una stabilità politica cercando il consenso, ma promuove invece una Costituzione che non tiene conto delle peculiarità e delle esigenze di ciascuno di questi tre macrogruppi, con il risultato di non riuscire nemmeno a rendere effettive le leggi promulgate, poiché non accettate né tanto meno condivise dal Paese stesso. Suddette differenze vengono trascurate in nome di un ideale repubblicano puro, a modello francese. A differenza del paese dal quale si trae ispirazione però, tale modello si rivela di difficile applicabilità, almeno nella sua prima fase di sviluppo, in quanto la realtà spagnola è fortemente cattolica e l’esercito con i suoi ufficiali è ancora in grado, qualora senta messo in dubbio il proprio potere, di rappresentare una reale minaccia all’equilibrio politico.
In particolare i provvedimenti presi contro la Chiesa, nella quale da sempre si riconoscono la borghesia più tradizionalista e una buona parte della popolazione contadina, non aiutano di certo il governo ad attirarsene le simpatie, trasformandone rapidamente la posizione da neutrale ad apertamente in opposizione. Lo stesso vale per gli ufficiali più anziani dell’esercito i quali, vedendosi costretti ad un ritiro anticipato dal proprio ufficio, non tardano ad organizzarsi nell’ordire congiure al fine di un ritorno ad uno Stato di regime, per loro garanzia di maggiori libertà e privilegi. Per quanto riguarda i repubblicani invece, Azaña si trova nella complicata situazione di contenere da un lato i malcontenti di cui sopra e di continuare a promuovere dall’altro le riforme promesse ed avviate, per non scontentare i propri sostenitori. Questo difficile equilibrio crolla completamente nell’ottobre 1934, a soli tre anni dal ritorno alla repubblica, con il rifiuto di Largo Caballero, leader del Psoe, di far parte del patto democratico proposto dalla Ceda, uscita vincitrice dalle elezioni del 1933. Tale vittoria anzi contribuisce all’irrigidirsi delle sue posizioni, tanto da spingerlo a guidare una vera e propria rivolta popolare allo scopo di non riconoscere la legittimità del partito al potere. Questo avvenimento segna la fine di qualsiasi possibilità di una convivenza pacifica e democratica fra le differenti correnti di pensiero sin qui presentate.
Due anni dopo soltanto infatti, fiorisce il sino ad allora nemmeno troppo sommerso reticolato di intrighi e congiure intessuto dai vari generali militari, che segue la tradizione dei pronunciamientos che questa volta ha la voce ed il volto di Francisco Franco.
3. Guerra Civile
Il Generale Francisco Franco non è eccessivamente convinto del buon esito di una rivolta armata. Lo stesso Fusi ricorda infatti che il generale nutre dei seri dubbi circa l’appoggio ad un’eventuale rivolta da parte dell’esercito nella sua totalità e teme la conseguente guerra civile che ne potrebbe nascere. Nonostante ciò con il precipitare della situazione a sfavore dei repubblicani il 18 Luglio 1936 a Santa Cruz de Tenerife egli comunica al paese intero la presa di posizione sua e dei generali insorti, i quali inizialmente pensano che tale azione da sola basti per accaparrarsi il potere e destituire il governo vigente. I fatti immediatamente successivi però dimostrano l’erroneità di tale calcolo, per molti aspetti rivelatosi superficiale e frettoloso. Se infatti è vero che i repubblicani inizialmente non realizzano la pericolosità di questo gesto, o comunque non prendono tutte le misure possibili per sedare l’insurrezione dei generali, è altrettanto vero che i generali stessi non riescono crearsi un appoggio, o perlomeno una neutralità sufficiente fra tutta la popolazione. Si ripropone pertanto l’ennesimo nuovo scenario poco equilibrato che sta alla base di una guerra civile nella quale confluiscono tutte le tensioni accumulate da anni di trascuratezza nei confronti delle reali esigenze del paese. Quello che accade nei giorni immediatamente successivi l’insurrezione dei generali si rivela deludente sia per le aspettative di questi ultimi, che pronosticano un maggiore supporto da parte del mondo politico, sia per quelle del governo, che confida esattamente nella stessa cosa ma in suo favore. Diventa subito chiaro invece che il paese soffre, come conseguenza del golpe de estado di Franco, per una profonda lacerazione interna, la quale produce una guerra civile della durata di 3 interminabili anni. La determinazione di Franco e dei suoi diventa se possibile ancora più manifesta il primo Ottobre dello stesso anno, quando egli si autoproclama capo di Stato, dando inizio, almeno ufficialmente, al regime franchista. I due schieramenti che si vengono a creare sono da un lato quello dei repubblicani, della Guardia Civil, della marina, dell’aeronautica, della popolazione dei grandi centri urbani e, dall’altro, quello dei generali ribelli, con appoggi inizialmente nelle zone più rurali e conservatrici, quali la Navarra, la Vecchia Castiglia, la Galizia, in seguito poi in tutta la fascia centro-orientale del paese, da Cadice a Bilbao (Hermet 1999: 132). Peculiarità di questo conflitto è l’internazionalizzazione che lo contraddistingue. Essa è la conseguenza diretta del meccanismo innestato dalle truppe franchiste che si vedono costrette per esigenze di logistica, allo scopo cioè di richiamare le truppe stanziate in Marocco, a richiedere un supporto aereo e navale ad Italia e Germania, le quali accettano. Nel frattempo il debole governo legittimo non riesce a mantenere il potere, che passa nelle mani dei partiti politici di sinistra, i quali coordinano le forze a loro disposizione, inevitabilmente meno esperte ed organizzate rispetto agli avversari. A questo punto, quindi, anche il governo madrileno ricorre all’aiuto delle potenze straniere, nella fattispecie rivolgendosi alla Francia e all’Unione Sovietica. Ci si ritrova così di fronte ad una svolta fondamentale nella guerra civile Spagnola, quella appunto dell’internazionalizzazione del conflitto. In apparenza praticando una politica di non intervento, sigillata sottoforma di patto a Londra il 9 settembre 1936 fra Inghilterra, Francia, Italia, Germania, Unione Sovietica e Portogallo, in realtà le grandi potenze del Vecchio Continente continuano ad inviare truppe, rifornimenti ed armi ai propri protetti, da una parte e dall’altra degli schieramenti venutisi a creare nella penisola iberica. Dal punto di vista degli stati Europei coinvolti la connotazione di questa guerra prende per molti combattenti tra cui scrittori come Gorge Orwell, tratti romantici ed idealisti, in relazione con il concetto di lotta per la sopravvivenza della democrazia. Inoltre la Spagna, così isolata geograficamente dal resto del continente, si trasforma nel terreno di scontro fra Russia da un lato e Germania ed Italia dall’altro, quindi fra fascisti e comunisti. Piuttosto contraddittoria è invece la posizione degli Stati Uniti, che si dichiarano solidale con la parte repubblicana, ma che nel proprio paese hanno grandi interessi economici con i ricchi imprenditori Spagnoli, di inclinazione palesemente franchista. Altrettanto contraddittoria è infine anche la posizione dell’Inghilterra e della Francia, che vorrebbero rimanere in un clima di neutralità ben consapevoli però dell’impossibilità di tale proposito.
A livello strategico i repubblicani soffrono per tutta la durata del conflitto del controllo navale da parte delle potenze dell’asse Roma-Berlino sulla costa mediterranea spagnola che rendono estremamente lunghe e faticose le manovre della flotta sovietica. Inoltre, un altro punto di svantaggio sempre per i repubblicani è la modalità di rimborso agli altri paesi di fronte agli aiuti internazionali: mentre Italia e Germania concedono dei crediti con la previsione di un risarcimento graduale a guerra finita, essi devono invece pagare in contanti quanto ricevuto. Altri due aspetti decisamente negativi sempre per i repubblicani, infine, sono la netta inferiorità numerica, soprattutto in riferimento ai rinforzi provenienti dall’estero e la necessità di un addestramento che sicuramente non è fra le necessità più incombenti dei generali insorti, per definizione esperti in tematiche militari. Nonostante questa mancanza di equilibrio piuttosto marcata fra le parti il conflitto si protrae per ben tre anni, provocando numerose perdite sia militari che civili. La sua risoluzione avviene solamente nel 1939, con la vittoria finale dell’esercito nazionalista, a seguito della decisiva battaglia sull’Ebro e del ritiro delle truppe Russe, richiamate in patria per far fronte alla sempre più tangibile ipotesi di un conflitto su scala mondiale.
1.5 Il Franchismo
1.5.1 Francisco Franco
La vittoria di Franco sta a significare per la Spagna l’inizio di un quarantennio di dittatura che data la durata va a caratterizzare e modellare profondamente l’apparato burocratico ed amministrativo del paese, nonché l’economia, lo stile di vita e la produzione culturale di quegli anni.
Il personaggio dal quale prende il nome questa epoca si presenta inizialmente come un giovane ufficiale di origini non altolocate. Egli nasce nel 1892 a El Ferrol, secondogenito di 4 fratelli di una famiglia della classe media con forti legami con la marina spagnola. La sua carriera militare, che ha inizio con l’iscrizione alla Accademia di Toledo, è così rapida e brillante che a soli 33 anni Franco è già generale di brigata. L’Africa costituisce una tappa importante nella sua formazione militare, ragione per la quale spesso Franco viene anche definito Africanista: in essa trascorre infatti ben 14 anni, durante i quali ricopre varie cariche conquistando riconoscimenti e medaglie. In particolare è molto importante il suo contributo, sotto la guida del generale Sanjurjo, nel sedare le insurrezioni delle zone marocchine di dominio spagnolo. Una volta tornato in patria, nel 1926, Franco continua a rivestire svariati ruoli di prestigio all’interno dell’esercito, da direttore dell’accademia Generale Militare a capo dello Stato Maggiore Centrale, a comandante generale delle Canarie. (Fusi 1995: 34-37). La dedizione del futuro Caudillo nei confronti dell’esercito si riflette inevitabilmente anche nella sua visione politica, piuttosto conservatrice e nella quale le milizie occupano un posto di grande rilievo. A tale proposito scrive Fusi:
Al hilo de esa doble condición (militar y africanista), Franco asumiría un puñado de convicciones firmes y esenciales que no lo abandonarían jamás. Por lo meno éstas: 1) una teoría nacional-militarista que hacía del Ejercito la encarnación del patriotismo y la garantía última de la unidad nacional, en un contexto en el que la monarquía liberal de 1876-1923 se identificaba con la decadencia histórica de España puesta de manifiesto en la derrota de 1898 frente a Estados Unidos; 2) la creencia de que la acción militar en Marruecos devolvería al Ejercito el prestigio perdido en 1898 y revitalizaría los ideales del patriotismo español; 3) la convicción de que la historia española legitimaba el intervencionismo militar en defensa del orden nacional y como salvaguardia última de la «supervivencia de la patria» (Fusi 1995: 38).
Secondo lo storico, l’esercito rappresenta dunque per il generale la vera spina dorsale dello Stato, l’ultimo baluardo per la difesa dei veri valori Spagnoli, contro lo sfacelo apportato dalla svolta repubblicana. Emerge una figura dai tratti fortemente patriottici, che si investe nella missione della salvaguardia dei valori tradizionali e che non crede nella democrazia. La sua posizione nelle vicende politiche del paese tuttavia rimane piuttosto marginale per parecchio tempo, essendo la sua opinione circa la gestione della cosa pubblica da parte dei governi allora in carica decisamente critica e negativa. Nella fattispecie, Franco disprezza il liberalismo e accusa la monarchia di essere la causa della perdita di Cuba, Porto Rico e Filippine. Il generale rimane comunque leale, fino al colpo di stato del 1936 che lo vede coinvolto, al potere costituito, servendo tanto Primo de Rivera quanto la Seconda Repubblica (Fusi 1995: 40-41).
La cospirazione che porta Franco al potere nasce dal desiderio di alcuni generali dell’esercito, in particolare Mola, Varela, Kindelán, di preparare, nel caso si rivelasse strettamente necessario, un movimento militare (Fusi 1995: 25) con l’obiettivo di tutelare gli interessi e gli ideali dei militari. Il secondo governo repubblicano, quello che va dal 1931 al 1936 rappresenta quindi con le sua tendenza all’innovazione ed al ridimensionamento del potere militare, una grave minaccia per l’esercito stesso, spingendo gli ormai congiurati a mettere in moto l’orchestrazione per il colpo di stato del 1936. L’assassinio di Calvo Sotelo, lider dell’opposizione, avvenuto il 13 luglio dello stesso anno, rappresenta il punto di non ritorno di questo processo ormai in atto; solamente cinque giorni dopo, infatti, il generale annuncia ufficialmente da Las Palmas la sollevazione del movimento militare cui appartiene, aprendo le porte alla Guerra Civile e dando inizio all’era franchista.
Da questo momento Franco riversa anche nel regime la durezza e la massima disciplina che da sempre riserva ai suoi sottoposti, comportandosi con una freddezza e con una crudeltà estreme. Fra i più tragici esempi di tale efferatezza, che diviene caratteristica soprattutto dei primi anni del regime, al termine cioè della Guerra Civile, è l’abitudine del Caudillo[4] di farsi recapitare le domande di grazia degli avversari repubblicani condannati a morte solo una volta portata a termine l’esecuzione, come beffa suprema e chiaro segno di disprezzo nei loro confronti. Nonostante questo ed altri picchi di spietatezza, tuttavia, egli sa anche essere un abile manovratore. Franco infatti comprende l’importanza di un sostegno politico solido e che parte dal basso, perciò, facendo ricorso anche al proprio carisma, cerca di non perdere mai totalmente l’approvazione del popolo, evitando così di cedere il potere, una volta terminata la guerra, ad un monarca o ad un governo di transizione (Hermet 1999: 163).
1.5.2 La prima fase della dittatura
Nonostante l’apparenza monolitica del quarantennio franchista, numerosi sono i cambiamenti politici e sociali che lo caratterizzano, distinguibili in varie fasi differenti. Per motivi di semplificazione sono in molti a non ricorrere alla suddivisione in fasi, mentre nel testo a cui si è ricorso ne viene fatto esplicito riferimento lo si riporta in quanto giudicato maggiormente chiarificatore ed esplicativo nei riguardi di quanto accaduto. Prima di esse ovviamente c’è il periodo corrispondente alla Guerra civile, seguita, fino al 1945, dal perpetrarsi della controrivoluzione, cioè della forte repressione contro gli avversari politici, come già accennato nell’esempio precedentemente introdotto, dove il potere assume tratti molto simili a quelli del fascismo. Inoltre le attenzioni di Franco sono rivolte ad annullare qualsiasi traccia della breve parentesi repubblicana. Scrive ancora Hermet (1999):
Si tratta, per quella consistente parte de popolo spagnolo che ha aderito alla Crociata, di farla finita una volta per tutte con la Spagna «rossa» contro la quale ha condotto una guerra senza esclusione di colpi. Un’operazione definitiva, indipendentemente dai dolori e dalle perdite umane che ne sarebbero derivati (Hermet 1999: 165-166).
Da queste parole si deduce come il paese viva in un clima di esaltazione che alimenta le violenze e l’intolleranza verso i repubblicani, i cosiddetti rossi, che vanno a popolare campi di concentramento e prigioni, quando non vengono direttamente fucilati. A giustificazione delle stragi più o meno legalmente compiute si apporta una serie di motivazioni insostenibili, la più ricorrente delle quali per esempio è l’assassinio di José Antonio Primo de Rivera, fondatore e teorico della Falange, nonché figlio del fautore della dittatura precedente, compiuto durante la Guerra civile dalla fazione repubblicana. Scompare in questi anni inoltre buona parte dei professori universitari e del corpo docente, oltre che un alto numero di funzionari che rivestono cariche elevate, tutti sostituiti da membri della falange o da persone ad essa legate, spesso privi delle competenze per rivestire tali ruoli.
Uno degli apporti più interessanti consultati, che riporta copiosa documentazione circa la mentalità del primo periodo del regime, è senza dubbio il testo Usos amorosos de la postguerra española, della scrittrice Carmen Martín Gaite (1987)[5], nel quale narra lo spirito di quegli anni, vissuti da lei in prima persona. Numerosi sono i riferimenti ad una retorica
mesianica y triunfal, empeñada en minimizar las secuelas de aquella catástrofe, entonaba himnos al porvenir. Habían vencido los buenos. Habían quedado redimio el país. Ahora, en la tarea de reconstruirlo moral y materialmente, teníamos que colaborar con orgullo todos los que quisiéramos merecer el nombre de españoles (Martín Gaite 1987:13).
Sin da queste poche righe si ha la percezione di un clima di forzato ottimismo verso il futuro che viene stimolato da parte dell’ordine costituito sicuramente al fine di alleviare il dolore ed il pessimismo conseguenti la durezza degli anni della guerra. In aggiunta però, la motivazione va ricercata soprattutto nella creazione di un clima favorevole al regime, oltre che nell’esigenza di allontanare il più possibile il ricordo della guerra con le sue atrocità. Atrocità queste, perpetrate in gran parte dall’esercito nazionale stesso; l’obiettivo di Franco, inculcando questa nuova attitudine di ritrovata serenità ed armonia, è per l’appunto quello di ripulire la sua immagine agli occhi del paese e di ristabilire l’ordine, essenziale per evitare rischi di sommosse e tentativi di ribaltamento del proprio governo. Sono pertanto riproposti i classici valori tradizionali, condivisi dalla parte conservatrice del paese che peraltro sostiene la falange. Tali valori sono identificabili nella totale esaltazione della patria, dell’onore, dell’orgoglio d’essere spagnoli e quindi portatori di valori e peculiarità nazionali da difendere ed ostentare. A tutto ciò si aggiunge il forte cattolicesimo che già permea la mentalità della popolazione, a prescindere dal colore politico, il quale contiene severi precetti morali e rigide norme comportamentali che ben rispondono alle esigenze e all’ideologia del regime. Sono queste le due autorità alle quali il popolo è sottomesso: lo Stato e la Chiesa. La Gaite sottolinea come il regime promuova in quegli anni come chiave di lettura la vittoria dei buoni, ossia dei Nazionalisti e che sia arrivato il momento in cui con impegno e buona volontà è necessario ricostruire il paese. Le parole chiave degli anni immediatamente successivi la Guerra Civile sono restrizione e razionamento: si tratta di risparmiare, di mettere da parte quanto più possibile e di adoperarsi con duro lavoro e sacrifici alla rinascita della Spagna dalle macerie post-belliche. La popolazione è in ginocchio di fronte alla carenza dei beni primari e dei servizi più elementari quali acqua, luce e carbone, che sono, in questo periodo iniziale, a continuo rischio di esaurimento (Martín Gaite 1987:14).
Un ultimo aspetto che si ritiene opportuno evidenziare di questi anni di dittatura è quello della politica estera (Hermet 1999:183), cruciale per l’indirizzo verso cui muoverà l’ordine costituito. A partire dagli atti finali del secondo conflitto mondiale il Generale tenta infatti un approccio diverso nei confronti degli alleati, preannunciati ormai come vincitori. Ben pochi fra di essi sono a sostegno o non totalmente in disaccordo con il regime Spagnolo e, per la maggior parte, sono circoscritti ai partiti più conservatori, come quello britannico di Winston Churchill. Anche la Chiesa rimane ambigua nei confronti del caso spagnolo, probabilmente per via delle concessioni che ha ottenuto nel Paese grazie a Franco. Gli altri Paesi invece, fra i quali l’Unione Sovietica comunista, la Francia e gli Stati Uniti, si prefiggono l’obiettivo di cancellare qualsiasi residuo di ordine fascista o nazional-socialista presente nel vecchio continente, perciò manifestano apertamente la propria opposizione al regime instauratosi nella penisola Iberica. L’Organizzazione delle nazioni unite, infine, non consente l’accesso alla Spagna al proprio interno, bandendola ufficialmente nel 1945. Essa si ritrova quindi, nel 1947, ad avere come unico alleato il generale argentino Perón, che le garantisce mediante accordi economici i rifornimenti necessari alla sopravvivenza. Questo nuovo clima di interesse internazionale verso la situazione spagnola spinge molti esuli repubblicani ad organizzarsi per un rientro in patria e va ad aggiungersi ad un disaccordo crescente da parte dell’opinione pubblica del Paese medesimo.
3. Seconda fase: manovre di assestamento del regime
Considerando l’isolamento sul piano internazionale e le pressioni interne il franchismo giunge ad una terza fase, circoscrivibile fra il 1945 ed il 1956, nella quale il generale riesce innanzitutto a sfruttare la situazione internazionale ostile convincendo gran parte degli spagnoli che le potenze che l’hanno esclusa abbiano compiuto un grave smacco nei suoi confronti. In secondo luogo, il Caudillo intraprende una politica volta ad attenuare il carattere repressivo e le inclinazioni di matrice fascista presenti sino ad allora nella gestione della cosa pubblica, affidandone le cariche più alte a persone esterne alla Falange. Nella fattispecie Franco si rivolge ai cattolici, nominando nel 1945 il ministro degli esteri Artajo, proveniente dall’Acnp, un’associazione cattolica nata nel contesto universitario. Negli anni seguenti, fino al 1956-57, anche le altre alte cariche di governo sono nominate in base allo stesso principio di selezione del ministro degli esteri, oltre che molte figure professionali negli ambiti della censura, dell’insegnamento, della propaganda (Hermet 1999:189). La nuova formazione così creatasi lavora alacremente fin da subito per riplasmare l’immagine del regime al potere, con l’intento di dargli una connotazione il più vicina possibile al concetto di democrazia.
Nel frattempo muta nuovamente la congiuntura internazionale e l’America si trova a dover affrontare il periodo di tensione e di giochi politici rappresentato dalla Guerra Fredda[6]. Per questo motivo ha bisogno del maggior numero di alleati possibili e già dal 1947 arrivano i primi segnali distensivi volti ad includere la Spagna nella propria cerchia, in quanto fondamentale, grazie alla propria collocazione geografica, alle strategie militari statunitensi. Le conseguenze del nuovo punto d’angolazione dal quale una delle maggiori potenze sulla scena internazionale guarda alla penisola iberica non si faranno attendere e nell’arco di un quinquennio anche gli altri paesi e le relative organizzazioni quali la Fao, l’Onu e l’Unesco la riammettono a pieno titolo sulla scena internazionale (Hermet 1999:195). La diretta conseguenza di questi fatti è una fiducia crescente per il Caudillo ed il suo governo da parte dei militari suoi sostenitori. Le due forze politiche al governo invece, i cattolici e i falangisti, non riescono a trovare una linea comune e le tensioni fra di essi partoriscono infine una pesante crisi politica, avvenuta nel 1956. Il motivo principale delle tensioni è la contestazione da parte della falange della politica di apertura liberale promossa da Artajo e Giménez, rispettivamente ministri degli esteri e della pubblica istruzione. In special modo il secondo diviene oggetto di attacchi in merito alla conduzione universitaria da lui promossa, che da adito persino a scontri fra gli studenti stessi, falangisti ed antifalangisti. A questo punto la falange provoca una crisi che permette a Franco, abile stratega, di liberarsi di Giménez, deposto dal proprio incarico, indebolendo così i cattolici e ritardando nuovamente il ritorno della monarchia. La crisi consente inoltre al Caudillo di sostituire gradualmente i ministri cattolici e falangisti con una nuova classe politica, prevalentemente proveniente dalle fila dell’Opus Dei.
4. Il governo tecnocratico: terza fase del quarantennio franchista
Il regime vive pertanto una nuova transizione verso una conduzione decisamente più tecnica, tanto da poter essere definita tecnocratica, all’interno della quale maggiore rilievo assume la conduzione economica del paese. Questo per rinforzare la legittimità di un modello di governo che con il passare degli anni, spente le paure provocate dalla Guerra Civile, inizia pian piano ad erodersi. Il nuovo ordine di priorità direziona l’interesse dl regime verso le banche e le grandi aziende multinazionali (Hermet 1999:205), ponendo in secondo piano la retorica ideologica e patriottica, pur non abbandonandola mai completamente. Il Caudillo infatti, si adopera verso questa direzione non tanto per cambiare l’essenza del proprio regime, ma per ottenere ulteriori appoggi anche da altre fasce sociali, sino ad allora trascurate. Bisogna sottolineare che l’immobilismo degli anni precedenti non è più sostenibile ed è necessario un rinnovamento della classe politica dirigente, in grado di garantire un certo equilibrio al governo, libero dalle tensioni invece presenti in passato fra cattolici e falangisti. L’incarico di segretario alla presidenza viene affidato a Carrero Blanco, il quale si avvale per il proprio mandato delle competenze dei ministri Ullastrez e Navarro. Durante la fase iniziale di governo i tecnocrati faticano ad imporsi, costantemente ostacolati dai falangisti che fanno leva sulla condizione dei lavoratori appartenenti ai sindacati, sostenendone gli scioperi sempre più numerosi e significativi, ancora una volta soprattutto nella zona delle Asturie (Hermet 1999:208). Tuttavia queste difficoltà si attenuano a partire dal 1958, con l’ammissione del paese al Fondo Monetario Internazionale e con il piano di stabilizzazione, che viene messo in atto nell’anno successivo. Tale piano prevede una svalutazione della peseta che consente alla Spagna di entrare a far parte anche dell’Ocse, l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, con conseguente ulteriore distensione del clima politico. In un breve lasso di tempo, grazie alle nuove misure adottate in campo economico, la popolazione spagnola migliora notevolmente i propri standard di vita, raggiungendo i livelli di sviluppo degli altri paesi europei. Questo grazie alla decisione presa dai ministri di focalizzare l’attenzione sull’industria e non più sulla campagna. Nell’arco di pochi anni la faccia di diversi centri urbani muta notevolmente, vedendo la creazione di numerose fabbriche, il sorgere di aree industriali e la costruzione di alloggi per i lavoratori, sempre più spesso provenienti dalle campagne. Inoltre, abbandonando la oramai quasi proverbiale reticenza nei confronti degli investimenti stranieri, il governo apre loro le porte incrementando così i fondi già stanziati a livello nazionale. Un ulteriore apporto economico, infine, proviene dall’afflusso turistico degli stranieri, in enorme crescita in questi anni. Il periodo sin qui descritto vede un miglioramento tanto rapido quanto eclatante dell’economia del Paese da essere conosciuto anche come “Miracolo Spagnolo”. Nel 1957 cambiano nuovamente i ministri al potere, con Carrero Blanco, anch’egli membro dell’organizzazione, come vicepresidente del governo. Solamente un punto non soddisfa i ministri, che come già affermato provengono dalle fila dell’Opus Dei: si tratta della loro volontà di un ritorno alla monarchia, che nuovamente viene disatteso. Franco infatti temporeggia, rimandando la questione ogni volta che gli viene sottoposta. Il sempre più incalzante López Rodó, conte di Barcellona e padre del futuro re di Spagna Juan Carlos ottiene infatti solo nel 1969 che il proprio figlio venga designato ufficialmente erede di Franco e “Principe di Spagna”, ma questo traguardo implica comunque una tempistica piuttosto lunga prima di una restaurazione monarchica.
Considerevoli cambiamenti dal punto di vista politico invece provengono da altri settori, rispettivamente cioè dalle opposizioni, dalla Chiesa e dalle minoranze Basche e Catalane. Rifioriscono infatti a partire dal 1962 i movimenti operai, come conseguenza dell’insoddisfazione crescente di buona parte dei lavoratori delle fabbriche, dovuta all’allocazione parziale dei proventi economici da esse dipendenti, come al solito in mano ai pochi e già benestanti appartenenti alle classi medio-alte. Lo Stato si trova così a dover fronteggiare nuove ondate di scioperi, questa volta però guidati da gruppi bene organizzati e non più arginabili, poiché espressione di una parte importante della popolazione del Paese. In secondo luogo anche la Chiesa prende progressivamente ma inesorabilmente le distanze dal regime, andando invece a sostenere i movimenti operai, i cui dirigenti spesso appartengono all’Azione Cattolica (Hermet 1999:224). La scontata evoluzione di tale presa di posizione è quindi l’incarcerazione da parte dello Stato di molti operai cattolici, che a sua volta provoca una crisi profonda fra le due istituzioni, manifestata infine chiaramente nel 1971 all’assemblea dei preti e dei vescovi. Si tratta di una grave perdita per il regime, che fino ad allora ha goduto del prestigio e del sostegno della Chiesa.
L’ultima ma non meno importante area di dissenso ha a che vedere con i nazionalismi Basco e Catalano, storicamente legati alla Chiesa cattolica, sebbene da percorsi differenti. Il primo, che si esprime attraverso il Partito Nazionale Vasco, i cui rappresentanti durante il franchismo sono per lo più in esilio, conserva la propria propensione democristiana, anche se al suo interno stesso si crea una netta divergenza fra chi promuove una rivoluzione armata e chi invece fa appello alla non violenza. Nasce così l’Eta V, frangia estremamente violenta che spesso, facendo ricorso ad attentati ed omicidi, giustifica la dura repressione di quegli anni da parte del regime. Il cattolicesimo catalano invece è esteso a tutta la popolazione per via del processo di secolarizzazione che lo caratterizza ed inoltre le rivendicazioni nazionaliste sono maggiormente tollerate dal governo stesso. A fungere da pomo della discordia in questo caso è il tentativo da parte di Franco di inserire nell’organico delle chiese della Catalogna vescovi e prelati non catalani, bensì provenienti da altre zone della Spagna, che godono della sua fiducia, al contrario di quelli indigeni. Questi ultimi infatti promuovono la necessità di una Catalogna libera e con la propria lingua, sfruttando le reti confessionali come vettore e denunciando l’oppressione del regime. Le contingenze qui sopra esposte costituiscono l’incentivo che convince di lì a poco Franco a prendere finalmente la via per una transizione verso la tanto promessa ma mai sino ad allora accordata svolta democratica.
1.6 La transizione verso la Democrazia
I segnali di cedimento del regime a fonte della scarsa fiducia che oramai riesce ad ottenere da un mondo politico sempre più avverso si manifestano come illustrato già a partire dagli anni 60, ma sarà solamente nel 1973 che il Caudillo rinuncerà alla proprie cariche politiche nominando capo del governo Carrero Blanco, l’ennesimo tecnocrata. Quest’ultimo però viene assassinato alla fine dello stesso anno e la sua morte implica il totale allontanamento dei tecnocrati cattolici dalle funzioni amministrative. Al suo posto viene dunque introdotto Alias Navarro, un liberale, durante la cui amministrazione il generale Franco si ammala gravemente e affida a Juan Carlos le proprie funzioni. La malattia non gli impedisce però di procedere ad un nuovo irrigidimento nella repressione dei ribelli e dei nazionalisti baschi, comprensiva anche di condanne a morte che fortunatamente però non verranno mai effettuate causa la morte, il 17 ottobre 1975 del dittatore stesso.
Circa un mese dopo, il 27 novembre, Juan Carlos viene incoronato ufficialmente re di Spagna, godendo dell’appoggio dei militari e della legittimazione di fronte al popolo datagli dall’essere l’erede designato del defunto dittatore. Questa ultima sua caratteristica è alquanto rilevante, infatti la maggioranza dei cittadini spagnoli si augura una fase transitoria non violenta ed un cambiamento equilibrato, non eccessivamente radicale. Inizialmente quindi gran parte delle alte cariche di Stato continuano ad essere ricoperte dagli appartenenti al regime, scissi oramai fra falangisti e liberali. La peculiarità infatti del passaggio alla democrazia in Spagna sta nel fatto che essa non è conquistata a furor di popolo mediante una rivoluzione o scontri cruenti atti a deporre l’ordine costituito, ma per gentile concessione del regime stesso, che già nelle sue leggi fondamentali prevedeva, prima o poi, tale approdo. Il re inizialmente persegue quindi, anche grazie ai praticamente illimitati poteri concessigli dalle leggi franchiste, una politica di continuità rispetto al passato, mantenendo Navarro come capo del governo. Quest’ultimo viene poi costretto dal monarca a dimettersi l’anno successivo, sostituito da Adolfo Suárez, figura malvista dall’opinione pubblica per il suo passato falangista, ma che riesce in poco tempo a capovolgere la propria posizione ottenendo dalle Cortes una legge che garantisca libere elezioni in un contesto multipartitico, successivamente approvata mediante referendum (Hermet 1999:235). Questa legge segna il proverbiale passo definitivo oltre la linea, poiché abbatte definitivamente le barriere antidemocratiche.
Nel frattempo sulla scena compaiono numerosi nuovi partiti, spesso di origine autonomista, che alimentano una certa confusione già presente nel clima politico per via della fase di transizione in corso. A ciò si aggiunge anche l’inconciliabilità fra i comunisti ed i socialisti. I primi infatti, al pari dei democratici all’opposizione, accettano di buon grado, a seguito della legalizzazione ufficiale del proprio partito, la transizione come frutto di una concessione del regime ed accantonano le questioni ideologiche ad essa legate adoperandosi per il buon esito di tale passaggio, mentre i secondi rimangono al contrario molto critici. Il fattore determinante per il passaggio incruento ad una nuova forma di governo che si verifica in questi anni è la consapevolezza di tutte le parti politiche in causa della necessità di ricorrere alla moderazione, all’equilibrio ed a compromessi ideologici al fine di evitare un ritorno dei militari al potere.
Finalmente quindi, dato il consolidarsi della democrazia, il 15 giugno 1977 vengono indette le elezioni legislative che vedono la vittoria Dell’Ucd, il partito centrista di Suárez. Analizzando tali risultati emerge una netta predominanza di elettori conservatori nelle zone rurali, un rifiuto diffuso per il comunismo del Pce e per la destra estrema di Alianza Popular, mentre la maggior parte dei voti si concentra in favore degli autonomisti in Catalogna e nei Paesi baschi, in favore del partito centrista e dei socialisti del Psoe a livello nazionale. Viene così messo in luce il timore nei ofronti degli estremismi, visti da gran parte della popolazione come pericolosi ai fini della democrazia stessa. Riconfermato alla guida dello Stato quindi, Suárez forma un governo dai tratti neutrali, evitando di includervi le personalità coinvolte con il regime del passato, rinunciando anche al sostegno di Alianza Popular, il partito di estrema destra guidato da Iribarne. Il premier si pone come principale obiettivo di questo mandato il risanamento economico del paese, ricorrendo alla svalutazione della peseta e, dopo aver ottenuto il via libera dei sindacati nel 1977 con il patto della Moncloa, ad un aumento delle imposte che colpisce tanto gli imprenditori quanto i lavoratori. Queste misure, per quanto di forte impatto e in apparenza molto drastiche, si rendono necessarie per via della trascuratezza con la quale negli ultimi anni del regime il governo si è dedicato all’economia, concentrandosi invece maggiormente sulla situazione politica. Il secondo importante traguardo di Suárez è inoltre la stesura di una nuova Costituzione, sulla quale si concentra insieme ai propri sostenitori dando corpo, nel 1978, ad un testo che viene approvato con una maggioranza schiacciante sia dai cittadini mediante referendum, che dalle Cortes che dal senato. Il principale merito di questa Costituzione è quello di condannare e vietare la pena di morte, oltre che di proclamare la laicità dello Stato. Un ulteriore merito che va attribuito agli ideatori di questa Costituzione e che essa contiene una formula, ispirata al riconoscimento delle autonomie regionali italiane, che permette di tutelare le peculiarità delle forti minoranze autonomiste spagnole, senza però perdere totalmente da parte dello Stato il controllo su di esse (Hermet 1999:243). In seguito quindi alla promulgazione della nuova Costituzione vengono indette nuove elezioni amministrative per il 1979. La sinistra ed in particolare i suoi due componenti principali, il partito comunista e quello socialista, non riescono a giungere nuovamente ad un compromesso per concorrere insieme al governo, per via del rifiuto del secondo a questa eventualità, così il risultato vede un’altra volta vincitore Suárez con l’Ucd. Il clima all’interno del paese però torna ad essere piuttosto teso, soprattutto per via della crescita della disoccupazione e degli attentati perpetrati dai separatisti baschi. Nel 1980 la formazione al governo, stavolta composta oltre che dall’Ucd di Suárez anche da Alianza Popular, entra in crisi come riflesso del profondo disagio di quegli anni e come naturale evoluzione di differenze interne mai realmente risolte se non in funzione della situazione di emergenza alla morte di Franco; la scintilla che accende tale crisi è il progetto di legge sul divorzio, contestata fortemente dai conservatori. Non riuscendo più a gestire i propri collaboratori il presidente del consiglio si vede costretto a rassegnare le proprie dimissioni.
A Suárez succede nel 1981 Calvo Sotelo, che si trova alle prese con un’altra importante spina nel fianco per la stabilità della nuova formazione, sempre composta da membri dell’Ucd, chiamata a governare il paese: il rischio di colpi di Stato da parte dei militari. Rischio che si concretizza per mezzo dell’irruzione alle Cortes del colonnello Tejero, sventata solamente grazie all’intervento di Juan Carlos che godendo di enorme prestigio fra i militari riesce a ristabilire l’ordine. Prendendo atto della debolezza delle proprie basi e realizzando l’impossibilità di portare a buon fine la risoluzione delle tematiche sin qui esposte, Sotelo nel 1982 scioglie il congresso (Hermet 1999:248). Le elezioni amministrative che seguono lo sfaldamento dell’Ucd aprono una nuova fase per la politica spagnola, quella dei socialisti al governo.
1.7 I socialisti al governo, atto conclusivo della democratizzazione
Il primo ministro del governo socialista che prende il posto di icen è Felipe Gonzáles, che gode di una maggioranza tale da potersi permettere di non dover scendere a patti con le altre forze politiche presenti sulla scena spagnola: per la prima volta chi detiene il potere non ha alcuna relazione con la dittatura conclusasi il decennio precedente. Una delle prime riforme intraprese da questa nuova formazione riguarda il settore economico e comporta la svalutazione della peseta (Hermet 1999:255) e la chiusura delle industrie non redditizie. Inoltre sono notevoli anche i cambiamenti introdotti in ambito giuridico, con la promulgazione di una legge sull’aborto e di una sul consumo di sostanze stupefacenti e infine diminuisce notevolmente i fondi destinati agli enti di istruzione privati, andando così ad intaccarne lo statuto. Queste ultime misure provocheranno non poche tensioni fra lo Stato socialista e la Chiesa, la quale condanna fermamente l’aborto, senza sottovalutare che numerose scuole private sono istituti ad essa legati, anche sul piano didattico. Infine la disoccupazione è in continuo aumento e le riforme del settore industriale causano una forte ondata di licenziamenti, con conseguenze particolarmente pesanti soprattutto in Andalusia, che già vive una pesante crisi del settore agricolo. Oltre a queste problematiche, che da sole non hanno un peso tale da destabilizzare od indebolire un governo, subentrano però altri due fattori, il terrorismo Basco e la scacchiera internazionale, che alla lunga rallentano ed ostacolano notevolmente lo sviluppo del Paese durante il mandato di Gonzáles. In particolare il primo si manifesta con tutta la sua ferocia con numerosi attentati, peraltro del tutto ingiustificata vista la disponibilità da parte dell’ordine costituito in merito alle autonomie regionali. L’Eta, il braccio armato degli indipendentisti baschi compie parecchie stragi soprattutto a Madrid con l’intento di rivendicare l’indipendenza del proprio “popolo”, creando un pericoloso disagio fra i militari che, nonostante continuino a sostenere il governo, subiscono numerose perdite in vite umane. Il secondo motivo di instabilità, come già introdotto, è costituito dalla reticenza della comunità europea nei confronti dell’inclusione della Spagna all’interno delle proprie dinamiche economiche, rappresentate dal Mercato comune. Il Paese infatti costituisce un pericoloso concorrente, soprattutto nel settore dell’agricoltura, per Francia, Italia e Grecia e gode inoltre di sussidi dovuti alla propria difficile condizione economica, a differenza degli altri stati membri. Contemporaneamente, con l’ingresso risalente al 1986 nella Cee, la politica economica spagnola è fortemente condizionata dal timore di perdere tali sussidi. Nonostante questa congiuntura sfavorevole, accompagnata dall’ostilità di buona parte del mondo politico di sinistra, soltanto qualche mese più tardi, mediante un referendum la Spagna entra infine a far parte dell’Alleanza atlantica ed alla Nato, sua organizzazione militare, donando così una maggiore credibilità al paese ed al suo governo. Governo che, seppur di fronte ad un indebolimento del proprio gradimento, dovuto in larga misura alle dinamiche sin qui esposte, viene riconfermato nelle elezioni del 1986. Il secondo mandato di Gonzáles è caratterizzato da una politica economica molto rigorosa, la quale fa lievitare il malcontento, soprattutto nei contesti universitari, dove si lamenta questa rigidità, causa anche della chiusura di diverse fabbriche. Citando la perifrasi secondo la quale i mali non vengono mai soli, la tensione generale è oltretutto accompagnata dall’aumento dell’inflazione, insieme agli scioperi sindacali e all’allontanamento dei sindacati stessi dalla politica del governo. Nel 1992 il Psoe viene comunque riconfermato nelle elezioni legislative, perdendo però la maggioranza assoluta. Questo comporterà la necessità di stringere nuove alleanze politiche, nella fattispecie con il conservatore partito catalano Convergència i Unió, confermando comunque la validità del principio democratico secondo il quale è possibile governare in una più o meno riuscita collaborazione.
Nel frattempo Alianza Popular, il partito di destra guidato stavolta da José María Aznar, cambia nome diventando il Partido Popular e stempera progressivamente l’immagine di partito di estrema desta con coinvolgimenti con il vecchio regime, proponendosi con un’immagine più moderata. In questo modo riesce, nelle elezioni legislative del 1996, a convince l’elettorato, soprattutto quello cattolico che è rimasto profondamente deluso dall’eccessiva laicizzazione promossa dai socialisti. Non si tratta tuttavia di una vittoria schiacciante, bensì di una maggioranza talmente esigua da costringere anche Aznar a raccogliere l’appoggio dei nazionalisti baschi e di Jordi Pujol, a capo del partito Catalano. Per questo anche il Partido Popular sperimenta le stesse difficoltà dei suoi predecessori, in bilico fra le esigenze e gli orientamenti politici che, grazie al sistema democratico, hanno un peso decisamente rilevante nella conduzione del paese.
Capitolo 2
Aspetti giuridici circa il ruolo della donna
2.1 Premesse
Con questo capitolo si apre la parte più specifica dell’elaborato, quella legata alle tematiche di genere. Si tratta quindi di un approfondimento mirato, che vuole essere preciso ed esauriente, ma per il quale la selezione delle fonti si è rivelata variegata e per certi versi persino insidiosa. Si è cercato infatti di individuare i contributi effettivi, storici e super partes, separandoli invece da quelli retorici o comunque eccessivamente filtrati dalla soggettività di chi li ha apportati. Molte informazioni provengono da una ricerca svolta nel 2001 dagli alunni dell’istituto Parque de Lisboa di Madrid, sotto la guida del docente Juan Carlos Ocaña, pubblicata successivamente nel sito dell’Istituto[7]. Non ci si è inoltre limitati a questi apporti, per quanto già decisamente esaurienti, ma si è invece scelto di verificare anche a livello legislativo i passaggi che si sono susseguiti nelle varie costituzioni del secolo appena trascorso. Le leggi emanate si considerano infatti gli indicatori più veritieri del ruolo sociale che viene di volta in volta attribuito alle donne a seconda del momento storico. Si è perciò scelto di illustrare la legislazione del periodo preso in esame in materia di tematiche femminili, che riguardano principalmente la famiglia, la discriminazione sul lavoro, l’accesso al mondo della politica e la concessione del diritto di elettorato attivo e passivo. Questo in quanto il testo legislativo è una diretta conseguenza dell’orientamento del governo che lo promulga e, pertanto, corrisponde all’immagine ideale che esso promuove, nel caso specifico, del ruolo della donna nella società.
Si notano nel corso degli anni una serie di cambiamenti, effetto del rinforzarsi, dell’approfondirsi e dell’allargarsi del dibattito sulle tematiche di genere, promosso a livello internazionale e nazionale dai movimenti femministi, i quali si ritiene abbiano svolto un compito fondamentale su scala americana ed europea, se non addirittura mondiale, a favore dell’emancipazione femminile e del trattamento paritario delle persone, a prescindere dal sesso. Lungi dal proporsi come un trattato femminista, tuttavia, il presente studio vuole invece proporsi quale punto di osservazione oggettivo dei mutamenti avvenuti a livello sociale in merito al riconoscimento dei diritti della donna nella Spagna del XX secolo, attingendo a fonti di tipo storico-storiografico e di emanazione statale costituite dai codici ufficiali. Altrettanto importante infine si è rivelata la consultazione dei testi di alcune delle più illustri studiose ed esponenti del femminismo o comunque delle tematiche di genere. Si considera doveroso citare Concha Borreguero, Elena Catena, Consuelo de La Gandara e Maria Salas, membre del SESM (Seminario de Estudios sobre la Mujer), che nel testo da loro curato La Mujer Espanola: de la tradición a la modernidad hanno raccolto una serie di saggi riguardanti le tematiche femminili in differenti contesti: per l’elaborazione del presente capitolo si è ricorso in special modo al saggio della giurista María Telo sull’evoluzione del diritto in Spagna, un percorso completo suddiviso per tappe dei vari codici e relative riforme adottate nel Paese nel secolo scorso. Si è rivelata di grande utilità anche la consultazione del saggio sul pensiero femminista sul diritto di Alessandra Facchi, docente di teoria generale del diritto presso l’Università degli studi di Milano, chiarificatore per l’inquadramento a livello europeo del contesto in fase di studio. Altrettanto rappresentativa è infine la giurista Lidia Falcón, la quale presenta un’approfondita argomentazione storica circa la condizione della donna, specialmente in epoca franchista. L’intento del presente capitolo è pertanto, in conclusione, quello di fornire una panoramica chiara ed esauriente circa gli avvenimenti trattati a livello istituzionale e giuridico, mantenendo per quanto possibile un parallelismo con il capitolo precedente, a corredo della presentazione del contesto nel quale l’universo femminile spagnolo si trova immerso.
2.2 Aspetti giuridici
Come ricorda Alessandra Facchi (1999) nel suo saggio sul pensiero femminista sul diritto, a partire da fine Ottocento e per buona parte del Novecento vi è in occidente una forte presa di coscienza da parte delle donne circa la propria condizione all’interno della società, paragonabile ad un vero e proprio risveglio dopo secoli di silenzio, accompagnata dal rifiuto della subordinazione nei confronti dell’uomo che, sino a quel momento, ne condiziona l’esistenza. Per questa ragione, soprattutto allo stadio iniziale, le principali richieste da parte del movimento femminista si focalizzano sulla realizzazione di leggi volte a garantire la parità dei diritti fra uomini e donne, al fine di evitare per il futuro l’ulteriore rinnovarsi della discriminazione sino ad allora perpetratasi (Facchi 1999:132). A livello generale, di conseguenza, nel periodo che abbraccia la fine del secolo XIX e la prima metà abbondante del secolo appena trascorso, viene dedicata una nuova attenzione alla tutela e alla regolamentazione della posizione e delle opportunità della donna nella sfera giuridica, che abbraccia una serie di tematiche variegate e molto ampie. Questo comporta non pochi momenti di tensione e di polemica, poiché l’argomento su cui si richiede di legiferare da parte dei vari movimenti femministi va ad intaccare la costruzione sociale del genere, derivata da secoli di prevaricazione nei confronti della donna. In particolare, viene lentamente intaccata la struttura giuridica che determina la subordinazione delle donne nella famiglia, in relazione all'organizzazione della parentela e ai sistemi di trasmissione della proprietà. I cambiamenti riguardano inoltre la possibilità di accesso ad ambiti di potere e di influenza in vari contesti culturali, dalla vita religiosa a quella intellettuale e politica, tradizionalmente preclusi alle donne. Nella specificità del caso spagnolo, come emerge nelle prossime pagine, questa nuova consapevolezza acquisita dalla donna gioca, soprattutto nella Seconda Repubblica in un primo momento, interrotto dalla lunga “parentesi buia” costituita dagli anni iniziali del regime di Franco e, a partire dalla metà del secolo scorso poi, un ruolo sempre più attivo nella stesura di codici e leggi che le consentano una maggiore autonomia, emancipazione ed indipendenza nei confronti dell’uomo.
2.3 Le donne invisibili del secolo XIX
2.3.1 L’accesso all’educazione, passaporto per il ventesimo secolo
La prima parte del periodo storico preso in esame, che abbraccia le ultime tre decadi del diciannovesimo secolo ed il primo ventennio di quello successivo, si rivela particolarmente fertile per la nascita e lo sviluppo di nuovi modelli di pensiero, i quali comprendono anche la riflessione inerente le tematiche di genere. Ci si trova infatti nell’epoca del liberalismo[8], dove i valori posti in rilievo sono la libertà e l’uguaglianza fra gli individui. Nascono in Inghilterra e negli Stati Uniti i primi movimenti suffragisti, diffusisi poi anche in altri paesi occidentali, per l’ottenimento del diritto di voto per le donne. Anche la Spagna risente di questa influenza e vede la nascita di associazioni femminili, le cui richieste implicano un cambiamento di rotta rispetto alla posizione della donna nella società, auspicabile attraverso il suo inserimento nella sfera pubblica. L’obiettivo più importante posto in essere da questa nuova presa di coscienza è l’accessibilità all’educazione superiore ed universitaria, considerata un passo fondamentale verso l’emancipazione, ma sino ad allora riservata solamente all’uomo.
Le competenze dei pochi ruoli professionali normalmente ricoperti dalle donne, come per esempio insegnanti ed istitutrici, rimangono limitate al minimo indispensabile per l’esercizio delle proprie mansioni. Lo stesso avviene per le donne dell’alta borghesia, il potenziamento della cui educazione rimane sempre finalizzato ad un migliore espletamento delle proprie funzioni domestiche e ad una maggiore capacità di trasmettere ai propri figli gli ideali della classe sociale di appartenenza. Per questa ragione Flecha García (1996) desume il permanere di un vincolo strettissimo fra la scuola e le necessità pratiche, che tiene quindi ancora conto delle differenze di genere e che preclude alla donna l’accesso a buona parte dell’informazione, materie scientifiche in testa. Come già evidenziato però, il particolare momento storico concede qualche piccola conquista alle donne, pur permanendo nel sentire comune la convinzione che non siano intelligenti quanto gli uomini. Tra i segnali del cambiamento c’è la decisione di un esiguo numero di studentesse le quali, avendo completato il ciclo di studi secondari, decidono di intraprendere anche quelli universitari. Essi non sono loro formalmente preclusi, non esiste infatti nessuna regolamentazione che vieti l’accesso femminile al contesto accademico. Allo stesso tempo però l’università è un ambiente sino ad allora interamente maschile ed è veramente forte e condizionante il giudizio negativo della società nei confronti delle donne che studiano. Per questa ragione le ragazze in questione, tutte di elevata estrazione sociale, figlie dell’alta borghesia spagnola, sono da considerarsi delle vere e proprie pioniere, che hanno il coraggio di sfidare la convenzione. Il problema vero e proprio tuttavia sorge al termine del percorso universitario, quando è auspicabile da parte delle interessate la messa in pratica in ambito professionale o accademico dei frutti dei propri studi.
Un caso che riscuote particolare attenzione è quello delle prime due laureate in medicina dell’Università di Barcellona, María Elena Maseras e Dolores Aleu, le quali, una volta completati gli studi, richiedono di poter intraprendere in base ad essi la carriera professionale che ne deriva. Il Consejo de Instrucción Pública, come documenta Consuelo Flecha García[9] (1996), che è l’organismo preposto alla risoluzione di tale questione, lascia passare tre anni prima di confermare l’accesso, nel 1881, delle donne all’insegnamento superiore (Flecha García 1996: 82). L’anno seguente inoltre, suddetto Consiglio approva formalmente l’accesso delle donne agli studi superiori non solo nell’insegnamento elementare ma anche a discipline più specializzate come per esempio quelle commerciali, suggerisce la creazione di appositi istituti per gli studi superiori femminili e accetta il riconoscimento dei titoli accademici ottenuti dalle donne, ponendo però la limitazione che tale riconoscimento sia effettivo solo per coloro che siano già immatricolate al momento della promulgazione di tale documento, pubblicato sul periodico La Época. Solamente due mesi più tardi, infine, si proibisce l’accesso femminile alla facoltà di medicina (Flecha García 1996: 87).
In un susseguirsi altalenante di richieste di riconoscimenti da parte delle studentesse e di riunioni del Consiglio si raggiungono però negli anni successivi due grandi risultati: il primo è l’accesso all’insegnamento secondario delle donne, ottenuto nel 1883 ed il secondo, cinque anni più tardi, dalla grande portata innovatrice, riconosce finalmente loro il diritto di poter intraprendere gli studi universitari tramite Real Orden, Ordinanza Reale. Questo traguardo, ottenuto come conseguenza di numerose insistenze esercitate dalle donne che vogliono proseguire gli studi, si rivela comunque ancora portatore di limitazioni piuttosto gravi, come l’obbligo di studiare da privatiste e quello di sottoporsi ad un’apposita commissione una volta conseguita la laurea per sottoporle la propria situazione al fine di decidere in merito al riconoscimento di tale titolo all’interno del mondo del lavoro. Solamente nel 1910 vengono definitivamente abolite queste limitazioni e, mediante il Real Orden del 2 settembre, si dichiara che coloro che volessero continuare la propria formazione a livello universitario in via ufficiale non hanno più bisogno di permessi speciali e che le laureate hanno lo stesso diritto degli uomini a partecipare a concorsi pubblici e ad accedere al mondo del lavoro senza restrizioni di sorta, compreso l’insegnamento superiore (Flecha García 1996: 93).
Con questo ultimo passaggio si completa una tappa assai importante del percorso verso l’emancipazione femminile in Spagna, chiara dimostrazione dell’apertura di uno spiraglio nella mentalità comune dell’epoca. Questo nuovo senso di intendere la donna tuttavia, seppure approvato su carta, è ancora ben lungi dall’essere accettato e riconosciuto nella vita reale e sono necessari decenni perchè ci sia una sua totale integrazione alla vita pubblica ed al mondo del lavoro senza più discriminazione.
2.3.2 Il contributo del Codice Civile napoleonico alla costituzione del 1889
Nel 1889 viene promulgato il Codice Civile Spagnolo, su ispirazione di quello napoleonico e a complemento della Costituzione del 1812. María Telo, (1986), giurista di nota fama ed esperta nelle tematiche di genere, nel suo saggio “La evolución de los derechos de la mujer en España”, contenuto nel testo del SESM La mujer española: de la tradición a la modernidad sostiene con forza il potere negativo del condizionamento esercitato dal Codice Napoleonico nelle nuove norme legislative introdotte nel 1889, in quanto secondo l’autrice esse rappresenterebbero la legalizzazione e la cristallizzazione della convinzione conservatrice per la quale la donna andrebbe trasformata in un
ser nulo, despojado de bienes y totalmente dependiente de su marido (Telo 1986:81).
Ritroviamo pertanto nel pensiero dell’autrice una forte sfiducia nei confronti di tale fonte normativa, la quale sta alla base, se non nei contenuti, nel tipo di approccio agli istituti di alcuni dei maggiori ordinamenti giuridici europei contemporanei fra cui Italia, Francia e Spagna, ma che evidentemente, sempre secondo la fonte citata, non è in grado di risolvere nella sua forma originaria il conflitto insito nelle tematiche di genere. In effetti, tale codice apporta una serie di limitazioni rispetto alle libertà femminili che sarebbero intollerabili nella realtà spagnola contemporanea. Per cominciare, la donna sposata viene considerata alla stregua di un minore sotto tutela, costantemente legata da un vincolo pupillare dapprima alle volontà del padre, dopo il matrimonio a quelle del marito. Lo deve seguire ovunque, non può abbandonare il paese senza il suo consenso, deve portargli obbedienza e rispetto. Tali indicazioni sono contenute nell’articolo 321, che afferma che le figlie maggiorenni, ma minori di 25 anni, non possono lasciare la casa dei genitori se non con il loro permesso o per sposarsi. Secondo l’articolo 22 del Codice, la donna adotta la nazionalità del proprio marito, secondo il 57 deve portargli obbedienza e seguirlo dovunque ed il 58 precisa che essa è esente da quest’ultimo obbligo, qualora l’uomo decida di spostarsi all’estero. La donna non ha la potestà sui propri figli né tanto meno la possibilità di darli in adozione, come sancito dall’articolo 154 che assegna automaticamente al padre la patria potestà, riservata alla madre solo qualora egli venga a mancare. Anche in merito all’amministrazione dei beni parafernali (cioè di esclusiva proprietà delle donne) sono presenti in questo codice numerose limitazioni, dipendenti dalla volontà del marito che è l’amministratore dei beni della coppia in base all’articolo 59. L’uomo è anche il rappresentante legale della propria sposa, come sancito dall’articolo 60, la quale non può nemmeno comparire in giudizio senza il suo permesso. Se una vedova si sposa in seconde nozze perde la tutela dei figli nati nel primo matrimonio. Peggio ancora, se separata, all’umiliazione pubblica di essere stata rifiutata, o come meglio esprime la Telo depositada, si aggiunge l’espulsione dalla casa coniugale, la perdita di tutti i beni comuni, dei beni parafernali assegnati al marito tramite pubblico documento scritto e della dote. La donna separata può portare con sé solamente i figli minori di 3 anni, i propri abiti di uso quotidiano ed il letto; il suo unico sostentamento è costituito dagli alimenti, che le spettano di diritto. Paradossalmente la figura femminile più tutelata in questo contesto tanto restrittivo è la donna sola, quella non sposata, che può, una volta raggiunta la maggiore età, dedicarsi ad una professione con vincoli che però riguardano “solamente” una questione di genere; la donna non sposata però non può lasciare la casa dei genitori e, qualora avesse figli, ne perderebbe la potestà parentale nel caso in cui il padre di tali figli li riconoscesse (Telo 1986: 83). Da quanto sinora esposto la realtà in cui si trova immerso l’universo femminile nella Spagna a cavallo fra XIX e XX secolo risulta effettivamente limitante e frustrante. Si ritiene di porre l’attenzione su due aspetti in particolare: in primo luogo, essa viene con il matrimonio totalmente spogliata delle libertà civili a partire dal semplice diritto al lavoro, alla residenza nel luogo che più le aggrada, alla potestà sui propri figli. In secondo luogo è evidente come l’uomo da questa situazione tragga enormi giovamenti economici: egli è infatti totalmente legittimato all’utilizzo, dote inclusa, di praticamente tutte le risorse economiche della propria compagna, senza nemmeno avere bisogno del consenso di quest’ultima, utilizzo che si protrae anche nel caso dell’interruzione della relazione fra i due. Per concludere, quindi, si appoggia la tesi dell’autrice che denuncia come il Codice Civile Spagnolo del 24 Luglio 1889 in materia di diritto familiare sia estremamente parziale ed incentivi la prevaricazione dell’uomo nei confronti della donna. A fronte di limitazioni scritte tanto restrittive infatti, non solo si limitano per legge quelli che ai giorni nostri sono i diritti fondamentali della persona, ma si legittima ed autorizza a livello istituzionale una subordinazione a livello familiare e sociale in base al genere, la quale comporta inevitabilmente il perpetrarsi della discriminazione anche a livello culturale. Le cose non vanno molto diversamente nemmeno in materia penale, dove ancora una volta la donna è fortemente svantaggiata rispetto all’uomo.
2.3.3 Il Codice Penale del 1870
Maria Telo presenta il codice penale entrato in vigore nel 1870 come ancora più duro e disumano di quello civile. Si legge nel saggio dell’autrice che
En el orden penal destaca la dureza con que sempre fue tratada la mujer, precisamente como garantía estabilizadora de la familia patriarcal y pureza de la estirpe (Telo 1986: 88).
Effettivamente nel nuovo codice penale vengono ripresi ed inseriti i princìpi del precedente Fuero Real, l’ordinamento del secolo XII secondo il quale il marito ed il padre della donna colpevole di adulterio hanno il diritto di lavar su honra con sangre, di uccidere cioè la figlia o la moglie fedifraga ed il suo amante qualora sorpresi in flagranza di reato. In aggiunta all’omicidio sono ammessi nel nuovo codice penale anche lo stupro, il rapimento, l’infanticidio, l’aborto come possibili conseguenze di fronte ad un tradimento, adducendo come motivazione la tutela dell’onore della donna, vista come poco più di una proprietà del padre o del marito. Nel caso di infedeltà dell’uomo, invece, la punizione è effettiva solo nel caso in cui i fatti si svolgano sotto al tetto coniugale o anche al di fuori di esso, ma soltanto se in maniera palese. Nello specifico gli articoli in questione sono il 438, il 448 ed il 452 del Codice Penale, che si occupano della regolamentazione dei casi di adulterio. Stando a quanto riportato dalle studentesse López e Medina nel saggio “Legislación sobre la mujer en la segunda mitad del siglo XIX” in tali articoli si afferma che, in caso di omicidio o lesioni gravi contro la donna sorpresa a commettere adulterio, la pena prevista per il marito sia l’esilio, pena che però viene annullata in caso di lesioni meno gravi. La stessa legge si applica anche ai genitori di minori di 23 anni che esercitino la prostituzione, a meno che essa non sia promossa dal padre o dal marito. La ragione che giustifica la severità delle pene nei confronti della donna è quella di tutelarne l’onore ma in realtà, ciò che si vuole proteggere secondo la Telo, è la certezza della paternità e con essa la successione di beni e di privilegi (Telo 1986: 89). Riconoscendo l’attendibilità delle fonti e ricercando la maggiore obiettività possibile, ci si limita nuovamente ad osservare, così come nel caso del Codice Civile, anche il Codice Penale in vigore durante i decenni che segnano il passaggio fra i secoli XIX e XX non sia equo ed imparziale, favorendo anch’esso la figura maschile e legittimando invece durissime pene alle donne, pene corporali che si possono tradurre anche nella morte stessa della persona. La motivazione addotta a giustificazione di tali abusi legalizzati è l’onore.
2.4 L’evoluzione della Seconda Repubblica
Nel 1931, una volta ristabilita la democrazia, una nuova Costituzione viene elaborata e promulgata, rendendo finalmente paritari rispetto a quelli degli uomini i diritti ed i doveri delle donne di fronte alla legge le quali acquisiscono lo status di cittadine; il governo, infatti, si prodiga sin dagli esordi per rimediare alla trascuratezza riservata a queste ultime durante i periodi precedenti. In particolare nella Costituzione del 1931 si sancisce che il sesso non può costituire elemento discriminatorio in ambito giuridico[10], elettorale[11], lavorativo[12], familiare[13]. Inoltre la nuova Costituzione garantisce la tutela della maternità[14] e l’accesso femminile a tutte le cariche politiche[15]. Un ulteriore passo avanti verso l’emancipazione femminile in Spagna è compiuto nel 1932, in corrispondenza della rielaborazione del diritto familiare. In tale circostanza si approva il riconoscimento del matrimonio civile e si rivede la legge sul divorzio, la cui possibilità di richiesta viene estesa anche alla donna o ad entrambi i coniugi, qualora ci sia un accordo comune. Secondo quanto affermato dalle ricercatrici dell’Istituto del Parque de Lisboa Lobelos e Borreguero (2001), i modelli costituzionali ai quali si ispirano per questa specifica tematica i giuristi spagnoli sono soprattutto quello francese in merito alla questione divorzio e quello della repubblica di Weimar[16] circa l’uguaglianza dei sessi. La legislazione discriminante che precede la Costituzione del 1931 viene in questo modo annullata e superata, rendendo la Spagna uno dei paesi europei più avanzati dell’epoca in materia di diritto civile. Ci si trova dunque di fronte ad un importante riconoscimento, almeno sulla carta, del ruolo delle donne nella vita pubblica, sino ad allora considerata prerogativa prettamente maschile. Infine, un investimento degno di nota è quello che il governo della Seconda Repubblica dedica al miglioramento del sistema scolastico, con la creazione di nuove scuole elementari per ridurre il tasso di analfabetismo nel Paese.
5. Il ritorno al passato dell’epoca franchista
2.5.1 La Donna secondo Franco
La resa di Madrid all’esercito franchista avviene il 1 aprile 1939. Da quel momento attecchiscono e vanno a costituire le fondamenta ideologiche del nuovo governo le idee promosse dall’ormai defunto José Antonio Primo de Rivera, fatto prigioniero e giustiziato dallo sconfitto esercito repubblicano. Come ancora ricorda la Falcón, per l’ideatore della Falange la Spagna deve essere imperiale, cattolica e indivisibile (Falcón, 1969: 274). Il concetto di Patria assume quindi una rinnovata importanza, viene esaltato come un valore universale per il quale vale la pena persino rinunciare alla vita stessa. In questo nuovo contesto vengono aboliti tutti i partiti politici esistenti, eccezion fatta, ovviamente, per quello al governo. Questo porta alla persecuzione, all’incarcerazione, all’esilio o comunque al non riconoscimento pubblico di tutti quei partiti politici, movimenti e relative sezioni femminili sorti a partire dall’epoca repubblicana. Secondo Lidi Falcón la rinascita della Spagna più tradizionalista si traduce nella rinnovata imposizione nei confronti della donna del modello femminile della vergine onesta, della sposa perfetta. L’ambito d’azione a lei riservato è accessorio e superfluo se comparato a quello dell’uomo (Falcón 1969: 286). Le leggi di epoca franchista inevitabilmente rispecchiano l’ideologia promossa dalla Falange e dal suo massimo esponente e quindi, soprattutto, nella fase iniziale della dittatura contribuiscono fortemente al mantenimento nella società spagnola della netta separazione dei ruoli ed alla svalutazione della donna, relegata nella maggior parte dei casi all’ambito della casa e della famiglia. Ancora una volta Maria Telo fornisce un preciso quadro a livello legislativo che si vene a creare nel nuovo scenario del paese. Innanzitutto con l’avvento del franchismo vengono abrogate tutte le leggi a favore della donna ed i diritti a lei riconosciuti durante la Seconda Repubblica, a cominciare da quello del divorzio. Viene infatti reintrodotta attraverso le Leggi Fondamentali una buona parte delle norme contenute nel Codice Civile Napoleonico, i divorzi di epoca repubblicana sono dichiarati nulli e le coppie oramai separate si vedono costrette a riunirsi. Con la reintroduzione di suddette leggi inoltre, i passi avanti verso l’emancipazione compiuti in ambito giuridico, elettorale, lavorativo e familiare vengono letteralmente cancellati; tutto questo, come ci ricorda la Telo è conclamato nel secondo punto del Fuero del Trabajo[17], che avrebbe lo scopo di liberare la donna dall’ufficio e dalla fabbrica. (Telo 1986: 90). Continua poi l’autrice precisando che esiste una legge, quella del Contratto di Lavoro, che concede di svolgere un impiego soltanto alle donne che abbiano il consenso del proprio marito. Per ciò che concerne il diritto penale, infine, rientrano nuovamente in vigore alcuni punti della normativa del 1870 che riconosce il reato di adulterio e ammette da parte del padre o del marito il diritto ad usare violenza sino all’omicidio contro la fedifraga qualora sorpresa in flagranza di reato, per compensare il disonore apportato da tale azione. Si tratta di misure estremamente restrittive che catapultano indietro nel tempo la donna al periodo pre-repubblicano e che, rapidamente, vanificano la lunga lotta per la conquista della parità di diritti combattuta sino ad allora. Tuttavia non va perduto totalmente questo desiderio di emancipazione, né tanto meno il governo può ignorare che a livello internazionale stiano avvenendo grossi cambiamenti in materia. Per questo nei decenni successivi il codice civile subisce una serie di riforme.
2.5.2 La riforma del 1958
María Telo, introducendo il paragrafo dedicato al primo punto di svolta nel cammino verso l’ottenimento della parità dei diritti per le donne nel periodo franchista, espone un antefatto che si rivela determinante per la focalizzazione dell’attenzione dell’opinione pubblica sulla tematica del domicilio coniugale. Nel dettaglio viene pubblicato sul quotidiano Abc un articolo redatto da Mercedes Fórmica, scrittrice e avvocatessa, intitolato proprio El domicilio conjugal, nel quale viene esposto il caso di una donna pugnalata dal marito. L’articolo continua con la denuncia dell’ingiustizia per la quale, secondo il Codice Civile, il domicilio coniugale in realtà sarebbe la casa del marito. Il dibattito, oltre che prendere vita e continuare sullo stesso giornale, si estende all’Academia de Jurisprudencia e, infine, alla Comisión General de Codificación che si adopera alla stesura di un nuova legge di riforma della precedente. Si abolisce definitivamente la pratica secondo la quale la casa coniugale sarebbe la casa del marito, diventando l’abitazione coniugale, assegnabile alla donna in caso di nullità del matrimonio a discrezione del magistrato incaricato; non solo, una volta dichiarato nullo il vincolo, la donna ha diritto alla metà dei beni comuni ed alla totalità dei propri, diversamente da quanto sancito precedentemente. L’unica “trappola” contenuta in questa nuova stesura è costituita però, come fa notare la Telo, dal principio di colpevolezza, alla base del sistema che regola le separazioni in Spagna, secondo il quale il coniuge colpevole perde il diritto agli alimenti e la patria potestà, con l’eccezione dei figli minori di 7 anni che rimangono con la madre anche in caso di sua colpevolezza. Questa situazione, continua la studiosa, non rappresenta una grave incombenza per l’uomo, che normalmente ha un proprio lavoro e quindi una sicura fonte di sostentamento; molto più difficile è invece che la donna sia in grado di mantenere se stessa ed i propri figli, dato che lo Stato si è prodigato per liberarla dalla fatica della fabbrica (Telo 1986: 91). Oltre a quelli già citati vengono apportati ulteriori cambiamenti e a seguito di tale operazione l’adulterio diventa un reato anche per l’uomo e l’unica motivazione ritenuta valida per il divorzio. Un’altra importante conquista riguarda la vedova che si risposi, la quale conserva la potestà genitoriale sui figli del precedente matrimonio. Infine, la donna sposata può ora anche essere esecutrice delle ultime volontà di un defunto e testimone e destinataria dei beni testamentari, a patto però che abbia l’autorizzazione del proprio marito. Tuttavia secondo la Telo la modifica più significativa è quella che riguarda l’articolo 1.413 del Codice Civile, dato che intaccherebbe più duramente di tutte le altre la base della famiglia patriarcale. Si ritiene che tale riforma, in effetti, rappresenti una svolta piuttosto marcata, giacché esige il consenso della donna all’utilizzo dei propri guadagni da parte del marito. Questa prima ondata di modifiche agli articoli del testo costituzionale rappresenta sicuramente un segnale di un cambiamento in atto nel modo di pensare la donna all’interno della società spagnola dell’epoca franchista, che vede aumentare le proprie libertà, almeno sulla carta, all’interno del contesto familiare. Ciononostante sono ancora numerosi i cambiamenti auspicabili, soprattutto in ambito politico e lavorativo; cambiamenti questi che occorrono solo tre anni dopo con la promulgazione di una nuova legge.
2.5.3 La legge del 15 Luglio 1961 sui Diritti Politici Professionali e del Lavoro della Donna e la riforma del Codice Penale del 21 Marzo 1963
Questa legge entra il vigore il primo gennaio del 1962 e secondo la Telo la motivazione principale della sua stesura va ricercata nelle eccessive restrizioni presenti nel testo ad essa precedente, poco funzionali allo sviluppo economico necessario al Paese. Scrive infatti l’autrice:
La asfixia económica y el desfase internacional que para el país suponía el haber tomado ciertas medidas, entre ellas la de prohibir el acceso de la mujer a los cuerpos profesionales de más alto nivel, y principalmente el haber excluido a la casada del mundo del trabajo, dio lugar a que se dictase esta Ley (Telo 1986: 92).
Come si deduce da queste parole la spinta verso il cambiamento viene individuata dalla avvocatessa, la quale ripercorre l’intera legislazione spagnola del secolo scorso focalizzandosi sul diritto femminile, nel rallentamento e nel cattivo andamento dell’economia spagnola di quegli anni. Tale situazione negativa necessita non solo di una maggiore manodopera, ma anche di un incremento nel numero del personale specializzato ed è risolvibile solo mediante il reinserimento della donna nel mondo del lavoro, ad essa inizialmente precluso dal codice adottato dal regime vigente. Alla donna viene perciò concesso il diritto di partecipare alla vita politica, di lavorare e di accedere alle più alte cariche dello Stato, fatta eccezione per la Administración de Justicia dove può occuparsi solamente dei minori e del lavoro, e le rimane preclusa la possibilità di integrarsi nei Cuerpos Armados e nella Marina Mercantile. Con questa legge perciò, salvo le eccezioni indicate, viene abolita qualsiasi differenza di genere, anche per quanto riguarda i salari, ora uguali sia per gli uomini che per le donne. Una ultima grossa limitazione che non viene però risolta se non con la legge del 28 dicembre 1966 è rappresentata dalla autorizzazione del marito, vincolante per la moglie per poter assumere o svolgere qualsiasi tipo di carica o professione. Anche il Codice Penale attraversa negli anni delle modifiche ed il 21 marzo 1963 il regime emana un decreto che proibisce e condanna il ricorso alla violenza da parte del padre o del marito in caso d’adulterio commesso dalla donna. Scompare così il concetto di venganza de la sangre, come lo definisce l’autrice, in base al quale il mancato rispetto dell’onore può giustificare ed autorizzare atti di inaudita efferatezza (Telo 1986: 92). A seguito delle lotte per la conquista della parità dei diritti portate avanti dalle donne spagnole, Telo inclusa, si verificano negli anni successivi le riforme di altri articoli, prima di tutte quella avvenuta con la promulgazione della legge del 4 Luglio 1970 che rende obbligatorio il consenso della madre per l’adozione dei figli. Ad essa segue infine nel 1972 la legge del 22 Luglio che permette alle ragazze minori di 25, ma maggiorenni, di lasciare la casa dei genitori anche senza il loro consenso (Telo 1986: 94). Per concludere si sostiene, alla luce di quanto sinora esaminato, che sono notevoli i segnali di apertura verificatisi soprattutto nelle ultime battute del regime nei confronti della donna, dapprima totalmente esclusa dalla vita pubblica e ridotta ad una posizione di vera e propria sudditanza nei confronti dell’uomo e poi lentamente riconosciuta come meritevole di maggiore riguardo. Si evidenzia però, in accordo con la studiosa María Telo, la presenza insidiosa di tutta una serie di limitazioni in conseguenza delle quali, almeno fino al 1966 quando vengono ufficialmente abolite, la decisione ultima sulla libertà della donna spetta sempre e comunque al marito. Si tratta quindi fino a quell’anno più che altro di riconoscimenti ufficiali che però non garantiscono l’assoluta libertà di azione alla donna, i cui diritti rimangono a lungo appunto limitati in confronto e in funzione di quelli dell’uomo.
2.6 La riforma del Codice Civile del 1975
Per una svolta ancora più radicale nella questione dei diritti bisogna attendere fino al 1975, anno in cui è promulgata la legge 2-5-1975. María Telo in particolare focalizza la sua attenzione su due articoli: il primo è l’articolo 62 nel quale si dichiara che il matrimonio “no restringe la capacitada de obrar de ningúno de los conjuges” mentre il secondo, l’articolo 63, precisa che nessuno dei due coniugi può rappresentare l’altro senza il suo consenso. La giurista sostiene che questi cambiamenti siano di enorme portata, poiché sanciscono l’abbandono definitivo del concetto di licencia marital, cioè dell’autorizzazione previa del marito necessaria alla donna per poter disporre dei beni parafernali, comparire in giudizio, essere tutore e testimone testamentario, presente invece nel codice del 1958 (Telo 1986: 94). A livello teorico scompare quindi anche la figura del padre di famiglia e fa capolino invece una nuova prospettiva, quella della collaborazione e del comune assenso fra i coniugi, che devono proteggersi e rispettarsi a vicenda; non c’è nemmeno più l’obbligo per la donna di seguire il marito ma, al contrario, il domicilio è la scelta a seguito di un comune accordo. Sul piano lavorativo, infine, viene modificato anche il Código de Comercio, affinché la donna sposata possa svolgere attività mercantili senza l’autorizzazione del marito (Telo 1986: 95). Uniche limitazioni alla totale uguaglianza dei sessi rimangono però la patria potestà, ancora riservata all’uomo e il potere decisionale sui beni comuni, anche se provenienti dal lavoro della donna, che rimane di competenza del marito. Denotandosi una particolare attenzione riservata al conseguimento della parità dei diritti, nonostante la divergenza della dottrina di regime a riguardo, in quest’ultima fase della dittatura si ritiene positivo il grado di apertura dimostrato nei confronti della donna. Sicuramente tale miglioramento è tuttavia da ritenersi frutto anche della spinta dell’opinione pubblica nazionale ed internazionale e dei numerosi movimenti femministi venutisi a creare soprattutto a partire dagli anni sessanta in poi e proprio nel 1975 in special modo, essendo l’anno internazionale della donna.
2.7 La Costituzione del 1978
La Spagna è uno di quei pochi paesi dove il passaggio dal regime dittatoriale a quello democratico, anche se nello specifico si tratta di una monarchia parlamentare, meglio noto come transicción ha luogo non tramite un passaggio netto o cruento, bensì come frutto di una preparazione lenta e ragionata, uno studiato passaggio di testimone. Ne è la dimostrazione l’evoluzione lenta, ma costante, che ha coinvolto la legislazione durante il periodo franchista tramite le varie riforme sinora esposte, che rappresentano ciascuna un piccolo passo verso una maggiore apertura circa, nello specifico, il riconoscimento dei diritti delle donne. Dopo il 1975, con la morte del dittatore ed il ritorno alla monarchia costituzionale, gioca un ruolo determinante per l’elaborazione del nuovo codice adottato di lì a qualche anno la Comisión de Codificación, della quale la stessa Telo fa parte, organismo preposto alla riforma del Derecho de Familia, impegnato, fra le altre incombenze, anche alla preparazione di un progetto di legge sul divorzio. Il primo grande risultato dei lavori della commissione vede la sua realizzazione con la nuova Costituzione del 27 dicembre 1978, nel cui articolo 14 si proibisce la discriminazione in base al sesso; tale concetto viene poi ribadito in ambito familiare con l’articolo 32 e in ambito lavorativo con l’articolo 35 (Telo 1986: 95-96). Nello stesso anno anche il codice penale subisce ulteriori ammodernamenti, secondo la giurista conseguenza diretta delle insistenti richieste dei gruppi femministi, che si traducono con l’emanazione di tre nuove leggi, la prima delle quali risale al 26 maggio 1978 e annulla il reato di adulterio. Nello stesso anno, più precisamente il 7 di ottobre, vengono promulgate le altre due, la 45 e la 46, la prima delle quali depenalizza l’utilizzo di contraccettivi, mentre la seconda condanna lo stupro non più come un crimine contro la donna, ma contro la persona. Due anni più tardi, infine, viene modificato anche lo statuto dei lavoratori con la legge del 10 marzo 1980 nella quale si riconosce al lavoratore il diritto di non essere discriminato né per ragioni di sesso né di Stato civile; qualsiasi clausola portatrice di discriminazioni in tal senso viene dichiarata nulla. Indicativo è anche l’articolo 28 di questa legge che sancisce che non ci devono essere differenze salariali. Si è evidentemente giunti ad un punto in cui il nuovo sistema di governo, insieme all’operato delle varie organizzazioni femministe, apre la porta ad un maggiore dibattito e attenzione alle tematiche di genere, sempre più tutelate a livello normativo e, di conseguenza, anche sociale.
2.8 La riforma del codice civile degli anni 1981 e 1982
Le ultime significative modifiche che si vanno ad esporre sono quelle avvenute con l’emanazione della legge del 13 maggio 1981, del 7 luglio dello stesso anno e del 13 luglio 1982, che completano il percorso degli anni precedenti, permettendo alla donna di raggiungere totalmente l’uguaglianza dal punto di vista giuridico. Nel dettaglio il 13 maggio 1981 e l’entrata in vigore della legge 11, risale all’anno 1978, quando la Comisión General de Codificación ne termina la stesura del progetto, sotto il nome di Filiación Patria Potestad y Regimen Económico del Matrimonio. Tale legge elimina le discriminazioni in base al sesso e pone su un piano di uguaglianza giuridica i coniugi per quanto riguarda l’amministrazione dei beni comuni e la potestà genitoriale; si legifera inoltre che qualsiasi atto giuridico o contrattuale fa fede esclusivamente a chi vi ha apposto la propria firma, cancellando definitivamente la licencia marital, che per tanto tempo ha costituito un’importante limitazione all’autonomia femminile. La Telo però precisa che è ancora il marito a costituire il punto di riferimento per stabilire le competenze per quanto riguarda moglie e figli ed è sempre lui ad avere la corsia preferenziale nell’assegnazione della propria nazionalità ai figli. Questa differenza viene tuttavia appianata l’anno successivo con la legge del 13 luglio. La legge del 7 luglio 1981, invece, desta maggiore polemica al momento della sua emanazione in quanto si occupa della tematica del divorzio, argomento molto discusso all’interno della società spagnola, ancora permeata di cattolicesimo. Il progetto di quest’ultimo apporto al Codice Civile, infatti, viene ostacolato nel corso degli anni e costretto a subire numerosi cambiamenti. Come sostiene la Telo, che vede in queste tre leggi la terza tappa delle riforme del Codice, la legge sul divorzio elimina il principio di colpevolezza e non esplicita alcuna differenza fra uomo e donna. L’articolo 97 di tale legge prevede che, in caso di differenze economiche fra i coniugi conseguenti al divorzio, chi dei due si ritrova nella situazione meno conveniente ha diritto ad una pensione che però tiene conto di svariati fattori fra cui lo Stato di salute, l’età, la qualificazione professionale, la durata del matrimonio, gli accordi presi fra i due. Alla luce di quanto sopra si può in conclusione notare con certezza l’avvenimento di numerose modifiche a favore della donna, dovute sicuramente in parte sia all’evoluzione del diritto internazionale, sia alla nascita dei movimenti femministi spagnoli sia, da ultimo, alla fine della dittatura la quale, portavoce di un cattolicesimo rigoroso ed integerrimo, non promuove eccessivamente le (giuste) pretese di libertà e di uguaglianza promosse dalle femministe.
Capitolo 3
La storia nella Storia dell’altra metà del cielo
3.1 Premesse
Il presente capitolo si occupa di analizzare la situazione della vita reale delle donne nella società spagnola del secolo scorso, nella prospettiva di verificare le corrispondenze e le discrepanze con quanto esposto nel capitolo precedente. Nel dettaglio, si tratta di verificare se e come i cambiamenti avvenuti a livello normativo siano fautori di modifiche nei comportamenti a livello sociale nei confronti della donna. La suddivisione del paragrafo mantiene lo stesso parallelismo al quale si è sinora ricorso, in modo da isolare i differenti periodi storici cui si fa riferimento, per meglio evidenziare le relazioni di causa-effetto che si vanno indagando. Si sono consultati numerosi testi, iniziando con quello di Consuelo Flecha García, docente all’università di Siviglia e ricercatrice in tematiche collegate al femminismo, la quale ha scritto in merito alla situazione della donna a cavallo tra Ottocento e Novecento. Si è utilizzata poi ancora una volta la preziosa risorsa costituita dalla ricerca effettutata dall’Istituto Parque de Lisboa, al quale si è gia ricorso nel precedente capitolo.Per molti aspetti, in aggiunta, soprattutto per quelli prettamente storici, si è attinto dagli articoli dell’ANPI, l’Associazione Nazionale dei Partigiani d’Italia[18]. Tale associazione ha infatti raccolto negli anni abbondante documentazione relativa alla resistenza antifascista in Italia e all’estero ed ha a sua disposizione una ricca raccolta di articoli proprio in merito alla tematica in esame in questa sede. Di particolare importanza poi si rivelano nuovamente la raccolta di saggi per merito del SESM ed il testo di Lidia Falcón, entrambi contenenti dati dettagliati sull’associazionismo femminile in particolare dell’epoca franchista e di quella immediatamente successiva. In tali elaborati si sono incontrate riflessioni anche profonde in merito alle connessioni fra la situazione politica del Paese ed i suoi risvolti nella vita pratica e quotidiana, nonché sulla percezione del proprio ruolo delle donne stesse, nonché del resto della società. L’approfondimento degli argomenti presentemente trattati si rivela fondamentale per poter confermare (o confutare) la tesi di partenza, che verrà sviluppata nel quarto capitolo, secondo la quale la letteratura appunto può essere considerata uno specchio della realtà nella quale viene prodotta o anche essere essa stessa utilizzata come strumento per accentuare determinati comportamenti all’interno di quella realtà stessa della quale si auspica con i primi tre capitoli di riuscire a fornire un quadro generale completo.
3.2 La scuola: primo percorso di emancipazione
L’utilizzo del Codice Civile Napoleonico, che come si è visto riguarda gli anni a cavallo fra il secolo XIX e XX, manifesta perfettamente in materia di diritti e doveri riservati alle donne l’idea della naturalizzazione, comune a tutte le fasce sociali, da quella povera, contadina e illetterata all’alta borghesia, ben più colta e con maggiori strumenti critici a sua disposizione. Questo sta a significare che a giustificare la discriminazione di genere perpetrata c’è la convinzione che la donna debba essere madre, moglie, custode della casa e del mondo intimo e domestico, in una condizione di passività e sottomissione, in virtù del fatto che questo è il suo ruolo biologico, assegnatole dalla natura stessa. All’uomo invece, assecondando questa convenzione, vengono designati i compiti più pratici e quelli di competenza della sfera pubblica. Nel diciannovesimo secolo quindi, alla donna sono preclusi tutti i canali emancipatori riservati all’uomo, come l’accesso alla vita politica e all’attività economica. Inoltre il suo valore personale viene socialmente riconosciuto in conseguenza di quello del marito, del padre, dei fratelli o dei figli, pertanto questo la porta a relazionarsi solamente con il proprio contesto familiare e ad isolarsi rispetto alle altre donne, con le quali non ha la possibilità di confronto e nemmeno, ovviamente, di associazione. (Flecha García 1996: 20). L’opinione comune è che la donna debba ricevere anche un’educazione differente da quella dell’uomo, concentrata cioè su ciò che riguarda i sentimenti, la formazione della personalità, le buone maniere. Nella Spagna a cavallo tra i due secoli c’è un tasso di analfabetismo elevatissimo rispetto alla media europea, soprattutto nelle aree rurali, dove sia gli uomini che le donne svolgono lavori manuali nei campi. In aggiunta, il contesto nazionale del periodo è fortemente influenzato dalla presenza della Chiesa cattolica, come fra gli altri pone in evidenza anche lo studio svoltosi presso l’Istituto Parque de Lisboa da Beatriz Pérez e Rebeca Muñoz (2001). Tale condizionamento colpisce soprattutto le donne, inculcando loro il valore della verginità fino al matrimonio e la convinzione che il destino a loro riservato sia appunto quello di madri e di spose. Il modello maschile che invece prende piede è sempre più distaccato da quello ecclesiastico, riflettendo la mentalità laica in rapida diffusione e corrisponde ad una figura dinamica, propositiva, curiosa e reattiva nei confronti di tutto ciò che costituisca un’innovazione. Tuttavia l’uomo laico stesso generalmente appoggia il modello di femminilità proposto dalla Chiesa, molto più restrittivo, ma ad egli funzionale come garanzia di obbedienza, sottomissione e fedeltà (Pérez e Muñoz 2001). L’accesso all’università, l’istituzione che forma i futuri dirigenti politici ed economici del paese, nonché gli intellettuali, continua quindi a rimanere negato alle donne. Un modo di dire molto comune dell’epoca ad esempio, spesso citato dalla stessa Carmen Martín Gaite, recita mujer que sabe latín no puede tener buen fin: questa espressione sta a significare che la donna istruita non attira sguardi favorevoli, creerà sicuramente problemi innanzitutto a se stessa, in secondo luogo anche alle persone che le stanno intorno. Troppa sapienza in una donna viene socialmente riconosciuta come nociva, poiché portatrice di contenuti in grado di destabilizzare l’animo femminile, le cui caratteristiche peculiari secondo questo ragionamento sono la dolcezza, la debolezza, la tenerezza. Non solo, come riporta la docente Consuelo Flecha García (1996), vi è un pregiudizio diffuso anche fra luminari ed intellettuali secondo i quali il sapere è prerogativa prettamente maschile, tanto che nel corso del Congreso Pedagógico Hispano-Portugués-Americano si arriva ad affermare che possono accedervi unicamente le donne che rinuncino alla propria natura femminile, che le prevede dedite alla cura dell’ambiente domestico, oppure quelle che abbiano dei tratti caratteriali e delle spiccate tendenze maschili (Flecha García 1996: 23). Di fronte ad un contesto del genere è facile immaginare le difficoltà ed i pregiudizi contro i quali si trovano costrette a rapportarsi quotidianamente tutte coloro che sperano in un miglioramento della propria situazione economica, sociale ed intellettuale, investendo tempo, energie, denaro e a questo punto anche il proprio prestigio per poter migliorare la propria formazione. Con l’avvento del progresso sociale ed economico tuttavia, alcune donne, soprattutto quelle non sposate o vedove della classe media, reclamano il diritto ad avere una propria fonte di sostentamento, sfruttando il sapere acquisito dagli studi effettuati. Dato l’elevato tasso di maschilismo nella società infatti, come già ricordato, si continuano a mantenere le donne, nonostante i cambiamenti in atto, isolate da tutto ciò che non rientri nella sfera del privato e del domestico. Un interessante intervento per esempio è quello di Joaquín María Sanromá, deputato e docente all’Università di Barcellona, che illustra chiaramente le posizioni del Paese su questa tematica. Il cattedratico parla di una società frammentata, dove la donna viene vista come “un tipo raro y excéntrico en todas las cosas serias y dignas que estén fuera de la vida doméstica” (Sanromá 1869 citato in Flecha García 1996: 26). Come si evince dalle sue parole e da quanto sinora esaminato pertanto, la risoluzione della problematica circa il difficile accesso delle donne al mondo lavorativo oltre un certo grado di specializzazione e prestigio e nel mondo accademico in generale, prevede, per giungere a buon fine, lo stravolgimento delle convenzioni (e convinzioni) che sino ad allora la impediscono. I fattori già nominati che si ritengono colpevoli del forte isolamento esercitato su più di metà della popolazione, cioè la povertà di gran parte di essa, l’analfabetismo, l’ignoranza, il maschilismo e l’ideologia cattolica richiedono tempistiche piuttosto lunghe per essere sradicati. Essi infatti normalmente si estinguono, a fronte di una forte volontà di cambiamento, nell’arco di diverse generazioni, in quanto si tratta di modificare la percezione del mondo e dei valori di un intero paese; nel caso spagnolo in particolare inoltre, si tratta di stravolgere una tradizione di pensiero vecchia di secoli e supportata da un’istituzione forte ed influente quale la Chiesa cattolica. Le uniche scuole che offrono in quel periodo l’opportunità alle ragazze di proseguire gli studi sono le Normales de Maestras, istituzioni pubbliche adibite alla formazione del futuro corpo docente femminile per l’insegnamento elementare. Esse sono distribuite nei centri più importanti del territorio ed il loro operato è accompagnato da quello di altri enti, questa volta privati, sempre con lo scopo di fornire una formazione specifica alle donne. A questo gruppo appartiene per esempio la prestigiosissima Escuela de Institutrices la quale, sempre nei limiti del sentire comune che si limita ad intendere questo tipo di istruzione finalizzato al buon svolgimento del ruolo preparatorio e di accompagnamento dei futuri uomini del Paese che per natura è assegnato alla donna, è quella in grado di fornire alle sue allieve gli strumenti più completi per il loro futuro professionale. Grazie al diffondersi delle idee introdotte dal liberalismo però, si iniziano ad allargare i limiti dell’istruzione che impediscono loro la completa formazione fino al livello accademico e nel 1910, come illustrato nel precedente capitolo, sottoparagrafo 2.2.1, a seguito di numerosi dibattiti e riformulazioni da parte del Consejo de Instrucción Pública cui fanno da cornice le pressanti richieste delle donne interessate, si concede finalmente ufficialmente l’accesso al mondo accademico e la possibilità di esercitare la professione che deriva dal percorso di studi effettuato. Il lavoro è invece ancora una nota dolente sulla strada verso l’emancipazione, salvo i pochi casi fortunati legati ad una formazione universitaria, accessibile per ragioni economiche solamente ai ceti più abbienti ed è in ogni caso osteggiata dalla chiusura della mentalità dell’epoca. La società spagnola, di fatto, continua a considerare marginale il lavoro femminile al di fuori delle mura di casa, che costituisce l’ultima risorsa e solo in casi estremi, come quelli delle donne sole che non hanno altri mezzi di sostentamento. Inoltre esso di norma è remunerato meno che quello dell’uomo, come ulteriore disincentivo per coloro che volessero ricorrevi. Come riportato dalla ricerca di Pérez e Muñoz (2001) prende rapidamente piede in aggiunta il lavoro clandestino, sottopagato e spesso anche vero e proprio sfruttamento della forza lavoro femminile. Per via della rapida crescita industriale i settori interessati all’aumeno di mano d’opera sono, soprattutto nei grandi centri urbani come Madrid e Barcellona, quelli del tessile, degli alimentari, della chimica e del servizio domestico, quest’ultimo più sfruttato degli altri. In conclusione, si ribadisce quindi che nel passaggio tra il ventesimo secolo ed il precedente la mobilitazione femminile nella lotta per ottenere maggiori libertà, riconoscimenti e diritti è principalmente sostenuta da coloro che hanno i mezzi economici per poter proseguire negli studi. È proprio sul piano dell’ottenimento della parità con l’uomo di tali diritti che questa battaglia si svolge, producendo un ottimo risultato per l’epoca, cioè l’accesso all’istruzione universitaria accompagnato dalla possibilità di esercizio delle professioni per le quali si è conseguito il titolo accademico. Si aggiunge inoltre che tali donne sono più sensibili rispetto a quelle delle classi inferiori alle tematiche di genere, provenendo da un contesto dove i principi del liberalismo si stanno facendo strada. Per contro nella società spagnola in generale e quindi anche in un’ampia fascia di sue rappresentanti di sesso femminile la possibilità di una maggiore emancipazione della donna non viene accolta di buon grado, scontrandosi con una mentalità chiusa e conservatrice, significativamente permeata dalla morale cattolica che la vuole invece come angelo del focolare dedita alla cura del marito e dei figli.
3.3 Conseguenze sociali del nuovo ordinamento nella Seconda Repubblica
Sul piano pratico la nuova immagine della donna proposta mediante la Costituzione del 1931 si scontra con la realtà culturale spagnola del periodo, permeata di moralismo cattolico e di maschilismo, fatta eccezione, come risulta dalle statistiche dell’epoca, per i grandi centri urbani ed in maggioranza fra l’elettorato di sinistra. Desta infatti grande scalpore l’idea di una donna che non solo lavora al pari degli uomini, ma che addirittura percepisce un salario, soprattutto se la donna in questione è sposata. Si tratta di una problematica che coinvolge la società spagnola nel suo insieme, indipendentemente dall’appartenenza politica o sociale. La ragione principale dell’attaccamento quasi viscerale che la popolazione spagnola nutre nei confronti dei valori tradizionali, i quali prevedono una donna dedita principalmente al ruolo di madre e alla cura del proprio uomo, della famiglia e, in definitiva, del focolare domestico, va ricercata ancora una volta nella storia. Storia che è stata accompagnata per secoli, soprattutto nelle aree rurali che si estendono su gran parte del territorio, dalla forte presenza della Chiesa. Essa infatti, oltre che agli interessi prettamente economici e di potere che la legano alla monarchia Spagnola, incarna perfettamente e contemporaneamente promuove un modello di famiglia estesa e patriarcale, nel quale il contadino medio si riconosce perfettamente anche per ragioni pratiche e funzionali allo svolgimento della propria attività quotidiana. In base a questo modello la donna innanzitutto è per l’appunto madre e custode dell’educazione dei figli, oltre che l’angelo della casa e la fedele e pura compagna dell’uomo. Nonostante la presenza nel governo di due rappresentanti del sesso femminile, Victoria Kent e Clara Campoamor, deputate rispettivamente per i radical-socialisti e per i radicali, si presenta piuttosto ostile anche la reazione del mondo politico, che riflette appieno il disorientamento del paese di fronte alle tematiche di genere, poste in primo piano dai cambiamenti costituzionali verificatisi. Se da un lato infatti l’articolo 46, introducendo il diritto di voto per le donne garantisce al paese il raddoppio dell’elettorato rispetto alla prima repubblica, dall’altro solleva polemiche e perplessità. Nella fattispecie i socialisti e i radicali con l’espressione "las mujeres están sometidas al cura" (Lobelos, Borreguero 2001) manifestano scetticismo nei confronti delle potenziali elettrici, a detta loro in balìa della volontà dei preti e quindi della Chiesa. Si tratta di un luogo comune diffuso in un paese cattolico come la Spagna di allora dove, come più volte ripetuto nel corso del presente lavoro, le donne, per lo più relegate all’ambito domestico, passano parecchio tempo dedicandosi alla religione, andando a messa e a confessarsi. Da questo stretto contatto tra i parroci e le proprie parrocchiane nasce quindi la convinzione in questione, secondo la quale esse seguano alla lettera i consigli dei preti per preservare la moralità loro e della propria famiglia. Altrettanto curiosa è la reazione dei repubblicani che ci riportano le studiose Manuela Lobelos e Yolanda Borreguero (2001). Secondo appartenenti e simpatizzanti di questo orientamento politico infatti le donne, in quanto soggette più degli uomini a repentini sbalzi emotivi, dovrebbero accedere alle urne solamente dopo la menopausa. Se gli stessi partiti di sinistra, per antonomasia più sensibili alle problematiche sociali, accolgono tanto duramente l’ingresso femminile nella vita pubblica, non da meno sono le reazioni nella destra, che in questo periodo, non essendo al governo, è quanto mai compatta. Il supporto le viene fornito in larga misura dalla Chiesa, che si oppone alle riforme mediante lettere pastorali e dichiarazioni pubbliche e dall’esercito, penalizzato dalle stesse e la cui ostilità sfocerà ben presto, come documentato nel capitolo precedente, in congiure e tentativi di colpi di Stato, ultimo quello in cui è coinvolto Francisco Franco. In questo scenario non c’è dunque da stupirsi di fronte alla strumentalizzazione del ruolo femminile posto in essere dalla destra. Di destra infatti, più precisamente di natura monarchica, sono le operazioni atte a sfruttare a proprio vantaggio l’elettorato in rosa, mediante l’organizzazione di manifestazioni ed associazioni femminili volte ad incrementare il consenso nel paese. A tale scopo per esempio vengono organizzati i cortei a favore di Gil Robles, nasce nel 1932 il gruppo Acción Católica y Femenina e vengono pubblicati giornali e riviste i cui contenuti esortano la donna a dedicarsi alla famiglia e alla cura dei prigionieri. Queste donne antirepubblicane rifiutano di rispettare la nuova Costituzione e spesso sono per questa ragione perseguite ed incarcerate, ottenendo però ulteriori simpatie di fronte al paese, allargando il dissenso nei confronti dell’ordine costituito. Si può di conseguenza affermare che nonostante l’evidente apertura verificatasi durante la Seconda Repubblica a livello legislativo nei confronti della popolazione femminile, le discriminazioni rimangono soprattutto sul piano culturale e necessitano di profondi cambiamenti nella mentalità del paese, donne incluse, per poter essere definitivamente cancellate.
3.4 La Guerra Civile: più libertà per le donne'
A seguito del malcontento provocato nella parte più conservatrice del paese dalla politica del governo della Seconda repubblica, si verifica infine il colpo di stato del 1936, identificabile anche come l’anno di inizio della sanguinosa Guerra Civile Spagnola. Si tratta ovviamente di un contesto sociale molto duro e violento, che però paradossalmente permette a tutte le donne, di qualsiasi colore politico, di ritagliarsi un maggiore spazio decisionale e di darsi dei ruoli sino ad allora impensabili.
3.4.1 Le organizzazioni femminili antifasciste
Eclatante è il caso di Madrid, dove le repubblicane indossano la tuta da operaio, il “mono azúl”, non solo per partecipare alle manifestazioni antifasciste, ma anche per le attività quotidiane. Il valore simbolico di tale abbigliamento rappresenta appieno l’immagine di una donna forte, pratica, indipendente, che lotta esattamente come gli uomini per l’ideale repubblicano e che si emancipa dallo stereotipo della brava casalinga, moglie e madre, uscendo dal consueto isolamento domestico. In tutto il paese le donne dunque partecipano attivamente alla vita pubblica, chi assistendo i feriti, chi rifornendo i soldati di vivande e di abiti, chi addirittura combattendo in prima fila accanto a loro, in totale contrapposizione rispetto al ruolo che sino ad allora hanno ricoperto. Le donne diventano parte attiva all’interno dei vari partiti politici esistenti, creando sezioni femminili che, oltre che sostenere il partito stesso, si occupano di alcune specifiche tematiche di genere. Nel dettaglio, come ricorda lo storico Marcello Fascella, tali associazioni femminili sono la Unión de Dones de Catalunya, la UDC, comunista e antifascista così come la Agrupación de mujeres antifascistas, nota come AMA. Di fede anarchica invece sono le appartenenti al gruppo Mujeres Libres, seguite infine, dalle marxiste dissidenti del POUM, Partido Obrero de Unificación Marxista (Marcello Fascella, www.romacivica.net/antifascismo/Guerraspagna20.htm). Osserva ancora Fascella che queste organizzazioni, in particolare quelle di fede anarchica e comunista, oltre che l’obiettivo comune antifascista, hanno anche quello di emancipare la figura femminile all’interno del contesto sociale, mediante
l’educazione, la partecipazione politica, il diritto al lavoro, e il riconoscimento del loro valore sociale (…) mete primordiali di un programma femminile collettivo. (…)Dopo il 1937 la creazione dell’esercito regolare, e la scomparsa delle milizie, non permise la partecipazione delle donne alla resistenza armata. L’educazione e la cultura erano considerati due fattori importanti per la liberazione delle donne e si convertirono nelle mete primordiali di un programma femminile collettivo. Tutti i gruppi femminili si occuparono dell’analfabetismo di migliaia di donne spagnole e affrontarono insieme la domanda urgente di programmi educativi per adulti. Le donne istruite diedero lezioni ed organizzarono attività culturali e artistiche così come servizi di biblioteca per adulti. L’educazione e l’arricchimento culturale delle donne furono grandi conquiste del movimento femminile durante la guerra e la rivoluzione spagnola. (Fascella: www.romacivica.net/antifascismo/Guerraspagna20.htm)
Come si deduce da quanto riportato le donne e le varie organizzazioni femminili antifasciste sorte in quel periodo comprendono l’importanza della cultura e della conoscenza ai fini della propria accettazione e rispetto da parte di una società che sino a qualche anno prima si è rivelata fortemente discriminante e maschilista e si adoperano in svariate iniziative al fine di migliorare tale società. Non potendo dedicarsi all’attività militare, quindi, si impegnano fortemente per diffondere l’alfabetizzazione, piuttosto scarsa all’epoca e per istruire non solo i minori, ma anche l’ampia porzione di popolazione adulta digiuna delle nozioni scolastiche più basilari. Continua poi Fascella ricordando la creazione di svariati periodici a carattere politico-culturale, quali Companya, Emancipación, Muchachas, Mujeres, Mujeres Libres, Noies Muchachas, Pasionaria e Trabajadora, nei quali si affrontano temi normalmente preclusi alle donne come la rivendicazione del diritto al lavoro femminile, alla preparazione professionale, al salario garantito ed alla stabilità del proprio posto di lavoro, oltre che alla parità di trattamento rispetto ai colleghi uomini. Lo storico infine riporta un ultimo tema fortemente dibattuto durante quegli anni e cioè quello della prostituzione e dello sfruttamento sessuale in funzione del quale le varie organizzazioni femminili elaborano addirittura
una riforma sessuale che prevedeva l’aborto, il divorzio, e l’assistenza medica sanitaria gratuita. (Fascella: www.romacivica.net/antifascismo/Guerraspagna20.htm).
Risulta pertanto evidente, in conclusione, una partecipazione estremamente attiva e costruttiva da parte delle donne repubblicane alla vita sociale e politica durante il periodo della Guerra civile, ricco di iniziative volte a migliorare le condizioni di vita femminili, a partire dall’istruzione, passando attraverso il lavoro per arrivare persino a toccare argomenti delicati come l’aborto e la prostituzione, considerati quasi dei tabù per la cattolicissima Spagna dell’epoca. Un ulteriore punto di interesse, tuttavia, è costituito dal fatto che non sono solamente le donne antifasciste, certamente numerose e di ogni estrazione sociale, a partecipare a questa nuova apertura alla vita pubblica, ma anche le donne più conservatrici si impegnano attivamente al fianco dei propri compagni uomini promuovendo anch’esse le proprie iniziative ed i propri ideali.
3.4.2 La Falange e le sue donne
Sinora si è approfondita, grazie al prezioso apporto costituito dalla documentazione storica raccolta dall’ANPI, la presa di posizione di buona parte delle donne repubblicane, in opposizione cioè a quella parte di esercito che ha provocato con il proprio colpo di stato il conflitto in atto. Sarebbe tuttavia di scarsa utilità ai fini del presente lavoro limitarsi a quest’unica realtà, per quanto variegata e diversificata, senza soffermarsi anche sulla già citata controparte a favore dei afutori del colpo di stato militare. Negli stessi anni, infatti, come documenta la studiosa di tematiche femminili Lidia Falcón, più precisamente il 29 ottobre 1933, nasce la Falange Española, che più tardi si unirà con le Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista, andando a formare la Falange Española y de las JONS, partito profondamente conservatore e tradizionalista. Il suo maggiore teorico è José Antonio Primo de Rivera, primogenito di quel Primo de Rivera che solamente qualche anno prima, mediante un colpo di stato, si è autoproclamato a capo della nazione (Falcón 1969: 271). Secondo la visione Joseantoniana, che riflette quella della parte più conservatrice del paese, la donna non è adatta a combattere, essendo per sua stessa natura incompatibile con l’uso della forza e della violenza, ma al contrario può essere di grande ausilio a tutte le attività maschili, guerra inclusa. Nel 1934 nasce la sezione femminile del partito, la Sección Femenina, con l’obiettivo di effettuare opere di propaganda, di soccorso ai feriti, di assistenza ai detenuti ai quali le sue iscritte portano di nascosto cibo, tabacco, lettere, fingendosi sorelle, madri e fidanzate per poter accedere al carcere. Si dedicano inoltre alla cura delle famiglie dei caduti e alla ricerca di fondi per il sostentamento del proprio operato. Fondatrice e a capo della Sección Femenina c’è Pilar Primo de Rivera, sorella di José Antonio, fortemente motivata a sostenere gli ideali promossi dalla Falange. Pilar rappresenta il perfetto modello della femminilità proposta dai conservatori: come ci ricorda la stessa Falcón
Las mujeres falangistas ya tenían una tarea definida. Lavado de ropa, comida, flores y sonrisas. También podían encargarse de las cuestiones para recaudar los fondos precisos a la organización (Falcón 1969: 293).
Dalle parole della studiosa viene confermata quella che è la tendenza della parte del paese più conservatrice, radicata nella dottrina cattolica e fermamente convinta della necessità di una netta divisione dei ruoli. L’immagine della donna proposta dalla Falange infatti corrisponde a quella di angelo del focolare, madre premurosa e fedele compagna, la cui virtù principale è l’abnegazione nei confronti dell’uomo. Queste stesse idee, con la vittoria del franchismo ufficializzata nel 39, vengono ulteriormente sviluppate ed addirittura tutelate a livello giuridico dal regime.
3.5 Le donne di Franco
Con l’insediamento definitivo di Franco, nel 1939, tutte le donne appartenenti a movimenti antifascisti o semplicemente simpatizzanti repubblicane ritornano nell’ombra precedente la Seconda Repubblica. Questo poiché il nuovo regime desidera cancellare qualsiasi traccia delle libertà conquistate, cominciando proprio con la tanto dibattuta legge sul divorzio. Chi manifesta il proprio dissenso, come esposto nel primo capitolo del presente elaborato, soprattutto nella fase repressiva immediatamente successiva alla Guerra Civile, viene perseguito ed esiliato, incarcerato, torturato, giustiziato. Nessuno parla più di ciò che è accaduto durante la Seconda Repubblica, ogni pericoloso ricordo delle libertà ottenute viene sepolto, distrutto. Trascorre così più di un ventennio durante quale, terminata la repressione, l’unico modello di donna concepito è quello rappresentato dalla Sección Femenina della Falange. Si tratta di una donna devota al marito e ai figli, fedele, cattolica, portatrice di tutti quei valori universalmente riconosciutile nel sistema spagnolo, vale a dire la delicatezza, la dolcezza, l’abnegazione, la gentilezza, la sensibilità.
Andando ad analizzare la storia personale di Franco si può ritrovare una motivazione familiare molto concreta in merito alla linea presa nei confronti delle donne: sua madre, infatti, è abbandonata dal marito quando i figli sono ancora piccoli ed il Generalissimo subisce un trauma che fa ad influire sulla formazione della sua personalità. Per questo le direttive da lui promosse in merito al diritto privato tutelano l’unità familiare allo stremo, tanto che venendo dichiarata nulla la legge sul divorzio le coppie separate sono costrette a riunirsi. Il cattolicesimo che il regime appoggia e che è appoggiato dal regime, considerato una fonte d’ispirazione per la moralità dei cittadini spagnoli, sarebbe secondo questo punto di vista uno strumento molto funzionale al desiderio del dittatore, che prima di tutto è sempre un militare, ordine e stabilità al “suo” popolo. Ecco quindi spiegata la ragione dell’esaltazione della donna pia e devota, la quale attenendosi agli insegnamenti della propria religione fornisce la garanzia della propria fedeltà al marito e alla famiglia. Lo stesso termine femminista viene bandito in quanto ritenuto dispregiativo nei confronti delle donne. Il presente paragrafo consta a sua volta di due sottoparagrafi, uno incentrato sugli anni immediatamente successivi la guerra civile, caratterizzati dall’imposizione del più totale rigore e l’altro, il secondo, che invece svela i cambiamenti che cominciano ad avere luogo in seguito alle prime contestazioni femministe e che determinano un progressivo miglioramento della condizione sociale della donna, fino al suo quasi completo riconoscimento come cittadina. Ben lungi dal voler segnare una netta divisione temporale, considerata poco veritiera in relazione ai fatti trattati, che invece fanno parte di un lento processo carico di sfumature e di situazioni affini e divergenti, si è ritenuta più pratica la scelta di evidenziare per ciascuno dei momenti trattati i punti salienti e le peculiarità più significative, al fine di rendere maggiormente ordinata la sequenza logica e cronologica di quanto esposto.
1. La postguerra attraverso la finestra di casa
Appena terminata la Guerra Civile si apre in Spagna un’epoca di forte censura, nonché di esaltazione e assoluta devozione del potere instauratosi. La censura comincia nel nucleo centrale della società stessa, la famiglia. La Gaite afferma che addirittura i confessori del periodo ordinano alle fedeli sotto la propria guida di non parlare degli eventuali inganni e tradimenti del marito, di salvaguardare le apparenze, di preservare i figli dando loro comunque un modello corretto da seguire, anche se tale modello non rispecchia la verità dei fatti (Gaite 1987: 21). La famiglia infatti sia per la morale cattolica che per il regime rappresenta un punto di riferimento essenziale per la formazione morale ma anche ideologica dell’individuo. Questa istituzione va quindi tutelata come non mai, soprattutto adesso che quello che è essenziale per il franchismo è la solidità delle proprie basi, da costruire su una popolazione solida, rispettosa dell’ordine costituito, obbediente ad esso e portatrice dei valori promossi dalla Falange. La censura da parte del governo in aggiunta non si limita alla sfera privata ma prevede anche la cancellazione totale dalla memoria storica degli spagnoli di tutte le libertà conquistate in ambito legislativo durante la Seconda Repubblica e degli usi e costumi ai quali queste libertà preludono.
La donna ovviamente è quella che subisce maggiormente le limitazioni imposte dalla nuova situazione politica, risentendo fortemente degli effetti della retorica franchista. Di quegli anni è l’espressione mujeres muy mujeres con la quale si suole definire il gentil sesso spagnolo, rappresentante nel mondo dell’autentica femminilità. La cura dell’immagine femminile assume un’importanza basilare, in quanto le donne sono il pilastro della famiglia, le sue custodi e adepte principali. Si avvia pertanto un processo di innalzamento del suo ruolo più tradizionale e casalingo, proposto come una alternativa realmente innovatrice, a dispetto dei costumi che si stanno diffondendo in occidente, ben più libertini di quelli iberici, diretta conseguenza della modernità. La stessa moglie di Franco, Doña Carmen, rappresenta il prototipo ideale di questo modello tradizionale: dedita al proprio uomo e alla propria famiglia, riservata, pacata e sempre sorridente, senza alcun interesse per tutto ciò che riguarda il sociale e la politica, in totale antitesi con coloro che aspirano ad una maggiore libertà, additate come supponenti, snob e superficiali (Gaite 1987: 27-28). Il sorriso della donna è rivestito di importanti significati: esso rappresenta l’immagine della tranquillità e della serenità familiare, il dolce conforto per la fatica dell’uomo, il quale nell’ambito domestico fra le attenzioni della sua donna può godere del cosiddetto reposo del guerrero, meritato premio al rientro dalle sue dure giornate. Specialmente negli anni immediatamente successivi il conflitto civile non è inusuale incontrare figure femminili vestite di nero, dall’espressione triste e rassegnata: sono le fidanzate il cui futuro sposo ha perso la vita: sono identificate con l’appellativo di novias eternas verso le quali la gente prova un profondo rispetto, dato che non sono state abbandonate dal proprio fidanzato e neppure sono sole perché nessuno le vuole, bensì Dio stesso ha preso con sé il loro uomo, lasciandole nel lutto (Gaite 1987: 44).
L’autrice, oltre a quello della sposa perfetta, madre di famiglia e compagna fedele, individua altri modelli di femminilità tollerati dal regime, ai quali le ragazze possono aspirare, primo fra tutti quello di suora. La devozione religiosa è infatti socialmente riconosciuta quale ottima alternativa a quella riservata alla famiglia in quanto anch’essa espressione della sobrietà e della morigeratezza di costumi tanto decantata dalla propaganda falangista. Non bisogna inoltre dimenticarsi della pesante influenza del cattolicesimo nella penisola iberica, la cui presenza talvolta soffocante è ulteriormente incentivata grazie all’appoggio che la Chiesa fornisce al regime. La vocazione religiosa porta in sé qualcosa di mistico, di puro, di santo, una sorta di elevazione morale che libera la persona dai desideri e dalle passioni, permettendole di dedicarsi all’elevazione della propria anima. Come ricorda nel suo saggio la sessa Gaite in aggiunta, farsi monaca significa prendere una decisione, disobbedire spesso anche al volere della famiglia che pianifichi per lei un destino di sposa e di madre, ma si tratta di una disobbedienza legittimata dal contesto storico e sociale, di una scelta di vita prestigiosa, alla quale nemmeno la famiglia ha il potere di opporsi (Gaite 1987: 37). Votarsi ad una vita religiosa, dunque, o meglio, avere la vocazione che porta come diretta conseguenza dedicarsi ad una vita all’interno dell’ordine religioso, è addirittura di gran lunga preferibile al rimanere sola, secondo quanto documentato dalla fonte. Coloro che non riescono a trovare marito e che non hanno vocazione, infatti, sono spesso derise ed etichettate con il dispregiativo aggettivo di solteronas, zitelle. Le ragazze in età da marito o da fidanzato sono spesso consigliate da familiari e parenti di comportarsi con i propri eventuali pretendenti in maniera gentile, affabile, disponibile, spensierata e fiduciosa, per evitare di essere additate come persone strane e sgradevoli, poco raccomandabili per una vita di coppia. Fin dalla giovinezza pertanto la ragazza è oggetto di un pressante bombardamento di indicazioni e di modelli da seguire per non rimanere sola nella vita, posto che, a parte il matrimonio, l’altra unica alternativa ad un destino da zitella è rappresentata dal farsi suora.
A differenza dei solterones, gli uomini non sposati, la donna che persegua tale scelta di vita più o meno obbligata è infatti spesso etichettata come una persona dal pessimo carattere, strana, di poca compagnia, sgradevole, troppo pensierosa, polemica. La Gaite riporta un’espressione in uso in quegli anni, tener complejos, ossia avere complessi, tormenti dell’anima, tristezza, paranoie, frustrazioni, insicurezze. Con tale perifrasi ci si riferisce anche a quelle donne che non vivono in totale serenità la loro condizione di (futuri) angeli del focolare e custodi dell’armonia domestica, ma che si pongono delle domande sul senso della propria condizione personale e del proprio ruolo sociale, che parlano di politica, che leggono, che non si sentono realizzate all’interno del proprio contesto. Secondo i ricordi della scrittrice, che ha vissuto quegli anni in prima persona, si tratta proprio di quel tipo di donna che gli uomini disdegnano, ricercando invece la semplicità, la serenità, il sorriso ingenuo e fiducioso nel volto della propria futura compagna. Ecco perché alle fanciulle si insegna presto a non sembrare strane e ad essere accondiscendenti, per non venire rifiutate dagli uomini. Questi ultimi al contrario non sono bersaglio della derisione né quantomeno della commiserazione per da parte della società, anzi, è assolutamente normale che un uomo rimanga scapolo o che si sposi ad un’età superiore rispetto a quella della donna, andando a costituire una ulteriore spia della forte discriminazione tra i sessi presente nella cultura della postguerra.
C’è infine anche un rovescio della medaglia, un tipo di donna disprezzato e insieme temuto, colei che non rispetta le regole, che osa con il suo comportamento ribellarsi e mettere in discussone le convenzioni ed andare oltre i confini a lei riservati. Questo ultimo gruppo è quello delle ragazze Topolino, normalmente apparteneti alla media borghesia, molto alla moda, frequentatrici di locali e piuttosto disinibite. Il soprannome deriva dalla celebre macchina della Fiat, molto in voga in quegli anni, e compare per la prima volta in una striscia fumettistica satirica del settimanale La Codorniz, nel 1941 (Gaite 1987:74). Come ricorda la scrittrice, per il comune sentire si tratta, nel caso delle ragazze in questione, di un comportamento poco raccomandabile e ai limiti della decenza, basti pensare che, per esempio, anche solo il fatto di fumare per una donna è comunemente ritenuto scandaloso.
Alla luce di quanto riportato dal saggio della celebre autrice, testimone diretta e per questo fonte autorevole a proposito del modello sociale degli anni del dopoguerra spagnolo, si pone l’evidenza sulla netta inversione di tendenza che ha luogo come conseguenza dell’instaurarsi del nuovo regime. La donna, infatti, perde immediatamente le poche libertà comportamentali, oltre che civili, conquistate negli anni della Seconda Repubblica e della Guerra Civile, tornando ad essere la custode dello spazio familiare e privato. Non solo, la sua figura acquisisce nuovamente un senso compiuto solamente in funzione di un marito, di un uomo che le dia la possibilità di esercitare quel ruolo di moglie e di madre che la società da per scontato essere l’unico realmente di sua competenza.
3.5.2 Gli anni 60 e le lotte femministe
I primi cambiamenti di questa situazione si hanno attorno agli anni 60, quando il regime, all’inizio della fase tecnocratica, mostra segnali distensivi nei confronti della libertà di espressione, dettati dall’esigenza di riuscire progressivamente ad integrarsi nel contesto europeo, dal quale non può più ancora lungamente prescindere dato l’andamento economico a livello nazionale ed internazionale. Le vicende spagnole si intrecciano col diffondersi in tutto l’occidente del movimento femminista favorito anche dal nuovo clima che s’impone durante il movimento del Sessantotto. Interviene inoltre la nascita dei movimenti femministi stranieri, primo di tutti quello britannico, che chiedono a gran voce il rispetto dei diritti delle donne e l’ottenimento della parità dei sessi. Tuttavia, come ricorda Cristina Ruíz Guerriero,
El femminismo en la España contemporánea renace vinculado a los partidos y sindicatos de izquierdas, lo que le da un carácter muy conflictivo. La subordinació de la lucha feminista a la política crea tensiones y polémicas dentro del feminismo que se debilita en discusiones entre la única o doble militancia (Ruiz Gurerrero 1997: 149).
Si ripresenta quindi nelle parole dell’autrice la stessa tendenza verificatasi già durante la guerra civile, cioè la politicizzazione del movimento femminista, stavolta limitato alle sinistre e ai sindacati. La Guerriero parla anche di tensioni all’interno di quesi gruppi femministi, causate dalla subordinazione delle tematiche di genere rispetto a quelle politiche, in parte tuttavia giustificabile con la situazione del Paese, ancora sotto dittatura al momento dei fatti narrati. Si intende comunque come un segnale di cambiamento questa rinnovata visibilità che progressivamente le donne riescono a recuperare, ricordando al Paese la propria esistenza e specificità rispetto all’uomo, con le problematiche ad esse connesse.
A partire dagli anni 60, inoltre, aumenta il numero delle donne che accedono all’educazione formale, come conseguenza dello sviluppo economico, che richiede un incremento del capitale umano, donne incluse. Le donne più colte, inoltre, cioè coloro le quali hanno potuto beneficiare della propria posizione sociale elevata nei decenni precedenti per giungere ad un ottimo livello di educazione, forniscono il proprio apporto individualmente o in piccoli gruppi pubblicando articoli e libri di testo inerenti le tematiche di genere. Un’esponente piuttosto rappresentativa di questa categoria di donne emancipate è María Lafitte, la condesa de Campo Alange, la quale fonda il SESM, Seminario de Estudios Sociológicos de la Mujer, gruppo di studiose il cui operato è finalizzato all’indagine sulle tematiche di genere, il quale si rivela fonte di preziose informazioni anche per il presente elaborato. Per quanto riguarda la maggior parte della popolazione però, come ricorda nel suo saggio Inés Alberdí (1986) si continua ancora a parlare di attitudine sessista all’interno delle famiglie e l’esempio più classico sono i giochi dell’infanzia, bambole per le bambine e macchinine per i bambini, che denotano una tendenza spesso inconsapevole a preparare i più piccoli ai ruoli che avranno una volta raggiunta l’età adulta (Alberdí 1986: 76). Un altro esempio ci viene dato dai libri di testo scolastici che ancora nel 1986 si avvalgono di immagini e convenzioni che richiamano e danno ulteriore validità al modello familiare sopra citato. Ciononostante, come ricordano le studiose del SESM (1986), nella fascia di tempo che va dal 1960 al 1974 compaiono timidamente i primi accenni di un cambiamento in corso, fra cui la nascita del gruppo femminista MDM e dello stesso SESM, la pubblicazione di testi di scrittrici donne, la traduzione di due opere fondamentali del femminismo cioè La mística de la femininidad di Betty Friedan e El segundo Sexo di Simone De Beauvoir, grandi teoriche nonché esponenti del femminismo internazionale. Anche sul piano legislativo si registrano importanti miglioramenti con le riforme al Codice Civile del 1958 e del 1961, grazie alle quali vengono finalmente concessi alle donne maggiori riconoscimenti dal punto di vista familiare e migliori accessi e garanzie nel mondo lavorativo.
In quegli anni Maria Telo, che oltre che essere l’autrice del saggio dal quale si sono attinte molte delle informazioni sin qui riportate in merito alle leggi spagnole circa i diritti delle donne, è anche parte attiva, come lei stessa racconta, nella lotta femminile verso la conquista del riconoscimento di maggiori libertà. Dal 7 al 13 settembre 1969, infatti, si riunisce a Madrid nel Colegiodes Abogados la Fédération Internationelle des Femmes des Carrères Juridiques, della quale è membro e consigliera. Durante la riunione la giurista tiene un intervento intitolato “La Mujer en el Derecho Civil” nel quale espone la realtà Spagnola. Come lei stessa afferma la risposta dell’opinione pubblica è notevolmente a suo favore (Telo,1986: 93). Si registra quindi una decisivo aumento della sensibilità dell’opinione pubblica sull’argomento, che contribuisce ad accelerare il cambiamento. Grazie ai lavori di questo collegio e con il loro apporto si arriva finalmente nel 1975 alla stesura delle nuove norme del Código Civil che aumentano ulteriormente i diritti riservati alle donne, portandoli alla quasi completa parità con quelli degli uomini.
3.6 La transizione e i diritti riconquistati
L’anno 1975, che segna per altro la morte di Franco, va tuttavia ricordato anche per un altro grande avvenimento. Viene celebrato infatti l’anno internazionale della donna, preceduto nel 1974 dalla creazione della Plataforma de Organizaciones y grupos de mujeres de Madrid, che si dedicano alacremente alla realizzazione delle Primeras Jornadas de la Liberación de las Mujeres. Negli anni successivi la morte del dittatore si assiste al rapido sorgere di una grande quantità di movimenti femminili che si riuniscono, pubblicano riviste, esprimono le proprie idee nelle trasmissioni radiofoniche. A seguito delle elezioni del 1977 alcuni di questi gruppi scelgono addirittura di istituzionalizzarsi, altri invece rimangono solo a livello associazionistico nel contesto nazionale (SESM 1986: 30). Aumenta nel frattempo il numero di donne che terminano il percorso di studi, il numero di donne lavoratrici, il numero di deputate, viene riconsentito il divorzio. Lentamente quindi, dopo la transizione, i movimenti femministi vedono diminuire il numero delle loro sostenitrici, ma semplicemente poiché, grazie al riacquisito accesso dei diritti civili sino a qualche decennio precedentemente negati, possono tornare a far parte integrante della società, diventando la prova vivente che le dure battaglie compiute nel corso del ventesimo secolo, ispirate dalla se possibile ancora più faticosa sfida di fine Ottocento hanno finalmente dato i loro frutti. Naturalmente le difficoltà legate all’emancipazione della donna non sono ancora totalmente sradicate, soprattutto nei centri minori dove rimane ancora un residuo della mentalità maschilista e permeata di cattolicesimo che ha permesso tanti anni di soprusi, ma ormai le nuove generazioni spagnole hanno tutti gli strumenti giuridici e culturali per rendere duratura la così duramente raggiunta parità tra i sessi.
Capitolo 4
Carta nella Carne
4.1 Premesse
Il presente capitolo si occupa di indagare dal punto di vista letterario alcune tra le opere più innovative del secolo appena trascorso in merito alla rappresentazione dell’immagine femminile. Numerosi infatti sono i testi che affrontano questo argomento ma si è scelto di focalizzare la ricerca su quelli che si ritengono dei veri passaggi evolutivi verso una maggiore consapevolezza dell’identità e del ruolo sociale femminili. Per questo motivo si possono definire gli autori trattati come dei precursori della letteratura contemporanea, i quali hanno ridonato voce all’universo della donna, nascosto dietro alle quattro mura domestiche. La maggior parte degli scrittori spagnoli del Novecento infatti, fino almeno agli anni 50-60, presentano la donna assecondando i parametri indicati dall’ordine costituito. La donna proposta per tanto è generalmente casalinga, dedita alla cura dei propri figli, devota al marito e alla Chiesa. I temi a lei riservati, soprattutto durante il franchismo nel quale prolifereranno collane di questo genere, sono le grandi storie d’amore dove l’uomo arriva provvidenzialmente a salvare la donna da se stessa e dalle proprie paure, riscattandola e dandole la possibilità di realizzare la propria missione nella vita, cioè quella di madre e di moglie. Altri autori ancora invece hanno dipinto donne sensuali, voluttuose, ammaliatrici, esotiche, ombre irreali di fantasie ed ossessioni maschili: riassumendo questi casi si potrebbe quindi parlare di donne oggetto, frutto di un punto di vista parziale, incompleto e, se non superficiale, poco realistico in quanto mancante di tutte le sfaccettature che invece sono presentate negli esempi qui approfonditi. Si è infine volutamente omessa un’analisi della letteratura più recente in quanto si ritiene, al fine del presente elaborato, più funzionale evidenziare i cambiamenti più significativi avvenuti nel corso del novecento per ciò che concerne la rappresentazione della donna. Tale asserzione si basa sulla convinzione generale che il passato e la storia giochino un ruolo fondamentale nella cultura del presente, tale da determinarne o comunque da caratterizzarne modalità rappresentative e percettive della realtà, dei generi e dei ruoli sociali.
4.2 Romanzo di fine secolo
Nella cultura Spagnola di fine Ottocento la Chiesa cattolica, con la sua morale pudica e conservatrice, occupa un ruolo di primo piano, influenzandone modelli di comportamento, assegnazione dei ruoli sociali e componimenti artistici. Di gran moda è la novella naturalista che ripropone lo stile di Émile Zola[19]. C’è un grande interesse in questa tipologia di scrittura verso la donna, il suo comportamento e la sua fisicità, argomenti questi rimasti per lo più marginali e di scarso interesse nelle epoche precedenti. Come documenta la ricercatrice Pura Férnandez si moltiplicano anche le ricerche in campo medico e scientifico sul corpo della donna e sulla correlazione fra la sua fisicità ed il suo comportamento. Spesso la considerazione finale di tali ricerche, comunemente condivisa dal mondo intellettuale e scientifico, è che la donna è per natura portata a farsi guidare dall’emotività la quale, esacerbata dalle forti restrizioni impostele culturalmente per via del suo ruolo sociale, spesso sfociano in nevrosi ed isteria. La studiosa pone poi in rilievo, in secondo luogo, il forte interesse, ai limiti della morbosità, nei confronti del lato oscuro della donna, di tutto ciò che è all’epoca giudicato peccaminoso o scandaloso. In particolare suscita grande attenzione il tema della prostituzione: dato che il corpo della donna diviene la rappresentazione simbolica del grado di sviluppo della civiltà di fine ottocento, la sua mercificazione in questo contesto non è altro che il risvolto consumistico della soddisfazione degli istinti più naturali dell’uomo (Férnandez 1996: 82). La letteratura non sfugge a questa influenza e sono numerose anche in Spagna le produzioni che, sulla scia del romanzo zolesco, vedono come protagoniste figure femminili dalla dubbia moralità, spia della decadenza dei costumi in atto e del bisogno di un diverso tipo di rappresentazione dell’universo femminile, perfettamente aderente ai modelli proposti invece in precedenza dalla cultura egemonica. Gli autori che affrontano questa nuova tematica, ci ricorda la Férnandez, suscitano un vero e proprio scandalo all’interno della comunità letteraria e per questo i loro testi vengono banditi: il paese è evidentemente ancora talmente permeato di perbenismo e di moralismo cattolico da non essere in grado di aprirsi a nuove riflessioni riguardo il mondo femminile nella sua complessità. I personaggi usciti dalla penna di questa categoria di autori censurati e disprezzati dalla corrente di pensiero dominante sono soprattutto donne di malaffare o dalla torbida condotta. Costoro però non sono presentate in maniera retorica come il male, il modello da non seguire, ma servono all’autore da strumento per mettere in discussione la morale corrente, inclusa la tanto decantata castità degli ecclesiali e per evidenziare le lacune e gli squilibri del mondo contemporaneo, suscitando inevitabilmente in esso polemica e dissenso. Molti autori si dedicano alla rappresentazione delle realtà più misere e marginali, ponendo l’accento sui controsensi presenti nella società e sulla relazione fra il comportamento umano e la sessualità, imprescindibile dalla nostra natura ma ancora considerata argomento tabù. Sono ricorrenti in questi testi i riferimenti alla medicina, alla religione e alla sessualità: la questione sociale, che nell’ottocento ha una rilevanza di primo piano, spesso sfocia nella questione sessuale, ambito invece verso il quale a fine secolo l’interesse diviene via via maggiore, andando a costituire le basi della futura letteratura erotica (Férnandez 1996: 83).
4.3 Verso nuove concezioni di femminilità
Nel passaggio tra i due secoli l’ondata del modernismo europeo colpisce l’ambito letterario spagnolo. In questo contesto ciò sviluppa una tendenza che ripropone quale modello della vera essenza nazionale quello di un uomo forte e virile, la cui sessualità ha lo scopo fondamentale della procreazione e quindi della crescita del paese. Addirittura la virilità diviene una delle caratteristiche identificative della Spagna, la quale, in quanto virile appunto, è appunto anche forte e potente. Come ricorda Iris M. Zavala l’erotismo e la letteratura erotica di conseguenza sono banditi dalla cultura nazionale, relegati a contesti nascosti e proibiti (Zavala 1996:116). Tuttavia in questa cornice il corpo della donna suscita grande curiosità e spesso lo si interpreta come il luogo dello sconosciuto, del naturale e del senso stesso dell’esistenza, dato il nesso che lo lega alla nascita della vita. La Zavala cita in particolare due autori rappresentativi di questo periodo, i quali affrontano il tema proibito dell’esplorazione del corpo e dell’essenza femminile, valicando i confini concessi alla letteratura nazionale ufficialmente riconosciuta. Si tratta di Valle-Inclán e Unamuno, la cui produzione è incentrata sulla pluralità della realtà, sulle sue sfumature, sull’assenza nella natura umana di rigide e ferree regole fisse. La donna per questi scrittori perciò non è più il modello stereotipato e imprigionato nel ruolo di madre e di compagna; al contrario, essa è un essere dotato di ragione in grado di gestire la propria esistenza e di provare emozioni e desideri talvolta scandalosi per la morale ufficiale ma da loro presentati come del tutto naturali e legittimi. Data la già ricordata pressante presenza della chiesa in tutte le sfere del contesto spagnolo, tale tipo di punto di vista difficilmente viene compreso e accettato, dato che esso travalica le concezioni di genere e si situa ad un livello di osservazione più attento e meno retorico nei confronti di ciò che realmente avviene o può avvenire nelle persone a prescindere dal sesso di appartenenza.
4.3.1 Miguel de Unamuno: Madre Natura
Miguel de Unamuno è studiato e presentato nel saggio della Zavala in quanto grande autore controcorrente, rispetto alla tendenza più tradizionalista e rigida dei suoi contemporanei. Secondo il pensiero della studiosa, infatti, Unamuno non vede nell’erotismo una metafora delle condizioni esterne, suo malgrado risultato ed espressione al contempo del contesto alienante nel quale si sviluppa, bensì la condizione intima e personale dell’individuo “in stretta relazione con la profondità del sé” (Zavala 1996: 143). Secondo lo scrittore, di conseguenza, il corpo femminile non è più la simbolizzazione dello stato, come invece è per alcuni suoi contemporanei, ma assume un significato mistico, di purezza e di sublimazione, diviene cioè il tramite per raggiungere il divino. Anche nella sua scrittura infine si nota il processo di decostruzione della realtà permeata dai valori canonici seguita dalla ricostruzione di un mondo dove invece essi sono ben più intimisti, frutto della rielaborazione personale dei protagonisti dei testi, risultante del loro vissuto e della loro sensibilità. Per meglio inquadrare la produzione unamuniana in riferimento alla trattazione della questione femminile la Zavala ne riassume in quattro punti le caratteristiche fondamentali:
(…) 1) la mujer maternal como vivencia de la naturaleza, y en el campo de lo real; 2) el mundo oscuro y matriarcal opuesto a los convencionalismos y al juego político; 3) la devoradora y castradora, sujeta a la envidia y al habre de maternidad; 4) la costumbre (domesticación) o regazo maternal, que comprende y ama, que acerca a la negación del deseo, análogo a la contemplación o unidad última (Zavala 1996: 144).
Come si evince dalle parole della studiosa si ritrova quindi nell’autore innanzitutto l’assegnazione di una grande importanza al ruolo materno, al potere di dare la vita, che viene conferito alla donna dalla natura stessa, di cui è la manifestazione concreta nel mondo reale. In secondo luogo Unamuno riconosce l’esistenza di un modo parallelo a quello maschile, che si sottrae alle leggi, ai giochi di potere, alle brutture ed alle convenzioni della cultura e della società egemonica. Questo mondo è quello matriarcale, intimo e strettamente legato all’essenza della vita stessa, più riflessivo ed in contatto con le leggi naturali. L’autore è affascinato dalla saggezza femminile e da quella sorta di tacito legame che deriva da un sentire di fondo che accomuna tutte le donne, tanto da parlare, appunto, dell’esistenza di un vero e proprio matriarcato. Il terzo punto preso in esame è il potere che la donna è in grado di esercitare nei confronti dell’uomo negandosi alla di lui passione, da cui deriva l’appellativo della Zavala di castradora. A questa caratteristica ella aggiunge la fame di maternità, il desiderio in grado di annullare qualsiasi altra priorità e che fa parte della donna come il suo stesso sangue. Basti pensare al romanzo della Tia Tula, dove la protagonista raccoglie perfettamente in sé questo terzo punto, rifiutando in nome della maternità acquisita dei propri nipoti le avances di diversi uomini. In questo modo Tula mira a salvaguardare la purezza viscerale che la lega ai propri nipoti, che ella stessa considera suoi figli ed ai quali si dedica totalmente. I personaggi maschili del romanzo in effetti ne escono mortificati e limitati, “castrati” appunto, poiché non in grado di comprendere ed abbracciare il mistero della vita e dell’universo femminile e quindi da esso rifiutati o comunque tenuti ai margini. Il quarto ed ultimo punto della Zavala si lega a quello appena trattato e si riferisce alla capacità femminile di negarsi la propria stessa sessualità e desiderio pur di mantenere la purezza e la perfezione quasi mistica in grado di portare all’elevazione dell’animo umano. Si tratta di caratteristiche femminili che Unamuno propone in una chiave di lettura positiva, ponendo l’attenzione sul potere decisionale delle donne, sull’importanza del loro ruolo, attivo all’interno della società, seppure da essa non riconosciuta, sull’intelligenza femminile, non solo intuitiva ma anche pratica che deriva loro dallo stretto legame con la natura che ha donato loro il dono di dare la vita, sulla delicatezza dell’emotività delle donne, che però sono in grado di controllare e se necessario anche reprimere nel nome di un bene più grande, quale può essere un figlio o la giustizia, la correttezza e la già citata purezza.
Alla donna quindi Unamuno restituisce il ruolo misterioso e magico legato alla sua fisicità, come creatrice e preservatrice della vita. L’universo femminile inoltre, grazie ad una sensibilità fortemente sviluppata, a differenza, come già ricordato, di quella limitata che emerge dai personaggi maschili, utilizza più o meno consapevolmente questa risorsa come chiave per superare i limiti e le barriere intrinseche nella condizione umana, siano esse di origine sociale o familiare. Per sottolineare il maggior grado di consapevolezza in dote alla femminilità, Unamuno propone però donne che non corrispondono al modello canonico, ma che invece compiono scelte di vita piuttosto forti dalle quali sono inamovibili, come nel caso della Tia Tula. La protagonista infatti di questo romanzo si nega la totale realizzazione come madre naturale non sposandosi e non avendo figli di sangue, seppur conseguendo una maternità non fisica da lei considerata altrettanto pura e sacra, lasciandosi da essa volutamente coinvolgere in maniera forte e viscerale. L’apporto di questo autore consiste quindi nell’identificare nell’amore, promosso attraverso questi personaggi femminili così saggi, forti e per certi versi estremi, quella forza che supera e vince qualsiasi legge, politica ma anche naturale. Come si evince da quanto sinora trattato perciò, si può affermare che Unamuno è profondamente affascinato dal mondo femminile, tanto da parlare dell’esistenza di una sororidad, così presentataci dalla Zavala:
(…) el sentido matriarcal del mundo, lo quel llama «sororidad». Este mundo matriarcal está liberado de la lucha (masculina y cainita) por el poder, de la guerra, de la competitividad del mundo moderno; y su centro es dar vida (Zavala 1996: 146).
Con la presentazione di questo concetto di sorellanza presentato da Unamuno e rilevato nell’opera dell’autore, la Zavala stessa intende illustrare un aspetto particolarmente significativo e profondo della sensibilità Unamuniana. In effetti egli riabilita notevolmente la funzione femminile in relazione al significato della vita umana; questo non solo per ciò che concerne il potere di dare la vita, ma anche e soprattutto per un differente grado di consapevolezza rispetto a quello maschile che rende le donne capaci di essere al contempo pratiche e spiritualmente elevate, quasi delle figure mistiche. La Zavala in particolare fa riferimento all’esistenza di un legame di sorellanza universale che travalica il mero legame sanguigno e che fa derivare, seguendo il filo logico unamuniano, dall’assenza delle distruttive aspirazioni maschili quali la guerra, il potere, la rincorsa del successo. La possibilità di dare la vita sarebbe quindi quella forza naturale ed insieme divina in grado di infondere saggezza e di risvegliare uno spirito di tacita unione e collaborazione fra donne, la sororidad di cui sopra.
Il mondo, stando a questa analisi, assume inevitabilmente una nuova connotazione e si propone pertanto l’ipotesi di un’origine matriarcale della società umana, guidata dalla sapienza femminile, frutto diretto del mistero della vita e per questo suo interprete indiscutibile.
4.4 Avanguardie di inizio Novecento
La storia spagnola riassunta nel capitolo primo del presente lavoro non lasciata adito a dubbi circa la forte presenza della Chiesa cattolica che per secoli ha influenzato profondamente politica, cultura, ruoli sociali e l’arte stessa all’interno del Paese. Si tratta di un’influenza rigida e repressiva, all’interno della quale la castità al di fuori del matrimonio, oltre che essere una qualità positiva, si trasforma in un dovere addirittura legalmente punibile qualora infranto, almeno per quanto riguarda le donne. Tale condizionamento si protrae fino agli scorci del secolo scorso, per ridimensionarsi definitivamente, soprattutto nelle ultime generazioni, con la morte di Franco nel 1975 e la fine di una dittatura che della Chiesa fa suo solido e fido alleato.
Il senso del peccato legato al semplice desiderio del piacere si inizia a sgretolare lentamente però già a partile dagli inizi del secolo XX quando le conseguenze della rivoluzione industriale in ambito letterario iniziano a farsi sentire in Europa dapprincipio ed in Spagna di riflesso. In contrapposizione con il forte ottimismo portato dal progresso tecnico e scientifico del secolo precedente quindi, prende sempre più piede una disillusione che orienta la ricerca verso l’intimismo e la riscoperta del mondo dei sentimenti e delle passioni, sino a sfociare in un vero e proprio “culto a lo irracional” come segnala Mangini (Mangini 1996: 179). Diretta conseguenza di questa nuova ondata di pensiero sono i movimenti avanguardisti che si pongono come obiettivo la ricerca della vita interiore; loro esponenti nella letteratura europea sono, per citarne i più autorevoli, Baudelaire, Joyce, Rimbaud, Wilde, Proust, tutti autori che nelle loro opere portano alla luce i lati più oscuri ed intricati dell’animo umano. Come ricorda la studiosa, tali cambiamenti hanno delle conseguenze anche nella poetica spagnola di inizio secolo, benché si tratti di uno scambio piuttosto limitato per via della già nominata Chiesa cattolica che in questo Paese più che in altri esercita la sua influenza conservatrice, sostenuta dallo Stato, dall’esercito e dall’alta borghesia. Si andrà ora ad analizzare il contributo degli autori spagnoli d’avanguardia della cosiddetta generazione del 27.
4.4.1 Federico García Lorca e La Casa de Bernarda Alba
Su ispirazione delle università britanniche di Oxford e Cambridge, nel 1910, Alberto Jimenéz Fraud fonda a Madrid la Residencia de Estudiantes con lo scopo di formare i giovani uomini aristocratici della Spagna moderna. In questa residenza vigono regole rigidissime, i ragazzi sono ospitati in celle anguste e sottoposti a sessioni di studio serrate, oltre che educati nella maniera più consona al loro futuro ruolo (sicuramente prestigioso) nella società.
Uno degli alunni di questa scuola è l’autore Federico García Lorca per il quale, secondo quanto affermato dalla Mangini, la donna sarebbe una vittima oppressa dalla società fortemente maschilista nella quale si ritrova immersa. Tuttavia, per quanto riguarda il discorso sul desiderio attorno al quale è incentrato il saggio della studiosa, tale aspetto rimane in secondo piano poiché ciò che risalta è l’omosessualità dell’autore, con le conseguenti problematiche. Problematiche che consistono fondamentalmente nella difficoltà di accettazione da parte della società della sua attitudine sessuale e che traspaiono fortemente anche nelle sue stesse opere. Una denuncia palese della discriminazione esistente nei confronti dell’omosessualità, per esempio, è indicata dalla Mangini nella poesia Oda a Walt Whitman (Mangini 1996: 188). In particolare, la studiosa pone l’accento su di un verso, “el sexo atraversado por una aguja” nel quale, oltre al forte impatto evocativo, si evince una sensazione di dolore profondo e lacerante legata all’impossibilità di vivere serenamente la propria sessualità. Il periodo nel quale il poeta scrive le sue opere è infatti fortemente condizionato dalla morale cattolica, la quale condanna l’omosessualità nella maniera più assoluta. La studiosa poi analizza altre produzioni poetiche di Lorca, dalle quali emergono però soprattutto considerazioni circa lo stile figurato del poeta e la sofferenza intrinseca nell’amore.
Per avere un’analisi più esauriente del discorso di Lorca circa la condizione femminile si è rivelato molto funzionale il contributo di un’altra docente di letteratura spagnola, Maria José Sanchez-Cascado, la quale focalizza la sua attenzione sull’opera teatrale dell’autore, in particolare nel testo La Casa de Bernarda Alba, dove ci si ritrova in un contesto di personaggi femminili. La studiosa prende questo lavoro teatrale ad emblema della rappresentazione di Lorca verso il femminile poiché la sua trama è costituita dall’intreccio di storie familiari femminili, dove le donne sono le protagoniste indiscusse e quindi tema di indagine principale. La storia è ambientata in un non chiaramente identificato paesino spagnolo nel quale vive una famiglia composta esclusivamente da donne. Nel suo saggio la Sanchez-Cascado riprende le parole introduttive all’opera di Lorca stesso, il quale scrive che si tratta di un “drama de mujeres en los pueblos de España” e ancora “estos tres actos tienen la intención de un documental fotográfico”. Queste affermazioni a presentazione del testo sono emblematiche della volontà di questo autore di attribuire rilevanza e risalto alle vicende femminili, raramente approfondite dagli autori dell’epoca, attribuendo alla donna le sfaccettature e i lati umani che spesso in letteratura le vengono preclusi per via del ruolo passivo socialmente riconosciutole. Si evince inoltre dalle parole dell’autore stesso una volontà “fotografica”, intesa dalla Sanchez-Cascado come desiderio di distacco rispetto alle vicende narrate, ma interpretabile anche come tentativo di dare un quadro preciso ed imparziale, cioè privo di retorica o simbolismi, ad un mondo nascosto agli occhi della Spagna ufficiale, quasi a rendere giustizia a quelle vite umane così facilmente trascurate, annullate, passate sotto silenzio. In effetti il saggio riprende in un secondo momento proprio la tematica del silenzio, sottolineando come il filo conduttore de La casa de Bernarda Alba sia proprio questo silenzio il quale, insieme ad un forte senso di chiusura, si contrappone all’uscita. La parola salida è da intendersi non solo come l’uscita figurata dalla casa stessa, ma anche e soprattutto come il liberarsi dall’isolamento soffocante fatto di castità, purezza, proibizione, pregiudizio e quindi anche repressione della vitalità delle figlie più giovani di Bernarda, vittime, secondo l’analisi della Sanchez-Cascado, del fitto intreccio di norme e regole rigide e conservatrici, prodotto di una società patriarcale e maschilista.
Dalla lettura dell’opera in effetti non si può confutare la tesi della studiosa. Significativa è innanzitutto la scelta di trattare un tema tanto poco affrontato all’epoca sottoforma di lavoro teatrale: quello teatrale infatti, a differenza degli altri generi letterari, è studiato per essere messo in scena e quindi per arrivare con una certa immediatezza al pubblico, perciò, considerando l’argomento del testo, si tratta di una scelta piuttosto azzardata. Assecondando però l’intenzione dichiarata da Lorca all’inizio dell’opera, si attribuisce una decisione di questo tipo proprio al desiderio di rompere quella cortina di silenzio, presente in maniera ripetitiva, quasi ossessiva, all’interno del testo stesso, calata sopra alla vita domestica delle donne. Si tratta di un mondo tutt’altro che muto, quieto e raccolto come lo si immagina o come lo si vorrebbe secondo il modello di società proposto dalla cultura egemonica dei suoi tempi.
La trama si sviluppa attorno alle vicende di una famiglia unicamente composta da donne, in particolare da Bernarda, vedova sessantenne e le sue figlie, in ordine di età decrescente Angustias, avuta dal suo primo matrimonio, Martirio, Magdalena e Adela, la minore. Altri personaggi della casa sono María-Josefa, madre di Bernarda e affetta da una leggera forma di pazzia senile, La Poncia, serva di casa e fedele consigliera di Bernarda, pur disprezzandola per la sua rigidità ed una serva minore. L’opera si apre con il ricevimento in casa seguente il funerale del secondo marito di Bernarda e l’atmosfera iniziale è immediatamente permeata di silenzio, come già visto tema ricorrente. Nel primo atto, soprattutto attraverso le parole della Poncia, si presenta il carattere di Bernarda, donna dura e severa, la cui ossessione per le apparenze si trasforma in una vera e propria paranoia, tanto da impedire alle proprie figlie, tutte maggiorenni e la più grande delle quali addirittura quasi quarantenne, di intrecciare qualsiasi genere di relazione con gli uomini del paese, da lei giudicati non all’altezza. La Poncia lamenta anche il fatto di essere costretta dalla propria padrona a spiare i vicini per intere giornate, per poi riportare le notizie raccolte. Altri due personaggi che si distinguono all’interno del lavoro sono María Josefa, l’anziana madre di Bernarda, figura poeticamente pazza e ormai persa in un mondo di sogno dal quale però non manca di uscire ed avere attimi di intatta lucidità nei quali rimprovera l’ipocrisia della propria figlia e Adele, la figlia minore, l’unica che ancora non si vergogna dei propri sentimenti e delle proprie passioni e che, in barba alle raccomandazioni materne, non esita a sfoggiare uno sgargiante abito verde, a simbolo della propria ribellione e freschezza giovanile. La madre è un personaggio fortemente autoritario, ad inizio opera si sostituisce immediatamente all’appena defunto marito, assumendo totalmente la funzione di capofamiglia ed il potere nella casa. Ella impone alle proprie figlie l’obbligo del lutto per sette anni, nel quale periodo dovranno tutte vestirsi di nero e non uscire assolutamente dalle mura domestiche. La Sanchez-Cascado commenta questo atteggiamento come la conseguenza di una masculinización, cioè dell’assunzione di caratteristiche maschili da parte della madre la quale, sicuramente già severa ed intransigente di carattere, diventa insopportabile nell’assumere un ruolo maschile che non le appartiene, subendo la propria stessa ossessione per le apparenze, che ne amplifica la durezza. La narrazione continua poi con piccole vicende domestiche, dalle quali emerge una sorta di mutua complicità femminile fra le sorelle ed anche l’amarezza che le accompagna per essere ancora tutte quante nubili ed isolate dal resto del paese. Di particolare rilievo è un episodio, riportato anche nel saggio in esame, nel quale una giovane rimasta incinta al di fuori del matrimonio uccide il bimbo appena nato e lo seppellisce in giardino. Allo scoprire l’accaduto è immediata la reazione dei paesani i quali, inferociti di fronte a tanto disonore, non esitano a correre a casa della colpevole per massacrarla prima dell’arrivo della polizia. Indicativo della mentalità di Bernarda la quale, appena saputo della vicenda, condanna la ragazza con una ferocia inaudita non per l’infanticidio, bensì per il disonore che la poveretta ha portato alla propria casa cedendo al peccato carnale. Il tema del disonore è più volte presente sulle labbra di Bernarda che, come ricordato, rimane fortemente ancorata all’immagine e all’opinione della gente. Riferendosi all’intento fotografico di Lorca quindi, quello che si vuole catturare qui è lo scorcio di un piccolo mondo rurale i cui pensieri sono dominati da una morale cattolica che risulta così presente da togliere umanità ai personaggi i quali, invece che provare pietà, diventano crudeli. Questo è proprio il caso di Bernarda, che incarna perfettamente lo stereotipo della donna devota e religiosa portato all’estremo, privo di compassione in virtù delle apparenze. L’unico personaggio che prova compassione è la giovane Adela la quale nel frattempo ha iniziato una tresca con il pretendente la mano di sua sorella maggiore, Angustias, oramai trentanovenne e che ingenuamente non concepisce neppure lontanamente il peso che implica nella società in cui vive uno slancio amoroso al ì fuori delle regole. A fine racconto è proprio lei infatti a pagarne con la vita stessa le conseguenze: scoperta infatti dalla madre, la quale le fa credere di avere ucciso il suo amante, la giovane si toglie la vita in un ultimo ed estremo atto di libertà e di disperazione al contempo. L’opera si chiude con Bernarda la quale, ancora una volta anteponendo ai propri sentimenti materni la paranoia per le buone apparenze, proibisce alle sorelle di piangere la scomparsa e proclama a gran voce (sapendo di mentire) la verginità di Adela.
Dal testo analizzato emerge un quadro piuttosto degradante della donna del periodo. Ci si trova di fronte infatti ad una figura, quella di Bernarda, la quale non solo non approfitta dell’assenza maschile per permettere una maggiore libertà alle proprie figlie, ma arriva a farne le veci in maniera quasi dittatoriale, cercando inculcando nelle figlie una sorta di rifiuto verso gli uomini del paese, rifiuto che lei stessa manifesta sia impedendo svariati corteggiamenti nel corso degli anni, sia dichiarando l’inadeguatezza di tali uomini, che non sarebbero all’altezza delle ragazze. Si evince quindi che le donne secondo Lorca sono vittime a tal punto della cultura maschilista alla quale appartengono, da diventarne loro stesse portavoce e carnefici, intrappolate in una spirale di pregiudizi, paure e silenzi, frutto dell’eccessivo zelo nel voler mantenere le apparenze. Lorca scrive anche altre opere teatrali con protagoniste femminili, come per esempio Donna Rosita Nubile o Il linguaggio dei fiori, nella quale riprende il tema della solterona, appellativo familiare e di scherno affibbiato alle donne non sposate. Questo argomento viene da lui trattato con estrema delicatezza, ponendo l’accento sulla ricerca dell’amore, sulla solitudine, ma soprattutto sul pregiudizio dell’opinione comune che affligge queste donne, considerate in maniera negativa in quanto, per non essere sposate, sicuramente è per via di un brutto aspetto o di un pessimo carattere. Anche in La casa di Bernarda Alba la questione è presente, personificata dalle sorelle nubili rinchiuse in casa, che tuttavia sognano l’amore e non sono per nulla insensibili al richiamo sensuale, nonostante le proibizioni ed il moralismo pressante cui sono soggette.
In conclusione, dai testi analizzati e dagli apporti sin qui presentati circa la produzione di Lorca in merito alle tematiche femminili, si denota in lui una profonda e controcorrente sensibilità, la quale si traduce in delicate ma di forte impatto opere di denuncia. Denuncia questa quasi rassegnata, essendo ben consapevole l’autore dei limiti della società del suo tempo ed ancor più dei limiti della mente umana, la quale difficilmente riesce a liberarsi dai vincoli sociali.
4.5 Carmen Laforet e le scrittrici della Postguerra
A seguito della Guerra Civile il progresso delle libertà civili in Spagna, tanto perseguito e favorito durante la Seconda repubblica, viene bruscamente troncato e la donna ripiomba nell’oscurità del secolo precedente, con pochi diritti e molti doveri, primo fra tutti l’obbedienza. Tuttavia, per quanto piuttosto discreditate all’interno del contesto sociale di regime, non scompaiono totalmente le scrittrici, benché esse si dedichino prevalentemente ai generi letterari della narrativa e della poesia. Come ricorda anche Cristina Ruiz Guerrero nel suo Panorama de Escritoras Españolas, la maggior parte delle scrittrici proviene dalla borghesia benestante, condizione sociale che permette loro di accedere agli studi e di raggiungere una formazione culturale completa, grazie anche al processo di apertura verso le donne avviatosi nei decenni precedenti in ambito accademico. In questo panorama, tutto sommato piuttosto rassegnato ed accomodante rispetto alle linee guida indicate dalla Falange, si fa però strada l’opera di un’autrice, Carmen Laforet, che con il suo Nada giunge ad ottenere nel 1944 il Nadal, prestigioso premio letterario. Molte scrittrici a lei successive si ispireranno al suo romanzo, fra le quali Carmen Martín Gaite. Il conferimento di tale riconoscimento, insieme al premio Planeta, alla pubblicazione di articoli specializzati in letteratura femminile e al diffondersi delle idee femministe sulla scia di altri paesi europei, fa si che pian piano si creino le basi per un futuro consolidamento di una letteratura scritta da donne (Ruiz Guerrero 1997: 153). La studiosa sottolinea però come sia impossibile classificare questo gruppo di scrittrici all’interno di un genere letterario preciso, in quanto facenti parte di un mondo a sé stante, quello femminile appunto. Tale universo, infatti, difficilmente è raccontato dagli autori che le precedono, causa la netta divisione dei ruoli sociali allora esistente fra uomini e donne, la quale isola completamente i due generi. Per questo, a parte qualche eccezione di cui fanno parte i precedenti testi analizzati in questa sede, gli autori maschili tendono a rappresentare la donna classificandola secondo i propri parametri, sminuendola, idealizzandola o più semplicemente riducendola ad un mero oggetto letterario.
4.5.1 Nada
In Nada, capolavoro indiscusso di Carmen Laforet, l’autrice, benché all’epoca poco più che ventenne, con un linguaggio fortemente evocativo e poetico è tuttavia in grado di renderci l’immagine di una Barcellona appena uscita dalla Guerra Civile, ferita ed acciaccata, cupa e decadente ma nello stesso tempo calda ed accogliente, i cui vicoli rappresentano un sicuro rifugio per la protagonista. Si tratta di un’opera che trae spunto dalla biografia dell’autrice stessa, anche lei trasferitasi, come la protagonista del romanzo, a Barcellona per frequentare l’università, costruendosi attraverso gli studi una via per l’indipendenza. Il modello femminile proposto quindi dalla Laforet è piuttosto stridente rispetto a quanto prospettato dalla morale di partito, che vuole anche l’educazione femminile finalizzata al suo vero scopo, cioè la famiglia. L’universo femminile in quest’opera è il motore principale, il filo conduttore. A volte decadenti e lugubri spauracchi di un’epoca passata ma che non desiste dall’inquinare il presente, altre volte figure limpide, eteree, altre ancora fiere e passionali in cerca di un riscatto sociale e morale, sono infatti le donne ad essere raccontate e a raccontare un’epoca sicuramente carica di grandi contraddizioni.
Con Nada è presentata l’immagine femminile della postguerra spagnola o meglio, varie immagini femminili di quell’epoca storica. Fin dal principio, in uno dei passi più rappresentativi dell’opera, Carmen Laforet propone alcune interessanti tipologie femminili, fantasmi scoloriti di un modello arcaico che tuttavia rappresenta per questi personaggi un presente senza vie di fuga, come del resto per molte donne loro contemporanee, intrappolate nella staticità dell’ideologia franchista. Si tratta del primo incontro tra Andrea ed i familiari presso i quali sarà ospite, ancorati ai valori di una vecchia ed austera borghesia ormai fuori dal tempo. Alla ragazza si presenta una piccola parata notturna di donne spettrali, senza colori, il cui grigiore è accentuato dall’essere ancora in pigiama ed assonnate al momento dell’accoglienza della nuova arrivata e dalla sporcizia della casa. Andrea, rimasta orfana, arriva a Barcellona da un piccolo paese di campagna per frequentare l’università, con l’obiettivo di laurearsi in letteratura. Subito dopo la presentazione della decadente casa e dell’ancor più decadente famiglia materna di Andrea, si colloca una scena piuttosto rappresentativa del tipo di educazione femminile cara al regime franchista. Dopo le presentazioni e i saluti Andrea si trova sola con la zia Angustias, la quale immediatamente si preoccupa di informarla circa la linea educativa che ha intenzione di rispettare e di far rispettare alla nipote. Da questo dialogo spicca innanzitutto l’assonanza fra l’età ormai adulta e l’indole della ragazza ed il ruolo fortemente restrittivo che si auto assegna Angustias nei suoi confronti. Andrea è infatti ormai maggiorenne, autonoma e carica di entusiasmo, si trova lì poiché vuole studiare e costruirsi un futuro. La zia le si para immediatamente innanzi con una preoccupazione oltremodo accentuata, dando l’impressione di essere più una guardia che una guida, come si evince chiaramente da alcuni estratti del discorso tenutole da Agustias qui sotto riportati:
Hija mía, no sé cómo te han educado… (…) Ya sé que has hecho parte de tu bachillerado en un collegio de monjas y que has permanecido allí durante casi toda la guerra. Eso, para mí, es una garantía. (...) No te negaré, Andrea, que he pasado la noche preocupada por ti, pensando... Es muy difícil la tarea que se me ha venido a las manos. La tarea de cuidar de ti, de moldearte en la obediencia... (...) en toda España no hay ciudad que parezca más al iniferno que Barcelona. (...) Una Joven en Barcelona debe ser como una fortaleza. (...) Te lo diré de otra forma: eres mi sobrina; por lo tanto, una niña de buena familia, modosa, cristiana e inocente. Si yo no me ocupara de ti para todo, tú en Barcelona encontrarías una moltitud de peligros. (Laforet, 1945: 25, 26).
L’attenzione viene subito focalizzata dalla zia sull’educazione di Andrea, la quale, secondo il suo pensiero, è, o per lo meno dovrebbe essere, rispettosa dei valori della morale cattolica, castità e famiglia in testa. Il modello proposto è quello della donna come una bimba, i cui occhi nulla devono vedere delle brutture del mondo e della grande città. Barcellona, metropoli dinamica e già allora crogiuolo di incroci di tipologie umane, rappresenta pertanto secondo Angustias l’inferno, la sporcizia terrena, il male assoluto, di fronte al quale una donna deve essere intaccabile, inespugnabile, come una fortezza appunto. Questo è quanto Angustias si auspica per la nipote, una chiusura totale ed un comportamento inappuntabile secondo i valori cattolici che, per inciso, sono gli stessi promossi dalla morale di regime. Non solo, sin da questi brevi passaggi è riproposto il clichè della donna di buona famiglia, dai modi rispettabili, innocente ed obbediente. Angustias, soprattutto all’inizio della permanenza della nipote in città, la accompagna in lunghe passeggiate attraverso Barcellona, istruendola sui comportamenti da tenere in pubblico ed educandola alle buone maniere. Il personaggio della zia per molti versi rispecchia fedelmente il canone della donna di fede, che non cade in tentazioni e che preserva la propria purezza, tanto da decidere, ad un certo punto del romanzo, di dedicarsi alla vita monacale. Angustias infatti è una rappresentante della categoria delle spregiativamente chiamate solteronas, donne ormai mature ma mai sposate: la società tende ad incolpare le donne stesse per la loro solitudine, poiché particolarmente brutte o dal pessimo carattere. La scelta di chiudersi in convento quindi, non è inusuale nella Spagna dell’epoca in cui le vicende sono ambientate: pur di non identificarsi infatti con la figura della solterona, che non è riuscita ad accaparrarsi un uomo, è di gran lunga preferibile, come già messo in luce nel capitolo terzo del presente lavoro, assecondare la vocazione religiosa, vera o finta che sia, in quanto fonte di rispetto e di ammirazione di fronte alla società.
La nonna di Andrea invece incarna la donna sposata, dedita alla famiglia ed ai figli, soprattutto quelli maschi. Si presenta come un’anziana ricurva, appesantita dagli anni e dalla cupezza della vita, della guerra, della dittatura. Ella è la prima ad accogliere Andrea nella casa, pur tuttavia non riconoscendola immediatamente per via della confusione mentale dovuta all’età. Per tutto il romanzo la nonna fa da contrappeso alla figura di Angustias, così severa ed incorruttibile, soprattutto nei confronti di Gloria, la nuora, verso la quale manifesta affetto e protezione. Angustias infatti non può soffrire Gloria, la nuora, moglie del fratello Juan, intimando addirittura ad Andrea di non avere con lei alcun contatto, identificandola con la femmina tentatrice, che approfitta del proprio fratello e della propria famiglia. La nonna invece non solo dà confidenza a Gloria, con la quale stabilisce un rapporto affettuoso, ma interviene anche nei numerosi litigi violenti nei quali Juan, suo figlio, alza le mani verso di lei, cercando di proteggerla e di difenderla. La nonna è dunque anche l’anima protettrice della casa, per sua stessa ammissione infatti ella non dorme mai, ma vigila sulla famiglia. Andrea tuttavia è piuttosto intristita dalla sua figura, tanto da non riuscire ad accettare che la giovane con un velo di tulle che appare in una vecchia fotografia sia proprio sua nonna, una piccola mummia che si aggira silenziosa per l’appartamento di Calle Aribaud; preferisce invece pensare che anche lei sia morta, insieme al suo sposo, in un passato lontano dove la corruzione fisica e mentale non trovino terreno sul quale attecchire. Si considera fondamentale per meglio delinearne il ritratto uno dei passaggi finali del romanzo, che ha come cornice la veglia funebre del corpo di Roman, l’altro suo figlio, morto suicida al termine della narrazione. In questa circostanza le altre figlie della donna, mai menzionate prima, si presentano nella casa paterna e le rinfacciano la scarsa attenzione ed il poco affetto loro dedicati, sacrificati in favore dei due figli maschi:
Sempre fue usted injusta, mamá. Sempre prefirió usted a sus hijos varones. ¿Se da usted cuenta de que tiene usted la culpa de este final' (...) No hay más que ver la miseria de esta casa. Te han robado, te han despojado, y tú, ciega por ellos. (...) He acudido a los más desgraciados... A los que me necesitaban más. (Laforet, 1945:264).
Dalle feroci accuse delle figlie, la Laforet conclude quindi il quadro familiare aggiungendovi l’ultimo pezzo del puzzle: il quadro di una madre che ha amato i suoi figli, ma che si è dedicata anima e corpo solamente ai due maschi, accudendoli e servendoli come se non fossero mai diventati adulti, pensandoli esseri bisognosi ed incapaci di costruirsi una vita indipendente. Le figlie già sposate rivendicano l’affetto negato e accusano la propria madre di essere addirittura la ragione del tragico epilogo della vita di Roman e della disgraziata situazione di Juan, avendo loro concesso tutto, rendendoli incapaci a vivere.
Una figura presentata in negativo dalla famiglia di Calle Aribaud ma rivalutata e riscattata dallo sguardo di Andrea è invece Gloria, la nuora, moglie di Juan. Gloria è una donna avvenente, rossa di capelli e dall’indole ribelle, la quale conosce Juan e Román durante la Guerra Civil. Sposata con Juan ha da lui un bimbo nato da poco. Durante tutta la narrazione ci sono diverse scene di cruda violenza nelle quali Juan, accecato dalla gelosia, picchia e minaccia la moglie, pretendendo da lei ubbidienza e rispetto. Frequentemente Juan ricorda e precisa che in quella casa è lui ad avere le redini del comando e ad avere diritto alla più assoluta dedizione in quanto uomo e quindi padrone, secondo il modello arcaico della mentalità conservatrice spagnola dell’epoca. Durante queste scene sia la nonna che Andrea spesso intervengono per fermare la violenza e per consolare la povera Gloria che piange disperata e non si capacita di tanta crudeltà. Fra Andrea e Gloria si instaura con il passare dei mesi un rapporto di delicata complicità, fatto di reciproca consolazione e confidenze: entrambe infatti vivono in una famiglia della quale non condividono i valori e detestano il grigiore decadente, ma dalla quale loro malgrado non riescono a distaccarsi totalmente, per ragioni rispettivamente economiche ed affettive. Il riscatto di Gloria però ha luogo verso la fine del romanzo, quando Juan, esasperato dalla propria stessa gelosia, una sera, seguito a sua volta di nascosto da Andrea, segue la moglie e la scopre inoltrarsi nel Barrio Chino, dipinto da Angustias come luogo di perdizione. Gloria in realtà si reca laggiù non per tradire il marito, bensì per giocare a carte e racimolare abbastanza soldi da poter mantenere Juan e sé sessa, dato che l’uomo non ha una professione. Alla luce di quanto sopra, si può analizzare la figura di Gloria come il classico esempio della donna vittima del proprio uomo e del proprio ruolo sociale, ma che ciononostante non rinuncia alla propria indipendenza anche economica né alla propria femminilità.
Il rapporto femminile che più segnerà l’esperienza barcellonese di Andrea, tuttavia, è quello instauratosi con Ena, dapprima sua compagna universitaria e poi migliore amica. Ena è una ragazza solare, bionda, dagli occhi chiari e dalla risata spensierata, in netto contrasto con il contesto dal quale Andrea proviene. Anche la famiglia di Ena, fratelli, padre e madre, ha lo stesso potere attrattivo su Andrea, in quanto accogliente, gentile e cordiale: non di rado, soprattutto nei primi tempi della loro amicizia, Andrea si ferma a pranzo e a studiare dalla ragazza. L’apparente ingenuità e candore di Ena vengono però spazzati via quando questa conosce Roman, l’affascinante zio musicista di Andrea, con il quale intesse una sempre più stretta relazione. Come conseguenza si allontana progressivamente sia da Jaime, il proprio fidanzato, che da Andrea, la quale soffre a dismisura per la perdita dell’amica, che scompare letteralmente dalla sua vita senza fornire alcuna motivazione. Solamente a fine romanzo Ena svela il proprio segreto, in una delle scene sicuramente più soavi e toccanti dell’intera opera, quando Andrea ed Ena finalmente si incontrano nuovamente ed ha luogo la sua lunga confessione:
Si tú supieras que Román, cuando joven, hizo sufrir a mi madre... (...) Pero no me creas mejor de lo que soy, Andrea... No vayas a buscarme disculpas... No era sólo por esta causa por lo que yo quería humillar a Román... (...) Escucha, Andrea, yo no pdía pensar en Jaime ni en ti ni en nadie esta temporada, yo estaba absorbida enteramente en este duelo entre la frialdad y el dominio de los nervios de Román y mi propia malicia y seguridad... Andrea, el día en que por fin pude reírme de él, el día en que me escapé de sus manos cuando ya creía tenerme segura, fue algo espléndido... (Laforet, 1945:248).
Da questa confessione emerge quindi una donna forte e smaliziata, la quale dapprima per vendicare la propria madre e, in un secondo momento per dimostrare a sé stessa di essere più forte della passione sensuale che la lega a Román, si dimostra in grado di tenergli testa ed, infine, di deriderlo e liberarsene. Nel caso di Ena quindi, ci si trova di fronte ad un altro personaggio femminile forte, in grado di riscattarsi e di far valere le proprie ragioni, di interagire in modo attivo sugli eventi, non più in balia dell’ormai imbiancato mito del Don Juan, dell’uomo seduttore che getta la donna nella dipendenza e nella disperazione.
La protagonista, infine, si rivela un personaggio ricco, interessante, vero ed in evoluzione. Arrivata nella grande città subito dopo la guerra, orfana di genitori, affronta praticamente sola, se non per la compagnia di Ena e di altri suoi nuovi amici conosciuti in ambito universitario, il passaggio dall’adolescenza all’età adulta. Passaggio il quale include la scoperta dell’altro, del diverso, della propri limiti, delle proprie emozioni, della solitudine, del male insito in alcune circostanze, del senso di vuoto che lascia il tempo che scorre. Si tratta di una ragazza estremamente sensibile e che pertanto risente del clima negativo della famiglia materna, ma che allo stesso tempo si lascia rapire dalla profondità e dal fascino della musica di Román, si riempie il cuore e gli occhi della gioia dei momenti passati con Ena e Jaime, respira fino in fondo gli odori e i colori di Barcellona, con la testa sgombra dai pregiudizi che suo malgrado la zia Angustias cerca di inculcarle. Particolarmente suggestive sono le descrizioni delle interminabili camminate di Andrea in giro per le vie di Barcellona, rese ancor più surreali dalla lucidità quasi maniacale portatale dalla fame. Al fine di risparmiare per essere il più possibile indipendente economicamente dalla disprezzata famiglia, infatti, Andrea si auto impone ricorrenti digiuni i quali, oltre che farla dimagrire notevolmente, la indeboliscono fisicamente e rendono il suo pensiero più acuto e osservatore, affamato di immagini e sensazioni, rendendola quasi del tutto simile ad un leggero spettro fluttuante. Andrea assorbe da Barcellona quanto più possibile, si perde fermandosi a sognare ad occhi aperti, a riflettere sull’amarezza portata dalla solitudine, ad osservare ed immaginare le storie nascoste dietro a muri e persone. A testimonianza del suo spirito fortemente osservatore e malinconico si riporta un frammento dell’opera el quale così la narratrice racconta uno dei suoi momenti di solitudine, cullata solamente dal battito del cuore della città, in un momento di sconforto totale di fronte al nulla che si apre innanzi alla propria esistenza:
Me parecía que nada vale correr si sempre ha de irse por el mismo camino, cerrado, de nuestra personalidad. Unos seres nacen para vivir, otros para trabajar, otros para mirar la vida. Yo tenía un pequeño y ruin papel de espectadora. Imposible salirme de él. (Laforet, 1945:208)
L’amarezza di aver perduto un’amica, accompagnata dalla delusione nei confronti di una famiglia allo sfacelo, quasi in putrefazione, la colgono con un’acutezza che la lascia nuda e disarmata, totalmente avvolta da un senso di impotenza e di piccolezza rispetto al mondo. Sicuramente però, nonostante la malinconia dovuta alla solitudine, la protagonista è dotata di un’indole indipendente, testarda e ribelle, ma anche affettuosa e sognatrice. Arrivata nella capitale catalana con la testa piena di progetti, vede sgretolarsi man mano di fronte ai suoi occhi l’idillica immagine del futuro che aveva prospettato per se stessa, ma non per questo rinuncia a darsi da fare studiando per migliorare la propria condizione. Al termine del romanzo, recuperata l’amicizia con Ena ed affrontati ognuna i propri incubi personali, le due amiche andranno insieme a Madrid, con l’intento di dare una nuova svolta positiva alla propria esistenza e a costruire finalmente e totalmente sé stesse.
Conclusione
Nel presente lavoro si è esplorata la realtà femminile spagnola del secolo appena trascorso esaminandone alcuni aspetti, fra cui la storia, le produzioni culturali, le condizioni sociali ed il riconoscimento sociale. Società, quella spagnola, rimasta fortemente patriarcale per secoli, seguendo un modello fortemente promosso e predicato dalla Chiesa quale unica alternativa possibile al decadimento della famiglia e della moralità. Si è scelto questo periodo di tempo poiché lo si considera la fase di passaggio, il cambiamento, la transizione da un modello all’altro, quello attuale, dove ormai si può parlare di totale riconoscimento ed integrazione femminile nella società. In realtà già da fine Ottocento, come si è potuto analizzare, ci sono vari tentativi da parte di poche coraggiose di uscire dall’ombra e dal silenzio delle quattro mura domestiche, tentativi che danno il là, nel secolo successivo, ad una serie di iniziative le quali, seppur duramente frenate dal quarantennio franchista, continuano nell’ombra a dare i loro piccoli frutti. Questo paziente lavoro sotterraneo si traduce infine, una volta allentatasi la rigidità del regime, nella nascita di una delle costituzioni, quella spagnola, dove i diritti della donna, almeno sulla carta, meglio sono tutelati. Il procedimento seguito per la stesura del presente elaborato è stato un parallelismo fra la storia ufficiale di tutto il Novecento spagnolo, presentata nella prima parte e dell’evoluzione dei gruppi e movimenti femminili, completata dal sentiero di conquiste a livello legislativo che li accompagna, per meglio evidenziare la continuità e la costanza di un’opera portata avanti per tutto un secolo nonostante le reticenze culturali, politiche e religiose dell’epoca. Si è infine passati a presentare l’opera di tre celebri scrittori di inizio Novecento che si ritiene rappresentino, fra gli altri, alternative concrete nel modo di rappresentare il femminile, realtà invece omessa od idealizzata dalla maggior parte degli autori loro contemporanei. La scelta dei testi non è casuale: si è infatti voluto evidenziare quello che si considera nella letteratura spagnola il vero e proprio momento di stacco, l’attraversamento di una linea rossa che contribuisce non poco nel dare voce ad un mondo sino ad allora silenzioso e nascosto.
Si vogliono ora trarre alcune conclusioni che emergono dall’analisi sin qui proposta: cultura, famiglia, politica, patrimonio, ma anche rispetto e riconoscimento sono solo alcune tappe di un lungo, lunghissimo viaggio, che forse si sta ancora percorrendo, per arrivare alla totale parità fra i sessi, tutelata sulla carta ma ancora spesso violata, come testimoniano le cronache spagnole contemporanee.
Obiettivo di questa tesi non è quello di esprimere un giudizio o di effettuare una denuncia su quello che è stato il trattamento riservato alle donne. Piuttosto, quello che è veramente importante, è prendere consapevolezza dei passi straordinari che sono stati compiuti in un lasso di tempo relativamente breve,considerando anche la presenza quarantennale di una rigida dittatura promotrice di valori arcaici e patriarcali.
Nell’analisi presentata si è ripercorso un iter che comprende avvenimenti storici, promulgazione di nuove leggi, vicende famigliari e domestiche e si è infine, soffermata l’attenzione sul contributo di autori quali Miguel de Unamuno, Federico García Lorca, Carmen Laforet. Punti di vista diversi, nuovi, a volte provocatori se si considera il contesto nel quale sono inseriti. La donna considerata come un vortice di passione, sentimenti, pensieri e fragilità. Non più quindi un essere umano di serie B, ma una persona a tutto tondo, meritevole di una maggiore considerazione politica, sociale e famigliare.
E’ quindi grazie alla consapevolezza oggettiva degli avvenimenti riportati, che è possibile parlare di una vera e propria rivoluzione del pensiero circa il ruolo della donna nel tessuto sociale, che è nata, si è sviluppata e che si è praticamente conclusa nel secolo appena trascorso. Inoltre, la conoscenza di quello che è stato, la ricerca nel passato degli avvenimenti e la loro evoluzione, ha un altro punto di arrivo, non trascurabile: comprendere meglio il presente per tentare di capire un po’ più a fondo le dinamiche e le consuetudini attuali.
Bibliografia
Borreguero, Concha; Catena, Elena; De la Gándara Consuelo; Salas, María 1986, La mujer española: de la tradición a la modernidad (1960-1980), Madrid, Editorial Tecnos.
Camps, Victoría 1998, El siglo de las Mujeres, Madrid, Ediciones Cátedra.
David, René; Jauffret-Spinosi, Camille 2004, tradotto sulla 11ª edizione (2002), I grandi sistemi giuridici contemporanei, Padova, CEDAM.
Facchi, Alessandra 1999, Il pensiero femminista sul diritto, in Gianfrancesco Zanetti, (a cura di), Filosofi del diritto contemporanei, Milano, R. Cortina, pp. 125-153.
Falcón, Lidia 1974, Mujer y Sociedad _ Análisis de un fenómeno reaccionario, Barcelona, Editorial Fontanella.
Ferrer Navarro, Ana Maria 1982, Feminismo, Familia, Mujer, Pamplona, Eunsa.
Fineman, Martha A., McCluskey, Martha T. 1997, Feminism, Media, and the Law, New York, Oxford, Oxford University Press.
Flecha García, Consuelo 1996, Las primeras universitarias en España, Madrid, Ediciones Narcea.
Fusi, Juan Pablo 1986 Franco, Madrid, Taurus.
García Lorca, Federico (a cura di Bodini, Vittorio) 1952, Teatro, Milano, Giulio Einaudi Editore.
Hermet, Guy 1999, Storia della Spagna nel Novecento, Società editrice Il Mulino.
Laforet, Carmen 1995, Nada, Barcelona, Destino.
Losano, Mario 1988, (1978), I Grandi Sistemi Giuridici. Introduzione ai diritti europei ed extraeuropei, Torino, Giulio Einaudi editore s.p.a.
Martín Gaite, Carmen 1994 (1987), Usos amorosos de la posguerra española, Barcelona, Anagrama.
Moreno, Amparo 1977, Mujeres en Lucha. El movimiento feminista en España, Barcelona, Anagrama.
Pitch, Tamar 2004, I diritti fondamentali: differenze culturali, disuguaglianze sociali, differenza sessuale, Torino G. Giappichelli.
Ruiz Guerrero, Cristina 1997, Panorama de escritoras españolas Vol. II, Cadiz, Publicaciones de la Universidad de Cadiz.
Unamuno, Miguel (de) 1997 (1921), La tía Tula, Madrid, Cátedra.
Zavala, Iris (a cura di), 1996, “La mujer en la literatura española (Del s. XVIII a la actualida)” in Breve historia feminista de la literatura española (en lengua castellana) , Barcelona, Anthropos.
1989, Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana, Madrid, Espansa-Calpe.
2001, Diccionario de la Lengua Española, Vigésima Segunda Edición, Real Academia Española, impreso en Rotapapel.
1991, Gran Enciclopedia de España, Zaragoza.
1988, Gran Enciclopedia Larousse, Barcelona, Editorial Planeta.
Sitografia
Costitución de la Republica Española, 1931, Palacio de las Cortes Constituyentes, Madrid. Consultata presso il sito http://www.constitucion.es/otras_constituciones/espana/1931.html, (la cui fonte è Europa Press)
Código Civil Español, http://civil.udg.es/NORMACIVIL/estatal/CC/INDEXCC.htm.
Lobelos Manuela e Borreguero Yolanda, “De la República al Franquismo” in Historia de la Mujer en España, http://centros5.pntic.mec.es/ies.parque.de.lisboa/alumnos2001/23.htm, 2001, Madrid, Instituto Parque de Lisboa(16/05/07).
López Lorena e Medina Alicia, “Legislación sobre la mujer en la segunda mitad del siglo XIX” in Historia de la Mujer en España, http://centros5.pntic.mec.es/ies.parque.de.lisboa/alumnos2001/, 2001, Madrid, Instituto Parque de Lisboa (16/05/07).
Hernández, Madalena “Nuevo Orden Liberal” in Historia de la Mujer en España, http://centros5.pntic.mec.es/ies.parque.de.lisboa/alumnos2001/, 2001, Madrid, Instituto Parque de Lisboa (16/05/07).
Pérez, Beatriz e Muñoz Rebeca “Revolución y Restauración” in Historia de la Mujer en España, http://centros5.pntic.mec.es/ies.parque.de.lisboa/alumnos2001/, 2001, Madrid, Instituto Parque de Lisboa (16/05/07).
Fascella, Marcello “Politica e lotte femministe durante la Guerra di Spagna (1931-1939)” in Le Donne e la Repubblica www.romacivica.net/anpiroma/antifascismo/Guerraspagna20.htm (15/04/07)
Fundación Isonomía, Universitat Jaume I, “Flecha García, Consuelo” in Currículos de ponentes, II Congreso Estatal Sobre igualdad entre mujeres y hombres de Castellón, 14, 15 y 16 de Septiembre de 2005 http://isonomia.uji.es/mujeres/'cod=1-1&cv=flecha (10/07/07)
Código Civil http://civil.udg.es/NORMACIVIL/estatal/CC/INDEXCC.htm.
Costitución de la Republica Española, 1931, Palacio de las Cortes Constituyentes, Madrid. Consultata presso il sito http://www.constitucion.es/otras_constituciones/espana/1931.html, (la cui fonte è Europa Press)
Fascella, Marcello “Politica e lotte femministe durante la Guerra di Spagna (1931-1939)” in Le Donne e la Repubblica www.romacivica.net/anpiroma/antifascismo/Guerraspagna20.htm (15/04/07)
Lobelos Manuela e Borreguero Yolanda, “De la República al Franquismo” in Historia de la Mujer en España , http://centros5.pntic.mec.es/ies.parque.de.lisboa/alumnos2001/23.htm, 2001, Madrid, Instituto Parque de Lisboa(16/05/07).
Hernández, Madalena “Nuevo Orden Liberal” in Historia de la Mujer en España, http://centros5.pntic.mec.es/ies.parque.de.lisboa/alumnos2001/, 2001, Madrid, Instituto Parque de Lisboa (16/05/07).
López Lorena e Medina Alicia, “Legislación sobre la mujer en la segunda mitad del siglo XIX” in Historia de la Mujer en España, http://centros5.pntic.mec.es/ies.parque.de.lisboa/alumnos2001/, 2001, Madrid, Instituto Parque de Lisboa (16/05/07).
Pérez, Beatriz e Muñoz Rebeca “Revolución y Restauración” in Historia de la Mujer en España,
http://centros5.pntic.mec.es/ies.parque.de.lisboa/alumnos2001/, 2001, Madrid, Instituto Parque de Lisboa (16/05/07).
Fundación Isonomía, Universitat Jaume I, “Flecha García, Consuelo” in Currículos de ponentes, II Congreso Estatal Sobre igualdad entre mujeres y hombres de Castellón, 14, 15 y 16 de Septiembre de 2005 http://isonomia.uji.es/mujeres/'cod=1-1&cv=flecha (10/07/07)
-----------------------
[1] Pronunciamento: Colpo di stato militare, per lo più incruento, il cui successo dipende dall’adesione delle altre guarnigioni dell’esercito (Hermet 1999: 309).
[2] Antonio Cánovas del Castillo, ex ministro monarchico, uomo chiave dell’epoca della Restaurazione, periodo precedente la dittatura di Primo de Rivera (Hermet 1999: 50).
[3] Cacicchismo: sistema politico illegale instauratosi in Spagna fra il XIV secolo e gli inizi del XX a causa del quale la democrazia parlamentare rimane falsata nei suoi risultati a seguito di manipolazioni elettorali esercitate da persone influenti nell’ambiente politico, amministrativo e sociale di una determinata località, i quali potevano contare su di una clientela che permetteva loro il controllo dei processi elettorali (Gran Enciclopedia de España 1991: 1870).
[4] Caudillo (dal latín: capitellus, piccola testa). Titolo dato al generale Franco sul modello di quello di Duce per Mussolini o di Fürer per Hitler. Tale appellativo designava originariamente i capi delle bande cristiane durante la riconquista contro gli arabi (Fusi 1999: 304).
[5] Carmen Martín Gaite (1925-200) è una delle scrittrici più rappresentative della letteratura spagnola in casigliano. Molto sensibile alle tematiche femminili, con il suo Usos amorosos de la postguerra española vince il 30 marzo 1987 il prestigioso premio Anagramma de Ensajo. Come ricorda l’autrice stessa quando finisce la guerra ha 13 anni e trascorre i 10 anni successivi, quelli della formazione e della crescita personale, subendo i forti condizionamenti ideologici della propaganda del regime (Gaite 1994:12).
[6] Guerra Fredda: a partire dal 1945, dopo la Seconda guerra mondiale, vengono a crearsi due nuovi blocchi di influenza politica ed economica a livello planetario: l’Unione Sovietica e gli Stati Uniti d’America. Ideologicamente tali superpotenze sono agli antipodi, promuovendo rispettivamente il comunismo da una parte ed il liberalismo dall’altra. La definizione nasce dal fatto che, sebbene entrambi i blocchi abbiano un’ampia sfera di influenza su diversi paesi, non si arriverà mai ad un conflitto armato vero e proprio, bensì solo alla cosiddetta “corsa agli armamenti”, durante la quale i paesi coinvolti investono ingenti somme in armi e nella ricerca scientifica militare.
[7] Nella presentazione del lavoro è contenuta la seguente descrizione, in riferimento all’attendibilità della fonte: «Esta web ha sido realizada por los alumnos de 2º de Bachillerato del IES Parque de Lisboa durante el curso académico 2000-2001. Se ha llevado a cabo como una actividad de la asignatura de Historia de España (profesor: Juan Carlos Ocaña), en el marco del Proyecto Educativo Europeo "Hombres y Mujeres en la Sociedad Europea Actúal" en la que participa nuestro centro». (http://centros5.pntic.mec.es/ies.parque.de.lisboa/alumnos2001/).
[8] Liberalismo: Dottrina politica che si propone di limitare i poteri dello Stato rispetto alle libertà individuali. Durante il XIX secolo il liberalismo si consolida nella maggior parte dell’Europa occidentale, andando ad integrare l’ideologia della nuova società formatasi sotto la guida della borghesia industriale. (Enciclopedia Larousse 1988: 6525) .
[9] Consuelo Flecha García è Dottoressa in Scienze dell’Educazione e docente all’Università di Siviglia e le sue ricerche si focalizzano sulle seguenti tematiche: storia dell’educazione femminile, genere ed educazione d presenza professionale delle donne negli studi superiori. (http://isonomia.uji.es/mujeres/'cod=1-1&cv=flecha)
[10] Artículo 25, Título III, Derechos y deberes de los españoles: “No podrán ser fundamentos de privilegio jurídico: la naturaleza, la filiación, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas ni las creencias religiosas.”
[11] Artículo 36, Título III, Derechos y deberes de los españoles: “Los ciudadanos de uno y otro sexo, mayores de veintitrés años, tendrán los mismos derechos electorales coforme determinen las leyes”
[12] Artículo 40, Título III, Derechos y deberes de los españoles: “Todos los españoles, sin distinctión de sexo, son admisibles a los empleos y cargos públicos según su merito y su capacidad, salvo las incompatibilidades que las leyes señalen.”
[13] Artículo 43, Título III, Derechos y deberes de los españoles: “El matrimonio se funda en la igualdadde derchos para ambos sexos, y podrá disolverse por mutuo disenso o a petición de cualquiera de los cónyuges, con alegación en este caso de justa causa.
[14] Artículo 43, Título III, Derechos y deberes de los españoles: “El estado prestara asistencia a los enfermos y ancianos, protección a la maternidad y a la infancia, haciendo suya la “Declaración de Ginebra” o tabla de los derechos del niño”
[15] Artículo 53, Título VI, Las Cortes: “Serán elegibles para Diputados todos los ciudadanos de la República mayores de veintitrés años, sin distinción de sexo ni de estado civil, que reúnan las condiciones fijadas por la ley Electoral”.
[16] Repubblica di Weimar: Il periodo della Storia della Germania che va dal 1919 al 1933 è conosciuto come la Repubblica di Weimar. Prende il nome dalla città di Weimar, dove un'assemblea nazionale si riunisce per stendere una nuova Costituzione, dopo la sconfitta tedesca della prima guerra mondiale.
[17] Durante il franchismo non vi è una vera e propria Costituzione. Essa è sostituita dalle 7 Leyes Fundamentales che regolano il comportamento dei cittadini nei vari ambiti della vita pubblica e privata. Nel dettaglio, tali leggi sono el Fuero del Trabajo del 9 Marzo 1938, la Ley Costitutiva de las Cortes del 17 Luglio 1942, la Ley de Referndum del 22 Ottobre 1945, la Ley de sucesión e la Jefatura del Estado del 26 Luglio 1946, la Ley de Principios del Movimiento Nacional del 17 Maggio 1958 e la Ley Organica del Estado, del 1 Gennaio 1967.
[18] L'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia della Provincia di Roma è un ente morale riconosciuto dallo Stato (Decreto Luogotenenziale del 5/4/1945, n. 224), che associa i partigiani e coloro che hanno partecipato a vario titolo alla guerra di liberazione (militari, deportati, IMI) e che, per statuto, svolge un'attività di valorizzazione e di informazione sull'apporto dato dai partigiani e dalla Resistenza alla libertà, alla democrazia e al nuovo ordinamento costituzionale) (http://www.romacivica.net/ANPIROMA/anpi/anpi.htm).
[19] Émile Zola (1840-1902): intellettuale francese promotore del filone letterario del Naturalismo.