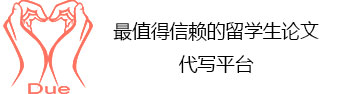服务承诺
 资金托管
资金托管
 原创保证
原创保证
 实力保障
实力保障
 24小时客服
24小时客服
 使命必达
使命必达
51Due提供Essay,Paper,Report,Assignment等学科作业的代写与辅导,同时涵盖Personal Statement,转学申请等留学文书代写。
 51Due将让你达成学业目标
51Due将让你达成学业目标 51Due将让你达成学业目标
51Due将让你达成学业目标 51Due将让你达成学业目标
51Due将让你达成学业目标 51Due将让你达成学业目标
51Due将让你达成学业目标私人订制你的未来职场 世界名企,高端行业岗位等 在新的起点上实现更高水平的发展
 积累工作经验
积累工作经验 多元化文化交流
多元化文化交流 专业实操技能
专业实操技能 建立人际资源圈
建立人际资源圈Il_Rilancio_Economico_Delle_Zone_Costiere
2013-11-13 来源: 类别: 更多范文
“Il rilancio economico delle zone costiere”
Solo dagli anni ottanta si è diffusa una maggiore consapevolezza internazionale dei problemi riguardanti le zone costiere, in quanto aree “sensibili”, in cui si concentrano attività spesso tra loro conflittuali ed in cui si registra un’eccessiva densità demografica. Turismo, acquacoltura, pesca, diporto nautico e porti turistici, trasporti marittimi e intermodali e connesse infrastrutture, sfruttamento di giacimenti petroliferi e minerari, proprietà pubblica e privata rientrano tra quei molteplici usi il cui sviluppo “irresponsabile” mina fortemente lo sviluppo sostenibile dell’ambiente costiero. Pur esistendo, ovviamente, una molteplice varietà di zone costiere diversamente caratterizzate, per esempio, dalla geografia del paese, dall’orientamento della costa, dal valore economico delle risorse costiere, dalla concentrazione della popolazione e delle infrastrutture e dal livello di sviluppo del paese, esse vanno comunque intese come sistemi interattivi mare-terra, dinamici e fragili, da tutelare attraverso l’elaborazione di più complete e approfondite tecniche di pianificazione e gestione in grado di affrontare, in modo complessivo ed integrato, i problemi dell’articolazione delle competenze istituzionali, delle possibili fonti di impatto sul territorio costiero e degli interventi necessari. La materia della pianificazione territoriale delle zone costiere è caratterizzata, ancora in molti paesi, da una sovrapposizione di norme giuridiche nazionali, con competenze frammentate e carenze di orientamento dovute al perseguimento di obiettivi tra loro contraddittori. La mancata elaborazione di una gestione integrata delle zone costiere, a causa dei vincoli ordinamentali di ciascun paese, si ravvisa anche nel nostro ordinamento. Infatti, nonostante la ormai nota crisi della rigida categoria del demanio marittimo, non si è ancora pervenuti ad un effettivo “assorbimento” giuridico del concetto di gestione integrata delle zone costiere ed, a monte, all’individuazione normativa di una nozione elastica zona costiera. Gli strumenti internazionali di soft law susseguitesi negli anni e volti ad indirizzare i singoli Stati ad adottare normative interne in grado di assicurare una gestione integrata delle aree costiere, attraverso l’individuazione approfondita dei principi, degli obiettivi e di modalità procedurali, non si sono rivelati sufficienti a promuovere l’implementazione di questo nuovo e diverso metodo di gestione. Da qui è emersa, di recente, nell’ambito del sistema di Barcellona, l’esigenza di adottare un nuovo strumento normativo regionale appositamente dedicato alla gestione integrata delle aree costiere e, soprattutto, di carattere vincolante essendosi dimostrata utopistica, negli anni, l’adozione volontaria da parte dei singoli Stati degli orientamenti e delle raccomandazioni in materia. La scelta di riconoscere una profondità territoriale ai paesaggi costieri muove non solo da considerazioni di tutela, ma anche da valutazioni economiche: la volontà da più parti espressa di ampliare e destagionalizzare l’attuale offerta turistica regionale attraverso l’integrazione del prevalente turismo balneare con gli altri segmenti turistici regionali implica infatti necessariamente la costruzione di strategie virtuose tra costa ed entroterra, che mobilitino risorse ben più ampie di quelle ricadenti a ridosso del litorale. Il progetto territoriale regionale per la valorizzazione e la riqualificazione integrata dei paesaggi costieri della Sicilia si sviluppa in coerenza con la strategia europea per la gestione integrata delle zone costiere e con lo Schema di Sviluppo Spaziale Europeo, che hanno evidenziato come le aree costiere, proprio perché caratterizzate da elevata fragilità ambientale e diversità ecologica, e nel contempo da un alto livello di pressione antropica, necessitano di strategie integrate di sviluppo spaziale, capaci di bilanciare tutela attiva e valorizzazione dei territori e non senza il coinvolgimento delle comunità insediate. Il PPTR sviluppa per i paesaggi costieri della Sicilia un progetto multisettoriale ed integrato che punta a mettere a sistema e a far lavorare coerentemente gli altri progetti territoriali su territori di particolare complessità come quelli costieri, perseguendo contemporaneamente obiettivi di valorizzazione e riqualificazione del paesaggio costiero. Il progetto territoriale regionale per la valorizzazione e la riqualificazione integrata dei paesaggi costieri si compone di due ambiti tematici, all’interno dei quali vengono indicati i progetti che il PPTR propone di sviluppare, inserendoli negli indirizzi e nelle direttive della disciplina del Piano: Il sistema infrastrutturale, in cui il progetto sui paesaggi costieri lavora sinergicamente con il progetto infrastrutturale integrato per la mobilità dolce al fine di raggiungere l’obiettivo della creazione di un sistema di trasporto pubblico regionale intermodale, atto a servire le città storiche e gli insediamenti turistici costieri, facilitando lo spostamento tanto lungo la costa quanto tra costa ed entroterra; Il sistema urbano, in cui la specificità delle forme di urbanizzazione che dal dopoguerra si sono manifestate lungo i litorali hanno comportato un affinamento della lettura delle fenomenologie insediative costiere che ha condotto all’individuazione di specifici strumenti progettuali finalizzati a salvaguardare i caratteri strutturali dei territori costieri storici, migliorare la qualità della città costiera contemporanea, incrementare la qualità dell’offerta turistico-ricettiva regionale, delocalizzare i detrattori costieri incompatibili con il progetto di rete ecologica regionale e con le politiche di sviluppo turistico regionale. Le città stanno, infatti, vivendo con il mare una nuova era: quella del waterfront. L'esame delle opere realizzate negli ultimi decenni permette di evidenziare programmi, progetti, circuiti finanziari e iter procedurali che spesso presentano punti comuni sia nelle soluzioni positive che in quelle negative. Tra le difficoltà riscontrabili, anche in alcuni famose zone costiere, spesso emergono carenze sia di governabilità sia "di massa critica" idonea ad innescare uno sviluppo autopropulsivo. Il waterfront, inteso come ristrutturazione del porto cittadino e della fascia urbana immediatamente retrostante, si dimostra sempre meno idoneo a cogliere le sinergie che potrebbero scaturire da un intervento più vasto di un singolo ambito amministrativo. Parallelamente, la frammentazione del potere decisionale tra enti vari genera conflitti di prossimità e di competenze che frenano la realizzazione delle opere e ne rendono difficile la gestione.
Il waterfront, diviene uno strumento di politica economica molto efficace nel contribuire a superare, anche, profonde crisi recessive e promuovere uno sviluppo sostenibile. Nel waterfront di Catania, come in quello di tante altre città, convivono opere realizzate, opere da realizzare, scenari e percorsi strategici ancora tutti da scegliere. In particolar modo la posizione geografica privilegiata del porto di Catania ha un forte impatto sul territorio regionale, in quanto occorre prendere in considerazione che il porto etneo serve un bacino terrestre rappresentato da sei province siciliane su nove, ed una popolazione complessiva di tre milioni di abitanti. Ma la peculiarità di cui gode il porto etneo è soprattutto riscontrabile nella polivalenza delle attività, che possono essere messe in atto. L’ambito crocieristico, ad esempio è quello che ha avuto negli ultimi anni il maggiore incremento di produttività. Di recente, la rivalutazione delle risorse culturali e paesaggistiche dell’intera provincia etnea, confortata da intense campagne promozionali del prodotto Catania, ha dimostrato capacità attrattiva di una zona capace di concentrare in pochi chilometri un patrimonio di inestimabili bellezze culturali e paesaggistiche come la stessa Catania, Taormina, Piazza Armerina, Siracusa e l’Etna. E’ per questo motivo che il settore crocieristico ha saputo registrare un significativo aumento di passeggeri, 93.000 nell’anno 2006. Anche il commercio, ha fatto registrare un notevole sviluppo grazie alle attrezzature specializzate nel settore dei containers, uniche nella Sicilia orientale, ed ai nuovi collegamenti con i grandi porti hub di transhipment di Gioia Tauro e Malta. Anche nel settore dei traghetti roll–on e roll-off si è avuto un ottimo incremento, tanto che ad oggi il porto di Catania è considerato tra gli scali cabotieri più importanti del Sud Italia. Le maggiori linee di collegamento si hanno con gli scali di Napoli, Genova, Livorno, Ravenna e Venezia. Il trend positivo di crescita che ormai accompagna da diversi anni il traffico del settore commerciale del porto di Catania è frutto di un’attenta pianificazione e dell’utilizzo di attrezzature specializzate negli specifici settori merceologici, che hanno consentito allo scalo etneo di operare con costi competitivi ad alta produttività. Inoltre la realizzazione del porto turistico inserirà l’approdo etneo in un circuito mediterraneo competitivo. La posizione geografica di Catania e del suo porto, la sua collocazione lungo le possibile rotte mediterranee, la vicinanza strategica dell’aeroporto, all’interporto e al centro agroalimentare (entrambi in fase di realizzazione) e il facile inserimento nella rete viaria e ferroviaria territoriale, nonché la possibilità di utilizzare la barca otto mesi l’anno, sono certamente i punti di forza dello scalo marittimo etneo. Un insediamento altamente tecnologico è quello della Elettra Tlc, che ha installato nel porto di Catania l’unico deposito di cavi sottomarini per telecomunicazioni esistente in tutta Italia garantendo l’approdo di due navi specializzate oltre che della Teliri, una delle navi posacavi più moderne del mondo. L’amministrazione comunale di Catania ha affiancato e sostenuto l’Autorità portuale nella politica di programmazione, promozione e ristrutturazione delle funzioni e delle attività del porto. In quest’ottica il metodo adottato è stato quello di ricercare, privilegiare ed incentivare gli investimenti privati. La città si è giustamente riappropriata del suo porto per farlo divenire oltre che motore di attività economiche, anche uno “spazio” da vivere. Per quanto riguarda la struttura, il porto Catania di I classe è costituito da un bacino artificiale limitato a est dal Molo di Levante ed a sud dal Molo di Mezzogiorno. Nel Porto Nuovo distinguiamo il pennello di levante con a sud il Molo Foraneo ed il pennello di ponente, l’ingresso è costituito da un’apertura di 200 metri. Il Porto Vecchio è adibito al traffico dei motopescherecci. Una banchina è destinata alla pesca, illuminata da lampioni pubblici. I due porti sono separati all’interno dallo Sporgente Centrale. Nonostante gli sforzi messi in atto dall’amministrazione comunale per rendere più funzionale e all’avanguardia il proprio scalo, il porto di Catania, tuttavia, è soggetto ancora oggi a gravi carenze dal punto di vista strutturale e non, ed in particolar modo il settore che riscontra i maggiori problemi è quello turistico. Le risorse e le potenzialità di cui dispone l’intera provincia di Catania non vengono sfruttate per la generazione di imponenti flussi turistici capaci di rilanciare l’economia locale, a causa della mancanza di attrattive ed eventi di rilievo e della concorrenza di altre località nel Mediterraneo più attrezzate ad ospitare e ad accogliere imponenti flussi turistici. Inoltre il porto a causa delle sue ridotte dimensioni rispetto ai principali porti del Mediterraneo non è in grado di realizzare intensi flussi commerciali, nonostante la posizione ideale di cui dispone. Per ottenere un’analisi più corretta inoltre occorre evidenziare il contesto entro cui il porto di Catania si inserisce ed in particolar modo è utile tener presente l’importanza che oggigiorno gioca il mar Mediterraneo per lo scalo etneo. Il ruolo globale del Mediterraneo è strettamente legato al Canale di Suez, che per quel che riguarda le rotte tra l’Asia e l’Europa, rispetto al percorso del Capo di Buona Speranza consente significative riduzioni dei percorsi (tra Tokyo e Rotterdam del 23%). Attraverso il Canale negli anni 2005-2006 sono transitate in media 18000 navi all’anno (oltre il 22% delle quali petroliere e il 45% containership) e circa il 7% del traffico marittimo mondiale, conferendo ai porti mediterranei che assorbono attualmente circa il 25% del traffico container del vecchio continente, un ruolo strategico per l’Europa. La chiave di volta dell’esplosione del traffico container è la tecnica del transhipment e il federaggio (con il quale i container in arrivo con navi di grande tonnellaggio vengono smistati in tutto il Mediterraneo con navi minori, le cellular ship), che hanno consentito anche ai porti medio piccoli di inserirsi nel circuito dei grandi traffici internazionali, in modo da servire anche mercati e destinazioni a domanda debole, che altrimenti sarebbero stati emarginati dai grandi flussi di traffico intercontinentali. Nel transhipment operano nuovi porti mediterranei che hanno affiancato i tradizionali hinterland oriented port (Barcellona, Valencia, Marsiglia-Fos, Genova-Voltri, La Spezia, Livorno, Napoli, Salerno, Ravenna, Venezia, Trieste, Capodistria, Fiume, il Pireo) i quali a loro volta, hanno realizzato nuovi terminal containers. I dieci maggiori porti hub di transhipment del Mediterraneo, sono attualmente: Algeciras, sulla porta occidentale del Mediterraneo; Gioia Tauro, Malta Marsaxlokk e Cagliari al centro del Mediterraneo occidentale; Taranto al centro dello Jonio; il Pireo e Izmir sulla soglia del Mar Nero; Limassol, Damietta e Porto Said nel bacino orientale del Mediterraneo. La leadership di questi porti è stata acquisita da Gioia Tauro (circa 3.261.000 teu nel 2004 e 3.161.000 nel 2005), in cui opera la Medcenter Container Terminal S.p.a (a cui concorrono due colossi globali come la Contship/Eurogate e Maersk Sealand). Ma anche negli altri hub si sono insediati leader mondiali del trasporto (Algeciras, SeaLand Maersk; Marsaxlokk, Grand Alliance; Taranto, Evergreen; Cagliari, P&O). I porti di transhipment sono entrati infatti nelle strategie di sviluppo dei vettori globali del trasporto container e della gestione dei terminali. Un fenomeno che modifica i termini della competizione tra il Northern Range (il fronte marittimo che va dal porto di Le Havre a quelli di Anversa, Rotterdam, Brema e Amburgo) e il Southern Range mediterraneo, per una competizione tra “sistemi a rete” che comprende porti di diverso Range. Inoltre anche nel Mediterraneo, come si è già verificato da qualche tempo nel Nord Europa, si moltiplicano gli investimenti per dar vita a inland terminal (interporti) e a piattaforme logistiche plurimodali che permettono di integrare i porti nei sistemi intermodali nazionali e internazionali. I problemi principali degli scali europei del Mediterraneo sono infatti: 1) Operare, come avviene per i porti del nord Europa, nell’ambito di sistemi logistici, al fine di divenire terminali marittimi dei TEN-T (Transeuropean Transport Networks) e dei PEC (Pan-European Corridors); 2) Dar vita a port cluster che rendano intercomunicanti le reti di Transhipment e le Autostrade del mare. Per quanto riguarda, la rete di transhipment dei porti italiani i tre hub di Gioia Tauro, Taranto e Cagliari hanno una posizione ottimale rispetto alle rotte Suez-Gibilterra e concentrano circa il 50% delle capacità di trasbordo del Mediterraneo. Ad essi dovrebbe aggiungersi nei prossimi anni Augusta, che ha in fase di realizzazione un nuovo terminal container. Purtroppo però dai dati più recenti, in contrasto con altre tipologie di traffico, come roll-on/roll-off e ro/pax, emergono segni di debolezza della nostra portualità per quel che riguarda il traffico container, con un arretramento sia rispetto ad altri scali mediterranei, in particolare quelli spagnoli, sia nei confronti dei porti del nord Europa, in forte rilancio. Le cause sono da attribuire: 1) Alla crisi delle attività produttive che determina una riduzione dell’interscambio commerciale; 2) Alla dispersione degli interventi su quattordici porti italiani sede di Autorità portuale, la metà dei quali nel Mezzogiorno (Bari, Cagliari, Catania, Gioia Tauro, Napoli, Salerno, Palermo, Taranto); 3) Alla forte concorrenza che subiscono gli hub di transhipment italiani; 4) Alla ripresa del ritmo di crescita dei porti del Northern Range, che grazie ai sistemi di trasporto integrati rafforzano la loro funzione di porte di accesso al mercato interno europeo, a danno di quelli meridionali, che rimangono legati al transhipment (hub e feeder) lontani dalle reti trans-europee di trasporto; 5) Ai ritmi troppo lenti nell’adeguamento delle infrastrutture e soprattutto alle difficoltà dei porti italiani ad integrarsi in sistemi logistici; 6) Alla marginalizzazione dei porti siciliani e di quelli pugliesi di Bari e Brindisi nell’ambito dei grandi traffici container provenienti da Suez. Grande impulso ha registrato negli ultimi anni anche lo Short sea shipping, vale a dire il cabotaggio marittimo nazionale e internazionale, che assume un ruolo strategico in relazione alla configurazione del Mediterraneo e che ha raggiunto livelli elevatissimi di crescita, grazie soprattutto allo sviluppo delle Autostrade del mare, comprendenti il roll-on/roll-off (ro-ro) e il ro/pax, che stanno ricevendo consistenti incentivazioni nazionali e dell’Unione Europea. Una crescita che riguarda soprattutto i porti di Italia, Spagna e Grecia, paesi ai quali queste forme di trasporto, destinate a divenire parte integrante di una catena logistica door to door, offrono interessanti alternative alla modalità stradale. Inoltre qualche perplessità per il futuro dei traffici Mediterranei, più che dal rilancio temporaneo dei porti del Northern Range, nasce dalle nuove iniziative internazionali che stanno convergendo su porti come Tangeri (Marocco), per creare nuovi hub di transhipment, per l’attracco di navi fino a 8000 teu che seguono la via del Capo di Buona Speranza. In tal caso l’ingresso in Europa avverrebbe con flotte feeder sia a sud (per il Mediterraneo e l’Africa settentrionale) che a Nord (per l’Europa centrale e settentrionale). Nonostante tutto, le previsioni sull’evoluzione dei traffici mediterranei restano positive, considerati gli sforzi in atto per l’approfondimento del Canale di Suez e le aspettative di un aumento, nei prossimi cinque anni, di oltre il 50% dei servizi pendulum, sostenuti soprattutto da un consistente aumento dei traffici con la Cina e dall’India e dallo sviluppo delle Autostrade del Mare. Altri elementi positivi riguardano: Lo spostamento del baricentro europeo verso Sud, con la creazione a partire dal 2010 di una zona di libero scambio euro-mediterranea, nell’ambito del Partenariato Euro-Mediterraneo, per il raggiungimento degli obiettivi della Dichiarazione di Barcellona firmata nel 1995 da 27 Paesi; L’adozione dell’ecobonus per lo sviluppo delle Autostrade del Mare (un viaggio stradale su una tratta media nazionale italiana costa circa 300 euro in più rispetto alla via marittima che, tra l’altro, fa risparmiare il 40% sui costi ambientali ed evita la congestione delle reti stradali). In conclusione occorre evidenziare le alternative di posizionamento nel business portuale in cui il porto, sempre più, deve essere concepito come un reticolo di attività economiche ad elevato grado di complessità, strettamente interconnesse con il sistema produttivo e con la organizzazione logistica del trasporto terrestre. Nell’evoluzione delle logiche strategiche di una organizzazione economica globale, i porti si propongono di essere centri di servizi e non punti di transito della merce, con l’obiettivo di catturare il valore aggiunto della logistica che è strettamente collegata alle attività di carico e scarico della merce. Questa nuova logica competitiva è possibile, e può essere vincente, solo se si riesce a costruire un modello operativo di sistema, capace di inserire il recinto portuale nel tessuto economico complessivo, su scala nazionale ed internazionale. In Italia, tuttavia, prevale ancora una logica di localismo esasperato, che induce a demoltiplicare i punti di approdo strategici indebolendo il sistema portuale nazionale nella sua interezza. Altrove, si perseguono invece disegni strategici coerenti, capaci di specializzare i sistemi portuali in funzione delle condizioni strutturali, delle opportunità di mercato, dei benefici economici per il tessuto produttivo nel suo insieme. Il profilo competitivo dei porti è quindi determinato, oltre che dai servizi offerti e dai soggetti attivi, dal livello di specializzazione, dall’integrazione con il territorio circostante e dalle prospettive di sviluppo. Le principali opzioni di posizionamento possono essere rappresentate in quattro classificazioni, che esprimono un diverso ruolo che la struttura portuale gioca nei confronti dell’area economica circostante: 1) il porto-città, in cui il porto è un centro di commerci e di attività industriali su scala ridotta; i trasporti marittimi consistono prevalentemente di merci non containerizzate e questo determina attività di carico e scarico di carattere labour intensive; la città che ospita le diverse attività portuali ne costituisce anche il mercato principale; i compiti del gestore del porto si limitano alla fornitura dei servizi nautici; 2) il porto-area, in cui il porto funziona come un complesso industriale; il trasporto intercontinentale di materie prime alimenta una vasta serie di industrie attraverso banchine ad utilizzo esclusivo collocate nel porto o in aree limitrofe; il porto offre servizi sempre più capital intensive e la gestione è focalizzata sullo sviluppo di nuove infrastrutture; 3) il porto-regione, dove il porto, in questo caso, opera essenzialmente nel trasporto intercontinentale di container e richiede servizi nei settori del magazzino e della logistica che vengono attivati in aree a basso costo esterne al porto; in un ambiente ad alto tasso di competizione tra i porti limitrofi e tra le attività interne al porto regione; il gestore, in questa configurazione, assegna un ruolo prevalente alle funzioni di marketing; 4) il porto-network, in cui il porto funziona come centro di controllo logistico; gli svantaggi strutturali del porto, quali la congestione e l’elevato costo del lavoro, conducono a delocalizzare le attività distributive a favore di altre locations ottenendo così un’estensione del livello di copertura territoriale; il gestore del porto svolge il nuovo compito di coordinare il networking. Fare sistema è il presupposto determinante per operare nell’ambiente competitivo del nostro tempo, se si vuole avere l’ambizione di catturare quote crescenti di traffico in uno scenario internazionale che continuamente valuta opzioni alternative di posizionamento. Scegliere la vocazione portuale, ed il posizionamento coerente con le effettive opportunità che possono essere colte, è parte integrante di un disegno che voglia essere davvero efficace. Spesso invece si cerca di perseguire disegni incoerenti e contrastanti, simultaneamente attivando tutte le opzioni potenzialmente sul terreno, con il solo effetto di vanificare gli sforzi inseguendo tutte le direzioni senza cogliere poi davvero nel segno.
A cura di
Giovanni Strazzulla
matricola 633/005400
Facoltà di Economia
Università di Catania